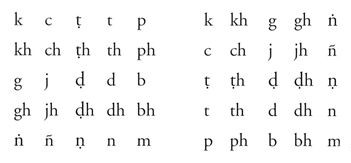Scienza indiana. La scienza nella cultura indiana
Scienza indiana. La scienza nella cultura indiana
La scienza nella cultura indiana
Il concetto di scienza e la classificazione delle scienze
Per designare le conoscenze sistematiche indiane si ricorre abitualmente al termine 'scienza', ma questa parola non denota forse un concetto tipicamente europeo o euro-americano? Non è facile rispondere a questa domanda retorica, dal momento che il termine non indica un singolo concetto ben definito. Esistono alcune differenze tra i modi d'uso di tale termine nell'inglese moderno ‒ sia americano sia britannico ‒ e nelle altre lingue europee, che possono rivelarsi fuorvianti. L'inglese science designa soprattutto le scienze fisiche e della vita, includendo, tuttavia, anche la matematica, che peraltro non tratta né di oggetti fisici né di organismi viventi. Il francese science, l'italiano scienza, il tedesco Wissenschaft, l'olandese wetenschap, il giapponese gaku e il russo nauka possono essere usati in riferimento alle discipline che studiano i diversi aspetti dell'uomo, della società, della Natura, così come a molte altre. L'inglese tende a confondere tra loro le scienze umane, le discipline classiche, la letteratura e persino le arti. In tedesco e in olandese si ricorre alla parola composta Geisteswissenschaften ('scienze dello spirito'), anche se non tutti concordano sul significato del termine Geist ('spirito') o saprebbero dire con esattezza a che cosa esso si riferisce, mentre in francese per designare tali discipline si usa l'espressione sciences humaines, che in tedesco e olandese indica l'antropologia, laddove in francese è una science sociale.
Queste ambiguità terminologiche non derivano da semplici discordanze; esse rivelano profonde confusioni che riflettono non soltanto la rapida espansione della conoscenza, ma tradizioni, stili di pensiero e retroterra culturali diversi. Nel corso del Medioevo europeo la classificazione delle 'sette arti liberali' includeva il trivium costituito da grammatica, retorica e logica e il quadrivium che comprendeva l'aritmetica, la geometria, l'astronomia e la musica. A partire dal XII sec., queste scienze furono aggiornate grazie alle traduzioni dall'arabo, dall'ebraico e dal siriaco e anche grazie alla conoscenza delle traduzioni greche e asiatiche di opere relative alla fisica e ad altre discipline che ben presto furono riunite sotto la denominazione di 'filosofia della Natura'. Soltanto dopo Newton e Leibniz, che ancora si consideravano 'filosofi della Natura', iniziarono a svilupparsi i diversi concetti moderni di 'scienza'.
Non possiamo aspettarci di ritrovare nel pensiero indiano un modello analogo a quello europeo rispetto al quale, del resto, anche gli stessi Europei e Americani hanno posizioni piuttosto discordi; non è il caso, quindi, di far precedere la nostra analisi dalla formulazione di rigide distinzioni. Attribuiremo, invece, al termine 'scienza' un'estensione che include tutte le forme di conoscenza sistematica di noi stessi e dell'Universo in cui viviamo; soltanto adottando questo criterio e applicandolo in modo flessibile sarà possibile prendere in esame le scienze indiane.
Una delle più importanti differenze tra le classificazioni e i concetti indiani e moderni è che in India non fu operata in via di principio alcuna distinzione tra le scienze 'umane' e quelle 'naturali', distinzione formulata da alcuni pensatori tedeschi del XIX sec., tra i quali Wilhelm Dilthey (Staal 1989a). In India, l'assenza di questo genere di distinzione è evidente sin dalle più antiche classificazioni conosciute delle scienze, che risalgono al tardo periodo vedico e distinguono sei scienze ausiliarie o 'membra' dei Veda (vedāṅga), il kalpa ('regola') seguito da quattro discipline che riguardano il linguaggio, la śikṣā ('fonetica e pronuncia'), il nirukta ('etimologia'), il vyākaraṇa ('grammatica') e il chandas ('metrica'); infine, il jyotiṣa ('astronomia'; queste scienze saranno prese in esame in modo sistematico nei successivi capp. VIII e XI; nel cap. III David Pingree, basandosi su altre fonti e aggiunte più tarde, descrive un elenco di quattordici materie 'vediche', tra cui la 'medicina', il 'tiro con l'arco', la 'musica' e la 'scienza del governo', citandone inoltre gli equivalenti sanscriti).
A partire dall'inizio del I millennio d.C., per designare la maggior parte delle scienze o discipline prese in esame in questa Sezione, s'iniziò a usare il termine śāstra, che indicava in primo luogo la scienza del linguaggio o linguistica, definita śāstrāṇām śāstram 'la (prima) scienza tra le scienze' (descritta da George Cardona nel cap. VIII). Definizione indubbiamente appropriata, anche se questo genere di analisi non rientra nella definizione di 'scienza' fornita dai vocabolari inglesi moderni ed è menzionata soltanto en passant da Pingree. D'altra parte, nessuna delle classificazioni indiane può essere considerata esauriente; esse, inoltre, non conservarono lo stesso status con il passare dei secoli (come del resto le loro equivalenti europee e americane); per esempio, talvolta la matematica era combinata con l'astronomia e l'astrologia:
In India non è mai esistita una jāti ('classe') di matematici e soltanto molto raramente si segnala quella che potrebbe essere definita una scuola; la maggior parte dei matematici erano jyotiṣi ('astronomi' o 'astrologi'). La letteratura matematica quindi si presenta in forma di capitoli di siddhānta astronomici o di trattati redatti, con rare eccezioni, da studiosi dediti anche alla composizione di testi astronomici. (Pingree 1981, p. 56)
Molti 'filosofi della Natura' europei erano anche astronomi, matematici, filosofi, alchimisti, astrologi e artigiani di vario genere e interessati in modo non professionale ad altri argomenti; d'altronde i profili delle scienze asiatiche non sono chiari, non possiamo quindi accertare la misura della loro corrispondenza con le scienze europee (dai confini altrettanto indefiniti). La stessa osservazione potrebbe essere applicata alle altre scienze asiatiche, in particolare a quella cinese:
Molti dei più familiari sviluppi della scienza moderna non sono riscontrabili nel modello cinese della conoscenza. Ci sembra conveniente e utile pensare in termini di 'biologia cinese' e di 'astronomia cinese', ma spesso tendiamo a dimenticare che in Cina la prima non è mai esistita, e che la struttura della seconda e il suo ruolo nella storia intellettuale presentano ben pochi punti di contatto con i corrispondenti modelli occidentali. (Sivin 1968, pp. 66-67)
Più avanti, in questo stesso capitolo d'introduzione, prenderemo in esame le connessioni con la 'storia intellettuale' e con altri contesti e scenari più vasti; seguiteremo, inoltre, a riferirci di tanto in tanto alla Cina, dal momento che disponiamo di un valido modello per lo studio della scienza asiatica, la monumentale Scienza e civiltà in Cina redatta da Joseph Needham e dai suoi collaboratori. Può essere interessante ricordare che tra gli Europei e gli Americani è diffuso un significativo fraintendimento circa le differenze esistenti tra l'India e la Cina. Poiché gli Europei scoprirono la Cina nell'età dell'Illuminismo e l'India nel periodo romantico, essi, come del resto gli Americani, ebbero la tendenza a vedere la scienza in Cina e la religione in India. Questo pregiudizio sembra trovare una conferma nell'assenza di un 'Needham indiano', ma coloro che affronteranno senza preconcetti i capitoli della presente Sezione dedicata alla scienza indiana potranno facilmente rendersi conto del fatto che le tradizioni scientifiche indiane non sono meno ricche di quelle cinesi.
Quest'impressione di ricchezza è confermata dalla stessa opera di Needham, che, oltre a descrivere la scienza cinese, abbonda di riferimenti ad altre scienze euroasiatiche e in particolare a quella indiana e a quella islamica. Come le popolazioni dell'Asia sudorientale, gli Iraniani, i Tibetani, gli Arabi e i Cinesi erano affascinati dalle scienze indiane. Il vasto corpus di traduzioni (spesso eseguite grazie a intermediari centroasiatici) di opere scientifiche dal sanscrito al cinese realizzato dai monaci buddhisti può essere raffrontato all'opera di traduzione dal greco in arabo e latino eseguita in Europa mille anni più tardi. Il confronto tra alcuni dei capitoli che seguono e quelli dedicati agli stessi temi da Needham (per es., il v. III, La matematica e le scienze del cielo e della Terra, redatto in collaborazione con Wang Ling e pubblicato nel 1959, e il v. VII, Il linguaggio e la logica, redatto da Christoph Harbsmeier e pubblicato nel 1998, dopo la morte di Needham) darà fondamento all'idea che è l'India e non la Cina a essere più ricca nel campo delle scienze astratte, come, per esempio, la matematica, la logica e la linguistica; per comprendere e apprezzare le scienze indiane dobbiamo quindi rivolgere la nostra attenzione alla nozione di 'astrazione'.
Il progresso scientifico
La scienza è caratterizzata dalla tendenza a guardare in avanti e non indietro: può essere utile trovarsi 'sulle spalle dei giganti' (una famosa espressione di Newton), ma soltanto se ciò ci consente di scorgere cose sfuggite ai giganti stessi. L'idea di progresso è essenziale per la scienza perché l'esperienza insegna che si può giungere alla verità soltanto dopo essersi emancipati dalle false credenze. Come l'evoluzione della vita, che per molti aspetti coincide con l'adattamento all'ambiente, la storia della scienza può essere considerata da molti punti di vista un percorso di avvicinamento graduale alla verità. Ovviamente, non si tratta di un progresso universale; la felicità umana, per esempio, non si è accresciuta in modo evidente o non si è affatto accresciuta, anche perché gli esseri umani hanno compiuto grandi progressi nella ricerca di nuovi metodi destinati non soltanto a salvare ma anche a distruggere le vite dei loro simili. Allo stesso tempo, nonostante le rivendicazioni delle teorie relativistiche della scienza, che si richiamano invariabilmente ai mutamenti di paradigma di Thomas Kuhn, è innegabile che noi ‒ o, per essere più precisi, quelli di noi che operano come specialisti ‒ conosciamo e comprendiamo un numero molto maggiore di cose rispetto ai più informati dei nostri antenati. Naturalmente, non tutte le scienze si sono evolute in modo costante, secondo linee di sviluppo progressive; i loro percorsi registrano dei cul-de-sac e molte conoscenze sono indubbiamente andate perdute, ma in essi sono evidenti anche grandi aperture che coincidono non soltanto con l'ampliamento ma anche con l'approfondimento delle nostre conoscenze, in particolare, sull'Universo, la vita, il linguaggio, la società e il cervello. La scienza moderna ‒ soprattutto quella successiva alla Rivoluzione scientifica ‒ conferma questa tesi pur riconoscendo il persistere di questioni irrisolte e l'emergere di problemi nuovi che sono, a loro volta, un prodotto del progresso scientifico.
Il concetto di 'progresso scientifico' non è una 'nozione popolare' ed è stato esplicitamente criticato da diversi pensatori. Tra questi, uno dei più eloquenti è stato indubbiamente Martin Heidegger, che non si è limitato a formulare una serie di preconcetti ancora oggi molto diffusi in proposito, ma ha anche affrontato alcune questioni che riguardano il concetto stesso di scienza.
Quando noi, oggi, parliamo di scienza, intendiamo qualcosa di assolutamente diverso dalla doctrina e dalla scientia del Medioevo e anche dalla epistḗmē greca. La scienza greca non fu mai 'esatta' e non lo fu perché per la sua stessa natura non abbisognava di esserlo. Perciò non ha senso alcuno affermare che la scienza moderna è più esatta di quella antica. Allo stesso modo non si può dire che la teoria galileiana della caduta dei gravi è vera e che quella aristotelica, secondo cui i corpi pesanti tendono al basso, è falsa. Infatti, la visione greca della natura del corpo, del luogo, e dei loro rapporti, riposa su una diversa interpretazione dell'ente e determina analogamente un diverso modo di vedere e d'indagare i processi naturali. Nessuno pretenderà che la Poesia di Shakespeare sia più progredita di quella di Eschilo. Ma è ancora più assurdo dire che la concezione moderna dell'ente è più esatta di quella greca. Se vogliamo pertanto afferrare l'essenza della scienza moderna dovremo liberarci del luogo comune che pretende di cogliere la natura della nuova scienza procedendo gradualmente dall'antica, sotto la guida dell'idea di progresso. (Heidegger 1950; trad. it., pp. 73-74)
I punti di forza e di debolezza di questo brano sono evidenti per chiunque abbia una certa conoscenza di una qualsiasi scienza. Non è il caso di dilungarsi sulla spiegazione del concetto di 'ente'; questo punto di vista, come è stato spiegato da A.C. Graham (1989), è privo di senso per quanto riguarda il pensiero cinese; non è neppure il caso ‒ in questa sede ‒ di dimostrare che gli standard di 'esattezza' si sono gradualmente evoluti nel corso della storia della matematica (affronteremo questo tema più avanti, in riferimento alle approssimazioni del valore di π, che nel corso della prima metà del XIX sec. furono adottate ovunque nel campo dell'analisi e furono più apprezzate in Germania che in Inghilterra). Needham rettifica, en passant, la zoppicante analogia di Heidegger, senza però menzionarlo: "Sarebbe difficile dire in qual senso Michelangelo può essere considerato un perfezionamento di Fidia, o Dante di Omero, ma non si può dubitare del fatto che Newton, Pasteur ed Einstein conoscevano un numero molto maggiore di cose sull'Universo naturale di Aristotele o di Chang Hen" (Needham 1976, cap. 23). Egli opera una distinzione tra scienza e arte molto efficace, sostenendo che le scienze sono interessate al progresso perché ricercano conoscenze attendibili. A questa ricerca dovrebbero dedicarsi gli aspiranti scienziati, a essa si sono dedicati con successo i migliori tra loro; questo dato di fatto non può essere negato richiamandosi alle pur numerose eccezioni, così come non si può negare il fatto che gli esseri umani siano razionali richiamandosi al loro comportamento irrazionale.
La nozione di progresso era tutt'altro che comune nell'antica Grecia. E.R. Dodds (1973) sostiene che questo concetto risale al V sec. a.C., quando la cultura allargò i propri orizzonti; egli conclude il suo saggio con una considerazione di carattere generale, affermando che nelle epoche di grandi progressi culturali, come il V sec. a.C., la fede nel progresso è in genere ampiamente diffusa, mentre in quelle in cui i progressi sono limitati alle singole discipline, come l'Età ellenistica, questa fede è circoscritta agli specialisti; quando lo sviluppo del sapere subisce un vero e proprio arresto, come negli ultimi secoli dell'Impero romano, la speranza nel progresso svanisce. Inoltre, un progresso rivendicato può rivelarsi immaginario, così come un effettivo progresso può celarsi dietro alla sua esplicita negazione: per es., nell'Antichità occidentale i pitagorici attribuirono a Pitagora molti risultati che furono raggiunti solo successivamente; nella filosofia indiana, il Vedānta afferma di rappresentare o di riassumere i Veda; e anche le cosmologie semiscientifiche dei Purāṇa furono attribuite ai Veda (v. cap. V). I seguaci della scienza delle gemme accettavano la teoria mitica secondo cui le pietre preziose erano generate dal corpo di un demone assassinato, Bala; altri accennavano alla spiegazione più scientifica secondo cui esse erano prodotte 'dalle qualità caratteristiche della Terra' (v. cap. XVII).
L'astronomo Lalla (VIII o IX sec. d.C.), cui accenna Pingree, era chiaramente consapevole del fatto che la sua scienza aveva compiuto grandi progressi rispetto a quella dell'epica e dei Purāṇa (un nome che letteralmente significa 'testi antichi'). Lalla volse in ridicolo la tesi enunciata in questi testi secondo cui la Terra è piatta ed è sostenuta da una tartaruga e le eclissi sono causate da un demone:
Se la Terra è piatta come uno specchio, perché l'acqua che cade dal cielo non rimane ferma ma ‒ ahimè! ‒ scorre a grande velocità in una direzione?
Se la Terra è sostenuta da una tartaruga [...], chi sostiene entrambe nello spazio? Se entrambe possono rimanere sospese nello spazio, che cosa impedisce alla Terra di rimanerci da sola?
Se siete dell'opinione che un abile demone causi le eclissi inghiottendo [il Sole o la Luna], come spiegate il fatto che un'eclissi può essere prevista attraverso il calcolo? (Subbarayappa 1985, pp. 41-45)
In Europa l'interpretazione delle scoperte come 'riscoperte' non fu limitata esclusivamente all'Antichità, ma conobbe una grande fortuna anche nelle epoche successive. Nei fondamenti della sua filosofia, Platone affermava che la conoscenza è 'memoria'. Questa concezione fu modificata in modo inaspettato dal cristianesimo, secondo cui la rivelazione divina non poteva essere perfezionata per definizione. Il mito europeo di Pitagora come sapiente progenitore della scienza è probabilmente una tarda risposta greca alla crescente popolarità di Cristo. Alcuni pensavano che i Greci dovessero il loro sapere agli Ebrei a cui era stata rivelata la vera sapienza, o attribuivano a Ermete Trismegisto molte concezioni più tarde e tutto ciò che ritenevano potesse ricondursi alla tradizione ermetica o gnostica.
è lecito chiedersi come si possa riconoscere un progresso se non si conosce il passato. La conoscenza del passato deve essere considerata propriamente una conoscenza scientifica, anche se la scienza della storia non sarà presa in esame in questa sede; l'idea che la storia non possa essere considerata una scienza, e quella che una 'scienza della scienza' non sia mai esistita in India, sono considerate insostenibili a parere di uno dei più autorevoli storici contemporanei dell'Antichità, vale a dire Romila Thapar (1978, 1986). La conoscenza scientifica nasce da intuizioni radicate nei fatti e affinate dalla logica, che sono poi costantemente verificate alla luce di entrambi questi fattori. Nello studio del passato non è possibile evitare l'uso di un metro di valutazione moderno; parliamo, per esempio, delle ruote primitive dal punto di vista delle attuali ruote dotate di raggi e dei mezzi di trasporto che ci sono familiari. Questa constatazione riguarda tanto la tecnologia quanto la scienza e Gilbert Ryle l'ha posta alla base della sua visione filosofica:
Naturalmente, c'è sempre una considerevole dose di rischio nel tentare di spiegare le dottrine di un filosofo del passato alla luce delle dottrine successive e soprattutto di quelle contemporanee. […] Ma la linea di condotta opposta, secondo cui bisogna tentare di descrivere l'evoluzione di una teoria ancora immatura senza riferirsi ai progressi di teorie più progredite, non comporta il rischio ma la certezza dell'insuccesso. Senza le ricerche successive che hanno reso più chiara la questione spesso non riusciremmo a definire esattamente la problematica di un filosofo e tanto meno la direzione e l'efficacia dei suoi tentativi di risolverla. (Ryle 1939, pp. 324-325)
A volte gli storici della scienza oscillano tra queste due linee di condotta. Nell'XI sec. lo scienziato arabo al-Bīrūnī ‒ un esperto astronomo, matematico, geografo e sanscritista ‒ eseguì uno studio dedicato ai paesi islamici e all'India, aprendo così la strada a Ibn h̠aldūn, il primo sociologo e storico delle società. Benché sapesse che sarebbe stato criticato se, da buon musulmano, non avesse denunciato l'induismo, al-Bīrūnī volle precisare che il suo dovere di storico era quello di ricercare la verità. Il primo curatore e traduttore della sua opera, Edward C. Sachau (1888), e quello moderno, Ainslie Embree (1971), sono concordi nel ritenere che la metodologia adottata da al-Bīrūnī nello studio della civiltà indiana fosse fondata sulla sua appassionata esigenza di verità. Un'analoga visione è stata enunciata dallo storico della scienza islamica Seyyed Hossein Nasr:
Lo studioso che si occupò nel modo più obiettivo dell'uomo e, per così dire, fornì i materiali sui quali Ibn h̠aldūn fondò le sue osservazioni di carattere generale sulla storia umana fu al-Bīrūnī. Autore di un'analisi approfondita sia della società islamica sia di quella indiana, a quest'ultima dedicò un'opera memorabile intitolata India, che è indiscutibilmente uno degli studi più scientifici e obiettivi sull'uomo e sulla società eseguiti nel corso dell'età medievale, in un periodo in cui nel mondo occidentale questo genere di studi non superava il livello delle cronache. (Nasr 1968, p. 231)
Sottolineando la scientificità e l'obiettività dello studio dell'uomo, Nasr parla da storico della scienza che accetta di usare la conoscenza contemporanea come metro di valutazione. Ciò, tuttavia, sembra contraddire la negazione fondamentalista del progresso che enuncia quando scrive in merito alla storia della scienza: "Il nostro obiettivo non è quello di analizzare le scienze islamiche dal punto di vista della scienza moderna e della concezione 'evoluzionista' della storia, ma è, al contrario, quello di presentare certi aspetti delle scienze islamiche considerandoli da un punto di vista islamico" (ibidem, p. 21).
Joseph Needham ha criticato questa prospettiva che, a suo parere, separa la scienza islamica dal grande movimento progressivo della scienza naturale di tutta l'umanità: "significherebbe tornare indietro e questo non è possibile"; poi aggiunge: "Per scrivere la storia della scienza, dobbiamo usare come metro di valutazione la scienza moderna ‒ è l'unica cosa che possiamo fare ‒, ma la scienza moderna è in continua evoluzione, e non è ancora giunta al termine della sua storia" (Needham 1976). Egli stesso, tuttavia, è stato a sua volta criticato, per esempio da Nathan Sivin secondo il quale la storia della scienza riguarda "non l'elencazione di scoperte isolate, ma il confronto tra sistemi complessi di idee con le loro differenti relazioni e articolazioni, e sistemi di pensiero che hanno dato origine alle scoperte" (Sivin 1970, p. 35). Anche se, al contrario di Nasr, Sivin non riconosce una verità assoluta, ciononostante la sua posizione relativistica conduce a difficoltà analoghe.
Le scienze sono campi di ricerca e di attività ben definiti e inizialmente devono essere apprese sotto la guida d'insegnanti esperti. Anche in India, le linee di discendenza della trasmissione delle conoscenze dai maestri agli allievi diedero origine a scuole o tradizioni che si perpetuarono per secoli in modo sostanzialmente indipendente dagli eventi esterni. Gli scienziati si emanciparono dai limiti imposti dal loro contesto per fare riferimento a coloro che li avevano preceduti nello studio degli stessi problemi o di questioni analoghe, ovunque avessero operato. Le opere più tarde erano spesso composte in forma di 'commenti' (bhāṣya) o di 'glosse' (ṭīkā) a testi più antichi che a loro volta derivavano dalla prima opera, spesso chiamata sūtra, di una linea di discendenza. Tuttavia, questi testi non corrispondono all'idea europea di 'commento' e 'glossa', ma molto di frequente contengono, talora senza dichiararlo esplicitamente, materiali nuovi e originali. Daniel Ingalls ha descritto in proposito il caso della logica (nyāya):
I logici trasformarono completamente le dottrine del saggio che aveva compilato il Nyāya-sūtra. In effetti, dovettero farlo per poter competere nelle discussioni con i buddhisti. Ma soltanto in alcuni rari casi le presentarono esplicitamente come opere originali. Quasi sempre essi pretesero di commentare un testo più antico, sostenendo che, anche se aveva taciuto su una certa questione, il saggio in realtà intendeva dire questo e quello. La scuola del Nyāya antico, che fu attiva per un millennio, era basata fondamentalmente su una sola opera formata da sei stratificazioni: sūtra, commentario al sūtra, primo subcommentario al sūtra, secondo subcommentario al sūtra e così via fino al sesto strato. (Ingalls 1959, p. 6)
Questa descrizione può essere applicata, in vari modi, ai commentari scientifici che saranno presi in esame nei capitoli successivi e in parte anche al 'Grande Commento' (Mahābhāṣya) di Patañjali di cui si parla nel primo dei due esempi proposti qui di seguito. Entrambi questi esempi indicano un progresso ma, considerati in una prospettiva globale, conducono istruttivamente a risultati molto diversi.
Un primo esempio: la scienza indiana del linguaggio
Come dimostra George Cardona nei capitoli dedicati alla scienza del linguaggio (capp. VIII e XIII), l'Aṣṭādhyāyī (Trattato in otto capitoli) di Pāṇini rappresenta (citiamo le sue parole) "la massima espressione della speculazione grammaticale sanscrita". Senza pretendere di voler integrare in modo sostanziale la sua analisi, tenteremo di dimostrare, combinando tra loro una serie di elementi, che dalle origini fino a Pāṇini e in una certa misura anche nel periodo successivo lo sviluppo di questa scienza registrò un enorme progresso. Nel prendere in esame la grammatica dovremo tenere conto della 'scienza del rituale' (Staal 1982). Christopher Minkowski (v. cap. IX) precisa che lo sviluppo del rituale degli Śrautasūtra (regole relative alla dottrina rivelata) è analogo a quello subito dalla scienza del linguaggio e che probabilmente ebbe luogo nello stesso periodo. Ciò consente di spiegare alcuni espedienti tecnici impiegati in entrambi i campi, tra i quali, per esempio, lo stile sūtra dell'analisi e l'uso delle 'metaregole' (paribhāṣā).
Gli Śrautasūtra ‒ che, nella versione che conosciamo oggi, furono redatti all'incirca nella stessa epoca in cui visse Pāṇini ‒ sono antichi ma non antiquati, come dimostra una caratteristica decisamente contemporanea, il concetto di default ('predefinizione'). Questo concetto e le sue applicazioni pratiche dimostrano che i primi scienziati indiani erano interessati sia agli oggetti delle loro analisi scientifiche sia al linguaggio stesso della scienza ‒ un fatto che, come vedremo più avanti, non è privo di significative implicazioni. Nel rituale śrauta è previsto un gran numero di offerte od oblazioni, di sacerdoti e di strumenti. Poiché sarebbe stato controproducente indicare in tutte le fasi del rituale a quale oblazione, a quale sacerdote e a quale strumento fosse necessario ricorrere, quando non era specificata un'altra opzione si applicavano i criteri di predefinizione; così, nel caso delle oblazioni si presupponeva di dover ricorrere al burro chiarificato, in quello dei sacerdoti all'adhvaryu dello Yajurveda e in quello degli strumenti al mestolo chiamato juhū ('lingua'). Comunque, vi erano diversi livelli di predefinizione: per esempio, nei casi in cui la 'lingua' era già usata e non era indicato nessun altro strumento, l'oblazione doveva essere eseguita con un altro tipo di mestolo definito sruva ('fluente'). Anche il manuale rituale di āpastamba (V-IV sec. a.C.) adotta questo sistema di predefinizione (ma ne esistevano molti altri) e ne spiega l'uso per mezzo di quattro metaregole: nel conciso stile dei sūtra (24.1.23) si prescrive che quando 'egli esegue un'oblazione', si deve intendere che quest'ultima sarà 'di burro chiarificato'; (24) come agente s'intende l'adhvaryu; (25) come strumento, la juhū; (26) quando questa è già utilizzata, lo sruva. Pāṇini (2.3.1) ricorre a un meccanismo analogo nella sua spiegazione delle relazioni dei kāraka (v. cap. VIII).
Si possono distinguere tre fasi progressive nel primo sviluppo della scienza indiana del linguaggio, la prima delle quali è rappresentata dai Padapāṭha, la seconda dai Prātiśākhya, la terza dalla grammatica di Pāṇini e dai suoi primi commenti. Rivolgeremo una particolare attenzione alla prima fase e combineremo tra loro le altre due che saranno esaminate nei dettagli da G. Cardona.
Vashishta N. Jha (1987) ha distinto cinque fasi nell'analisi del Ṛgveda (Veda degli inni). La prima coincide con l'isolamento dei pada, in quanto 'parole'. Nella seconda si separa il 'tema' dal 'suffisso' (per es., ṛṣibhiḥ è analizzato come ṛṣi-bhiḥ) e si effettua l'analisi, che consiste nell'inserire una breve pausa nella recitazione, chiamata avagraha ('separazione'). La terza fase riguarda i casi che non sono soggetti alle regole del sandhi ('adattamento fonologico'), come, per esempio, le vocali lunghe delle terminazioni duali: -ī, -ū, -e. Queste ultime sono chiamate pragraha o pragṛhya ('marcate') e nella recitazione sono seguite da iti, come, per esempio, saptaputram iti. Nella fase successiva, l'analisi dell'avagraha è estesa ai composti nominali (per es., saptaputram è analizzato in sapta-putram). Jha non menziona l'analisi parigṛhya, che consiste nello 'scandire e separare' (come, per es., appunto saptaputramiti in sapta-putram), ma è evidente che queste tre fasi, ossia avagraha, pragṛhya e parigṛhya, rivelano una graduale 'estensione' o 'generalizzazione' dell'analisi.
Inizialmente i casi in cui i due segmenti separati dall'analisi avagraha corrispondevano a tema nominale e suffisso non si distinguevano chiaramente da quelli in cui s'identificavano con gli elementi di un termine composto. Tuttavia, con il passare del tempo questa distinzione divenne sempre più chiara. Nel suo studio del Taittirīyapadapāṭha (Padapāṭha della scuola Taittirīya), pubblicato nel 1873, Albrecht Weber individuò un analogo processo di generalizzazione che andava dal Prātiśākhya del Ṛgveda e dell'Atharvaveda (Veda degli Atharvan) al Taittirīyaprātiśākhya (Prātiśākhya della scuola Taittirīya), nel corso del quale si trattarono tutti i casi avagṛhya come parigṛhya, compiendo un decisivo progresso, e al Vājasaneyiprātiśākhya (Prātiśākhya della scuola dei Vājasaneya), che segnò un'ulteriore evoluzione, includendo i casi pragṛhya.
Se rappresentiamo le parole sotto la forma di simboli convenzionali che indicano numeri, il flusso continuo delle parole della Saṃhitā sarà descritto da 1 2 3 … e la cadenza del Padapāṭha, in cui le parole sono isolate, da 1/2/3/…; saremo quindi in grado di valutare il progresso includendo una composizione vikṛti, come, per esempio, il Kramapāṭha o 'recitazione passo-passo': 1 2 / 2 3 / 3 4 / 4 5 / … Quest'ultima forma inizialmente era chiamata ubhayam antareṇa ('tra le altre due') perché include sia il Saṃhitāpāṭha sia il Padapāṭha. Nel Ṛgveda, la recitazione 'marcata e separata' saptaputram iti sapta-putram ha luogo soltanto nel Kramapāṭha e non nel Padapāṭha; tuttavia, essa è tipica del Taittirīyapadapāṭha e probabilmente della recitazione dello Yajurveda in generale. Potrebbe essere un'invenzione legata allo Yajurveda ma, in ogni caso, questo accostamento sembra suggerire che lo Yajurvedapadapāṭha, o uno dei Padapāṭha dello Yajurveda, e il Ṛgvedakramapāṭha risalgano allo stesso periodo, non molto successivo al 700 a.C. (Deshpande 1997). A quel tempo, i suoni della lingua erano considerati configurazioni bidimensionali, come, per esempio, il quadrato di 5×5 consonanti occlusive (pañca te pañcavargāḥ):
Le due tavole concordano tra loro e sono equivalenti perché presentano la stessa struttura; inoltre, esse illustrano le osservazioni di L. Renou e J. Filliozat secondo cui "una scrittura alfabetica di tipo semitico avrebbe impedito lo studio della fonetica in India, perché avrebbe fornito un modello di analisi dei suoni pratico ma non scientifico" (Renou 1953, p. 668). In altre parole, in India la linguistica nacque non 'malgrado', ma 'grazie' all'assenza della scrittura (Staal 1989a). Bisogna osservare che la struttura dei due quadrati, se ruotata di 180° intorno alla diagonale, sembra diversa, mentre rimane identica a livello di rappresentazione mentale, per esempio nella memorizzazione.
Separando tra loro le parole, l'analisi del Padapāṭha produceva un effetto opposto a quello che si proponeva, induceva cioè a 'dimenticare' le parole; forse è proprio questa una delle ragioni per cui fu elaborato il Kramapāṭha. Ben presto emersero altri tipi di analisi come, per esempio, il Jaṭāpāṭha, o 'recitazione intrecciata', dal termine con cui si designavano le ciocche di capelli intrecciate oppure arruffate, rappresentabile in forma numerica con 1 2 2 1 1 2 / 2 3 3 2 2 3 / 3 4 4 3 3 4 / … La recitazione intrecciata invertiva l'ordine delle parole e introduceva nuove forme che non comparivano nei tipi precedenti, inclusa la Saṃhitā originaria; per esempio, nella recitazione di un passo del Ṛgveda (1.164.1) l'inversione di palitasya hotuḥ si risolve in hotuḥ palitasya. A tale proposito Johannes Bronkhorst (1991) ha sollevato una questione interessante in un contesto analogo: queste procedure devono essere considerate 'prescrittive' o 'descrittive'? Si tratta di una questione molto importante per la tesi secondo cui l'analisi Padapāṭha è la prova di un progresso scientifico, dal momento che la scienza è, o almeno dovrebbe essere, descrittiva e analitica e non prescrittiva.
A prima vista, la risposta a questa domanda sembra ovvia: queste forme non appaiono nella tradizionale Saṃhitā vedica ed erano quindi prescritte. Tuttavia, tale risposta non è in realtà corretta perché non tiene conto delle distinzioni esistenti tra l'analisi di un corpus ben definito di espressioni, qual era la Saṃhitā vedica, e l'analisi del linguaggio parlato costituito da un numero infinito di frasi. M.M. Deshpande ha formulato una risposta in modo implicito, sottolineando che i brahmani che eseguivano queste recitazioni "usavano forme sanscrite meno antiquate nelle loro attività accademiche e rituali" (Deshpande 1997, p. 61). È vero che l'inversione introduce le forme anārṣa che non fanno parte del corpus vedico, ma queste forme erano usate nel linguaggio parlato, o in qualsiasi altro modo lo si voglia definire. L'inversione grammaticale corretta della frase palitasya hotuḥ nel linguaggio parlato è hotuḥ palitasya e non una forma grammaticalmente scorretta come, per esempio, *hotur palitasya o *hoto palitasya. Le inversioni corrette appartengono al linguaggio e quindi sono descrittive e non prescrittive. Sotto questo aspetto sono forme diverse da quelle esclusivamente rituali e grammaticalmente scorrette (come, per es., othāmo daiva made) e da altre "bizzarre contorsioni liturgiche" (per riprendere un'espressione di Caland 1907, p. 232, n. 8), o dalle forme del Sāmaveda (Veda dei canti), come, per esempio, o gnā ā yā hi. Queste strane forme non potevano che essere prescritte; possono essere considerate ascendenti della linguistica soltanto nella misura in cui facilitarono la pratica di scrittura delle regole. Le sequenze ārṣa furono in seguito definite da Pāṇini chandas ('vediche'); le sequenze anārṣa possono essere considerate anticipazioni dello studio dedicato dallo stesso Pāṇini al linguaggio parlato o bhāṣā.
La seconda e la terza fase dello sviluppo della linguistica indiana sono rappresentate dai Prātiśākhya (manuali di fonetica e fonologia) e dalla grammatica di Pāṇini. I testi chiamati Prātiśākhya enunciavano le regole che legavano le Saṃhitā ai Padapāṭha (testi analitici) così come ad altre vikṛti e indicavano i loro scopi: "[lo studio del Padapāṭha ha] lo scopo di afferrare saldamente (dārḍhya) le Saṃhitā vediche" e "lo studio del Kramapāṭha ha lo scopo di afferrare saldamente i Saṃhitāpāṭha e i Padapāṭha" (Śaunakīyacaturādhyāyikā 4.4.8-9, in: Deshpande 1997, pp. 612-613). Le relazioni esistenti tra i primi due sono espresse in modo ambiguo con l'espressione padaprakṛtiḥ saṃhitā che potrebbe significare 'La Saṃhitā è la base del Pada' o 'La Saṃhitā ha il Pada alla sua base'. I Prātiśākhya adottavano in generale la seconda interpretazione, enigmatica dal nostro punto di vista storico, che indicava un ritorno ai compositori che combinarono per la prima volta le parole nel loro linguaggio ispirato, proprio come facciamo noi ogni volta che parliamo o scriviamo. Pāṇini ricorre esclusivamente a quest'ultimo metodo e risale dalle parole alle frasi. La sua spiegazione delle forme vediche si limita quindi al Padapāṭha. Le regole vediche di Pāṇini "sono regole di supporto che vengono ad aggiungersi alle regole già stabilite e giustificate in base al sanscrito classico. Se si cancellassero tutte le regole propriamente vediche contenute nell'Aṣṭādhyāyī, non sarebbe facile ricostruire la loro presenza in base alla struttura di quel che resta" (Kiparsky 1979, p. 56). All'inizio del capitolo dedicato ai Prātiśākhya della sua Grammatical literature che venne pubblicata nel 1977, Hartmut Scharfe afferma:
Gli studiosi moderni si sono trovati ad affrontare soprattutto una questione, quella relativa alle relazioni esistenti tra i Prātiśākhya e Pāṇini. Inizialmente la fede nel costante progresso dell'umanità ha indotto a ritenere che i Prātiśākhya, meno scientifici, dedicati all'esame di una sola Saṃhitā nella sua forma esteriore e spesso formulati in uno stile rudimentale, fossero anteriori all'opera di Pāṇini che rivela un'ampia prospettiva ed è redatta in uno stile conciso. Ma ben presto si è dovuto ammettere che almeno alcuni Prātiśākhya presuppongono la conoscenza dell'opera di Pāṇini. (Scharfe 1977)
Naturalmente, il Vājasaneyiprātiśākhya è posteriore a Pāṇini, che non conosceva neppure la Vājasaneyisaṃhitā. A mio avviso, non è detto che si possa parlare di un progresso costante dell'umanità ‒ ci sono troppe eccezioni e troppi dubbi ‒ però si può dimostrare come l'evoluzione che dal Padapāṭha conduce al Prātiśākhya e poi a Pāṇini indichi un progresso scientifico. La chiave della discordanza di opinioni su tale questione è che i Prātiśākhya sono precedenti a Pāṇini a causa della loro struttura e della loro funzione e non per le forme sopravvissute, che potrebbero essere state influenzate da Pāṇini o da altri grammatici. Sostenere che il 'genere' dei Prātiśākhya sia posteriore a Pāṇini equivale a sostenere che la termodinamica del XIX sec. è posteriore alla meccanica quantistica del XX sec. perché in un testo di termodinamica del XX sec. è stato individuato un riferimento alla meccanica quantistica.
Considereremo ora un'altra caratteristica, già brillantemente descritta da Surya Kanta (1968), che ha affrontato lo studio dei Prātiśākhya con lo stesso spirito analitico rivelato in seguito da V.N. Jha nell'esame del Ṛk-padapāṭha. Surya Kanta opera una distinzione tra le enumerazioni o elenchi (gaṇa) e le generalizzazioni spiegate nelle regole dei sūtra. Egli ammette che un Prātiśākhya nella forma in cui ci è pervenuto possa presentare una serie di generalizzazioni ed essere, al tempo stesso, più antico di un altro quasi esclusivamente costituito da elenchi. Quindi opera una distinzione tra due tipi 'ideali' che, sull'esempio di Deshpande (1997), definiremo 'tipo A' e 'tipo B': il primo è costituito da elenchi esaustivi di esempi che espongono modelli di strutture linguistiche, ma non regole generali, e coincide con la prima fase, mentre il tipo B contiene regole generali, così come le eccezioni a queste regole generali, e coincide con la seconda fase.
Deshpande (ibidem, p. 59) elogia la "splendida edizione del 1939 di un diverso Atharvaprātiśākhya" di Surya Kanta, ma non concorda con quest'ultimo nel ritenere che il tipo B sia un perfezionamento del tipo A. Egli asserisce, al contrario, che "in realtà, le elencazioni dipendono dalle generalizzazioni e le generalizzazioni dipendono dalle elencazioni" (ibidem, p. 60). Le generalizzazioni, tuttavia, sono ricavate dagli elenchi e quindi dipendono da questi ultimi. A partire da una generalizzazione non è difficile compilare un elenco, ma a quale scopo ‒ a meno che non si tratti di un elenco di eccezioni?
I tipi ideali di Surya Kanta servono a spiegare lo straordinario progresso compiuto nel corso del primo sviluppo della linguistica indiana. In primo luogo, i Veda si distinguevano nettamente dai poemi trasmessi oralmente dai cantori, in generale inclini a introdurre cambiamenti. Essi dovevano essere ben compresi e tenuti a mente. L'insolita, se non ossessiva, attenzione alle minutiae del linguaggio comunemente parlato può essere spiegata soltanto con la più antica esigenza di stabilire un'accurata recitazione destinata ad accompagnare la celebrazione del rituale. L'attenzione nei confronti dell'analisi del linguaggio, che abbiamo definito 'ossessiva', sarebbe chiamata 'rispetto per i fatti' in un contesto scientifico. I primi fatti descritti dalle regole dei sūtra erano eventi rituali; in seguito, però, emerse l'esigenza di sottoporre all'analisi anche il linguaggio parlato. Gran parte di questo lavoro potrebbe essere stata svolta da una serie di precursori le cui opere sono andate perdute, ma il primo autore di cui sia attestato l'esplicito proposito di sottoporre ad analisi il linguaggio parlato è Pāṇini. Nella sua epoca, lo sviluppo della linguistica si era già manifestato con una serie di generalizzazioni ed egli compì ulteriori progressi, approfondendo la formalizzazione, una ben nota caratteristica della sua grammatica.
I primi grammatici che seguirono l'esempio di Pāṇini dei quali ci sono pervenute le opere sono Kātyāyana e Patañjali, autori delle 'glosse' (varttika) e del Mahābhāṣya (o Grande Commento alle summenzionate glosse; v. cap. VIII). All'inizio del XIX sec., gli studiosi ritenevano che Kātyāyana fosse un rivale di Pāṇini che aveva tentato di individuare delle imprecisioni nella sua opera e che Patañjali avesse cercato di giustificare Pāṇini contraddicendo Kātyāyana. Nel 1876, Franz Kielhorn confutò questa tesi in un opuscolo, oggi considerato conclusivo dalla maggior parte degli studiosi. Egli dimostrò per la prima volta che Kātyāyana non si era limitato a criticare le regole di Pāṇini, ma che molto spesso le aveva anche giustificate confermando quindi la sostanziale correttezza del vārttika presentato due millenni più tardi da Nāgoji Bhaṭṭa: sūtre'nuktaduruktacintākāratvaṃ vārttikatvam; Kielhorn ne offrì la seguente versione parafrasata: le glosse "considerano se nei sūtra sia stato omesso qualcosa che avrebbe dovuto essere specificato o se in essi vi sia qualcosa di superfluo, erroneo o espresso in maniera insoddisfacente" (Kielhorn 1876, pp. 51-52). Per quanto riguarda Patañjali, egli ha dimostrato che sia il suo rifiuto sia la sua accettazione di certe glosse sono esplicitamente motivati e ha concluso affermando che: "In nessun caso, Patañjali commenta Pāṇini con il semplice intento di spiegarlo, ma sull'esempio di Kātyāyana, tenta di scoprire se nei sūtra sia stato omesso qualcosa che avrebbe dovuto essere specificato, o se in essi vi sia qualcosa di superfluo, di erroneo o in qualche modo suscettibile di discussione" (ibidem, p. 56).
L'esame dell'opera dei grammatici più tardi (esposto da G. Cardona) concorda con la descrizione di Louis Renou, secondo la quale essi si dedicarono "all'approfondimento delle dottrine" o "alla loro volgarizzazione" (Renou 1940, I, p. 32). Kielhorn (1881) aveva già osservato che gli sviluppi successivi a Pāṇini sono legati al tentativo di perfezionare il suo ordinamento e ad altri 'scopi utili'. Lo studioso più originale di questo periodo fu indubbiamente Bhartṛhari, che elaborò una nuova teoria della grammatica e rivolse una grande attenzione alla semantica e alla filosofia della grammatica. Rinviando tale questione al paragrafo successivo, per il momento ci limiteremo a riassumere quanto constatato finora: nella scienza indiana del linguaggio e soprattutto nella sua fase di formazione è individuabile un enorme progresso.
Occorre ricordare altri due fatti. Il primo è che la scienza indiana del linguaggio ha avuto vaste implicazioni pratiche in molte regioni asiatiche: questa scienza, che in origine era esclusivamente orale, ha influenzato infatti non le forme ma l'ordine e l'organizzazione di quasi tutte le scritture dell'Asia meridionale, centrale e sudorientale, così come quelle dell'Asia orientale; tra queste ricorderemo le scritture brāhmī, kharoṣṭhī, gupta, khotanese, siddham, tibetana, nepalese, bengalese, nāgarī, gujaratī, pallava, kannada, telugu, tamil, malayalam, singalese, birmana, thailandese, khmer, giavanese e balinese. Nell'Asia orientale, l'unico sistema di caratteri che resistette all'indianizzazione fu quello cinese, che conservò la sua indipendenza nonostante la rappresentazione del sanscrito fosse fatta con il sistema di scrittura siddham. In Asia centrale, invece, nel corso di un periodo relativamente breve, la lingua cinese fu scritta ricorrendo ad alcuni alfabeti indiani o di derivazione indiana come, per esempio, la brāhmī, il tibetano o il ḥPhags-pa (creato dal lama omonimo, a partire dal tibetano, per l'imperatore mongolo Khubilai Khān affinché fosse utilizzato come scrittura internazionale nel suo Impero asiatico). In Giappone il sistema indiano fu adottato nei sillabari hiragana e katakana che furono ideati nel corso del periodo Heian (794-1185) e combinati con i caratteri cinesi nel sistema di scrittura giapponese. In Corea, infine, il sistema indiano portò all'elaborazione della scrittura han'gul, creata nel 1444 da un comitato di studiosi scelti dall'imperatore.
Il secondo fatto importante ai fini della nostra analisi è che la linguistica moderna non sarebbe esistita se Franz Bopp (1791-1867) non avesse individuato il metodo con cui analizzare le parole dividendole in unità semantiche più piccole grazie alla grammatica sanscrita pubblicata nel 1808 dall'inglese Charles Wilkins, la quale era a sua volta basata sulla grammatica sanscrita di Pāṇini (Thieme 1982-83). Con l'aiuto delle tecniche di analisi descritte in questo testo, Bopp riuscì per la prima volta a confrontare tra loro diversi linguaggi affini in modo sistematico e scientifico, introducendo così un nuovo paradigma nella linguistica (Staal 1989b). La linguistica moderna non sarebbe nata senza la tradizione grammaticale sanscrita.
Un secondo esempio: le scoperte indipendenti e la serie di potenze
Il progresso compiuto dalla matematica può essere valutato attraverso le successive approssimazioni del valore di π che furono prodotte nel corso del tempo. In India, quest'area di indagine registrò nel corso di un millennio considerevoli progressi, ai quali, tuttavia, si giunse attraverso un percorso piuttosto tortuoso. Nel cap. X Takao Hayashi riferisce che verso il 500 d.C. Āryabhaṭa I stabiliva per il rapporto π tra la lunghezza della circonferenza e quella del diametro di un cerchio il valore 62.832/20.000 o 3927/1250=3,1416. Non sappiamo come Āryabhaṭa fosse giunto a determinare questo valore o da dove l'avesse ricavato. La maggior parte dei matematici più tardi adottarono i valori 3 oppure 101/2, precedentemente stabiliti dai matematici jaina, precisando in generale a questo proposito che '3 è per gli usi pratici e 101/2 per i calcoli accurati'. Tutti, o quasi tutti, questi studiosi più tardi molto probabilmente conoscevano il valore proposto da Āryabhaṭa, ma non lo consideravano affidabile perché non potevano verificare direttamente il metodo attraverso il quale egli l'aveva ricavato. Tra il XV e il XVII sec., con la scuola di Mādhava o 'Nuova onda nel Sud', grazie alla scoperta dello sviluppo di una serie di potenze di π, si stabilì un'approssimazione del suo effettivo valore fino a undici decimali. Questo procedimento è stato descritto nei dettagli da Hayashi, Kusuba e Yano (Hayashi 1989).
Nello stesso periodo furono scoperte anche serie trigonometriche simili alle serie di potenze di π; in seguito, Leibniz, Newton e Gregory le scoprirono per la seconda volta. Si può forse presumere che queste due scoperte siano storicamente connesse tra loro? Lo storico della matematica B.L. van der Waerden adotta su basi euristiche l'ipotesi di una 'origine comune'; vale la pena di citare per esteso il brano in questione:
Le grandi scoperte nel campo della matematica, della fisica e dell'astronomia, escludendo alcune rare eccezioni, sono state effettuate una sola volta. Gli epicicli e i deferenti [delle orbite apparenti dei pianeti], la sfericità della Terra, il sistema eliocentrico, le tre leggi di Keplero, le tre leggi della meccanica di Newton, la legge di gravitazione universale, sono state scoperte una sola volta. Ciò vale anche per le leggi dell'ottica, dell'elettricità e del magnetismo e così via. Nel campo della matematica si registrano alcuni casi di scoperte indipendenti, come, per esempio, la scoperta della geometria non euclidea effettuata da Gauss, Bolyai e Lobačevskij, ma la grande maggioranza delle grandi scoperte nel campo della geometria, dell'algebra e dell'analisi sono state effettuate una sola volta. Quando constatiamo che un grande e fondamentale teorema, come, per esempio, quello di Pitagora, certamente non facile da elaborare, era noto in diversi paesi, la cosa migliore da fare è adottare l'ipotesi della dipendenza. (van der Waerden 1983, p. 10)
Sembra che molti storici non accettino il principio euristico che conclude il brano citato, ossia "la cosa migliore da fare è adottare l'ipotesi della dipendenza"; frequentemente, infatti, essi presumono l'indipendenza delle invenzioni e, di conseguenza, non tentano neppure di spiegare le analogie. A molti altri studiosi, tuttavia, l'ipotesi della dipendenza appare come un criterio molto efficace; adottando questa ipotesi, spesso si riescono a individuare degli 'anelli mancanti' o altre indicazioni di connessioni e interazioni tra le diverse civiltà (ibidem).
Le serie di potenze scoperte da Mādhava, Nīlakaṇṭha, Śaṅkara, Leibniz, Newton e Gregory sono grandi scoperte, certamente non 'facili da effettuare'; cosa suggerisce in proposito l'adozione del principio euristico di van der Waerden?
È molto probabile che numerosi matematici arabi si siano ispirati a predecessori indiani, anche se, a eccezione di alcuni celebri casi, come, per esempio, quelli di al-ḫwārazmī e di al-Bīrūnī, non disponiamo di prove che possano accreditare questa ipotesi. Essa, tuttavia, sembra trovare una conferma nella Geschichte der Elementarmathematik (Storia della matematica elementare) di J. Tropfke, in cui le grandi scoperte sono presentate in ordine cronologico e le sezioni dedicate alla scienza indiana spesso precedono quelle relative alla scienza araba creando l'impressione di uno sviluppo continuo. L'influenza esercitata dalla matematica indiana su quella araba è certamente più profonda di quella rilevata dalle nostre fonti, e questa conclusione concorda con la tesi di D. Pingree secondo il quale il campo in cui la scienza occidentale ha maggiormente risentito dell'influenza indiana è la matematica, dal momento che essa si esercitò attraverso la mediazione degli Arabi che svilupparono e integrarono liberamente non soltanto le conoscenze dei testi greci, ma anche le tradizioni ancora vive in India. In generale, si ritiene che gli Arabi fossero in contatto con gli abitanti dell'India meridionale, ma si nega l'esistenza di una reciproca influenza scientifica (Rahman 1999c; Chand 1946). A quanto risulta, gli Arabi non conoscevano la serie di potenze e non diffusero questa conoscenza in Europa; siamo quindi in presenza, fino al rinvenimento di una nuova prova, di un caso d'invenzione indipendente, analogo a quello della geometria non euclidea.
Perché, al contrario delle scoperte di Leibniz e di altri scienziati europei, le invenzioni della scuola di Mādhava non sono considerate in relazione alla 'scienza moderna' o alla 'rivoluzione scientifica'? O, in altri termini, perché quest'ultima ha avuto luogo in Europa e non in India? Più avanti torneremo ad affrontare questo problema e abbozzeremo una risposta conclusiva; a tal fine, tuttavia, sarà necessario fornire alcune precisazioni. Benché avessero ideato un eccellente sistema di notazione decimale, gli Indiani seguitarono a usare un sistema sillabico di notazione numerica. Āryabhaṭa conosceva questo metodo, e a partire dal VII sec. nell'India meridionale s'iniziarono a utilizzare quattro sistemi chiamati kaṭapayādi (v. cap. X), tutti piuttosto laboriosi, che si distinguevano per una singolare caratteristica, ossia sillabe diverse potevano riferirsi allo stesso numero. Indubbiamente questo sistema era molto utile dal punto di vista letterario e introduceva un elemento di gioco: una sequenza di sillabe poteva infatti essere letta come un indovinello o un racconto.
I cinque numeri della sequenza dei termini dello sviluppo potenziale del seno, nella Tantrasaṃgrahavyākhyā (Esposizione del compendio della dottrina [astronomica]), sono indicati dalle parole vidvān, tunnabala, kapīśanicaya, sarvārthaśīlasthira e nirviddhāṅganarendraruṅnigadita. In generale il significato di queste notazioni tendeva a un 'crescendo' di fantasia: 'studioso', 'force de frappe', 'una moltitudine di dèi scimmia', 'costante in tutti i tipi di virtù' e 'Narendra con gli arti feriti conosciuto come ruc ('lucentezza')'. I matematici del Kerala si dilettarono ad attribuire ai loro numeri questo genere di nomi. A questo proposito, Bibhutibhusan Datta e Avadhesh Narayan Singh (Datta 1962, I, p. 64) osservano: "Bisogna notare che i sistemi alfabetici hindu, a differenza di quelli usati dai Greci e dagli Arabi, non erano utilizzati dalle persone ordinarie oppure allo scopo di eseguire dei calcoli; la loro conoscenza era diffusa soltanto tra gli eruditi che usavano esprimere i numeri in versi". Un'altra osservazione di questi autori riguarda le quattro varianti del sistema kaṭapayādi: "Probabilmente è a causa della disomogeneità della notazione che l'uso di questo sistema non si generalizzò" (ibidem, p. 69).
Il linguaggio della matematica indiana è complesso a causa di questi sistemi numerici e di altri nomi speciali, notazioni artificiali, termini tecnici e abbreviazioni che variano da regione a regione. Invece di usare il semplice sistema di notazione decimale, i matematici indiani seguitarono a usare il sanscrito, una lingua che, benché fosse formale, non era abbastanza formale o artificiale né tale da trasformarsi in un linguaggio matematico artificiale 'separato'; potrebbe essere questa la ragione per cui la scoperta di Mādhava non superò i confini del Kerala, per non dire dell'Oriente, e non condusse a quella che potrebbe essere definita una 'rivoluzione scientifica indiana'.
Contesti, retroterra culturali e la lezione di Newton
Needham ‒ come si è detto ‒ è stato criticato da Nathan Sivin, secondo cui la storia della scienza richiede non "un'enumerazione di 'scoperte isolate'", ma "il raffronto di insiemi completi di idee con le loro relazioni reciproche e le loro articolazioni integre" e "di interi sistemi di pensiero che sono serviti da matrice alle scoperte". Queste critiche, però, possono essere applicate alla storia delle idee ma non alla storia della scienza, dal momento che le verità scientifiche devono essere universali e non possono dipendere da un particolare contesto o retroterra culturale; per esempio, il fatto che il risultato della moltiplicazione di 2 per 2 sia uguale a 4 esprime una verità universale. Venendo a sapere, per esempio, che i cacciatori di teste avevano scoperto che 'due noci per due noci equivalgono a quattro noci' così come 'due teste per due teste equivalgono a quattro teste', non dobbiamo ridurre o attribuire questa significativa scoperta al 'raffronto di insiemi completi ecc.', o di 'interi sistemi di pensiero'; imponendo queste limitazioni arbitrarie, si trasforma la scoperta dei cacciatori di teste in qualcosa di completamente diverso da quella espressa da '2×2', alla quale non potrebbe più essere commisurata. È comunque da precisare, per concludere, che la civiltà dei cacciatori di teste non ha nulla a che fare con questa scoperta.
Le critiche di Nathan Sivin, che nascono da una posizione relativistica o conducono a una tale posizione, sono analoghe a quelle formulate da Seyyed Hossein Nasr, che pure si basano sull'accettazione del concetto di 'verità assoluta'; entrambe, tuttavia, possono essere confutate da quella che può essere definita la 'lezione di Newton'.
Isaac Newton (1642-1727), la figura più rappresentativa della scienza moderna, era un esperto storico e possedeva un patrimonio assai vasto di cognizioni sulle dottrine antiche. Benché avesse studiato a fondo l'Antico Testamento, egli non riteneva che questo testo contenesse verità più inoppugnabili di quelle racchiuse nelle testimonianze egizie, fenicie o caldee. Newton credeva nelle tradizioni esoteriche trasmesse attraverso una linea di discendenza ininterrotta che risaliva alla rivelazione criptica originale babilonese, per cui riteneva, anche nel corso delle sue indagini più creative nel campo della fisica o della filosofia della Natura, di riscoprire le antiche dottrine che Pitagora, Mosè, Democrito, Salomone e altri saggi avevano già enunciato in forma di parabole e simboli.
Newton espresse le sue idee in alcuni manoscritti, costituiti da almeno un milione di parole sull'alchimia e le tradizioni antiche; poi collocò questi manoscritti in una scatola che lo seguì nel viaggio da Cambridge a Londra, dove in seguito fu abbandonata. Soltanto di recente alcuni di questi testi sono stati dati alle stampe; infatti, sia gli storici positivisti della scienza sia le autorità religiose ne osteggiarono la pubblicazione, i primi in considerazione del contenuto troppo religioso e i secondi perché tale contenuto religioso non era di loro gradimento. L'economista John Maynard Keynes, il quale nel corso di tutta la sua vita non ha mai cessato di studiare le opere di Newton, ricorda che il vescovo Horsley, cui era stato chiesto di esaminare la scatola in vista della pubblicazione dei manoscritti, "scrutò con orrore il suo contenuto e richiuse precipitosamente il coperchio" (Keynes 1951, p. 317). Secondo Keynes, Newton doveva essere considerato l'ultimo rappresentante della tradizione esoterica più che il primo fisico moderno.
Un insigne studioso delle opere di Newton parla così del suo interesse per l'alchimia:
Benché il periodo precedente ai Principia coincida con uno degli apici della produzione quantitativa di questi testi, la metà o la maggior parte di essi, contenenti in totale più di 600.000 parole dedicate all'alchimia, furono redatti all'inizio degli anni Novanta del XVII sec., cioè subito dopo i Principia. Questa circostanza mi ha molto colpito: è indubbiamente la conclusione più significativa che emerge dallo studio dell'ordine cronologico di questi testi. L'interesse di Newton per l''arte' non può essere considerato un'infatuazione giovanile, né un'aberrazione senile. Esso coincide con la fase centrale della sua carriera scientifica e abbraccia il periodo della maggior parte delle scoperte su cui si basa la sua reputazione. In realtà, sembra che l'alchimia sia stata la sua passione più duratura. (Westfall 1975, p. 195)
Lo stesso Newton non pubblicò alcuna delle sue opere alchemiche e storiche, ma considerò con grande attenzione ogni virgola del testo dei Principia, che furono dati alle stampe nel 1687 per impulso e grazie alla collaborazione di Edmund Halley. Nei Principia Newton presenta i risultati delle proprie ricerche sotto la forma di deduzioni, in un latino semplice, un 'linguaggio'non ancora matematizzato. La reputazione di Newton sarebbe diversa se egli avesse derivato le leggi del moto da Ermete Trismegisto.
A prescindere dagli insegnamenti di carattere scientifico, Newton ci ha impartito un'importante lezione: quella di guardare ai risultati e non a ciò che gli scienziati o altri specialisti possono dire o credere al riguardo. Se dovessimo raffrontare tra loro insiemi completi di idee con le loro relazioni reciproche e le loro articolazioni complessive, e rivolgere la nostra attenzione a interi sistemi di pensiero che sono serviti da matrici alle scoperte, dovremmo valutare la fisica di Newton alla luce di tutto il contenuto della famigerata scatola. La lezione di Newton insegna invece che l'interesse della scienza risiede nella 'enumerazione di scoperte isolate' di Needham, 'astratte' dal loro contesto. Gli storici della scienza devono quindi ‒ per certi versi ‒ 'astrarre' dai contesti e dai retroterra culturali; soltanto dopo essersi dedicati a questo compito, potranno prendere in esame la dimensione della scienza in una data civiltà. A questo riguardo, nella sua interessante opera The dilemma of context, edita nel 1989, Ben-Ami Scharfstein contrappone il 'contestualismo' al 'non contestualismo', tenta di valutare i loro risultati e di individuare un approccio intermedio. Per quanto riguarda i retroterra linguistici, egli raffronta le considerazioni di Charles Kuhn sul termine 'essere' nella lingua greca e quelle di A.C. Graham sull'assenza di questa nozione nel cinese:
Sembra che nessuno dei due studiosi possa evitare di parteggiare per la lingua che egli studia e di apprezzarne la capacità di distoglierci dall'errore e condurci alla verità. Benché non concordino fra loro su ciò che bisogna considerare errore e ciò che bisogna considerare verità, entrambi ritengono che questi linguaggi non tendano a imporre, ma a predisporre, ossia che si limitino a facilitare l'articolazione di un genere di asserzione a svantaggio di un altro. Ritengo che dovremmo riconoscere il contenuto di verità di questo giudizio e accettarlo. (Scharfstein 1989, p. 120)
La storia sembra aver appreso la lezione di Newton; questo scienziato è noto per i risultati conseguiti nel campo della fisica e nelle aule scolastiche s'insegnano le sue leggi sul moto, ma soltanto gli storici sono a conoscenza delle credenze (o almeno di un certo numero di credenze) del loro scopritore. La scienza non deve essere legittimata dalle tradizioni o dai retroterra culturali, ma dai fatti e dalla logica; è soprattutto a questi ultimi che gli storici della scienza devono rivolgere la propria attenzione. La lezione di Newton spiega la rapida espansione della scienza in tutte le regioni del mondo, sia tra i popoli che possedevano una tradizione scientifica, sia tra quelli che ne erano privi, ma il suo intrinseco significato è più profondo. Pitagora era vegetariano e credeva nella metempsicosi, Kepler era un astrologo, Newton un alchimista, L.E.J. Brouwer un teosofo e Srinivasa Ramanujan, il più grande matematico indiano degli ultimi cinque secoli, attribuì i suoi teoremi a una dea venerata nell'India meridionale, Namagiri. Sulle convinzioni di moltissimi scienziati non sappiamo nulla, ma ciò non ha alcuna importanza perché la scienza è universale.
L'universalità della scienza è data dal fatto che essa mira alla ricerca della verità oggettiva; tra gli psicologi o i sociologi, così come tra molti storici, questo concetto non è molto popolare, ma gli scienziati in generale e gli storici della scienza in particolare non possono farne a meno. La realtà trascende gli individui e le civiltà perché sia gli individui sia le civiltà fanno parte della realtà. Dal momento che la verità non dipende da un luogo o da un periodo particolari, i migliori scienziati sono coloro che riescono a emanciparsi dai loro contesti e dai loro retroterra culturali. La ricerca della verità, tuttavia, non implica la scoperta di una verità conclusiva; al contrario, la verità è sempre soggetta a continue revisioni che devono essere effettuate alla luce delle nuove conoscenze. Lo studio delle scienze indiane conferma, sotto tutti gli aspetti, questi principî. Non sempre gli scienziati tengono conto della natura della vera conoscenza, e il più noto filosofo indiano, Śaṅkara (VIII sec. d.C.), ha enunciato questo concetto esplicitamente, con grande lucidità e con una concisione comparabile a quella dei più grandi filosofi: "La conoscenza della natura di una cosa non dipende dalle nozioni umane o da asserzioni prescrittive, ma dalla cosa stessa" (Brahmasūtrabhāṣya, 1.1.3).
I due esempi che presentiamo di seguito riguardano particolari forme di 'asserzioni prescrittive' e di 'nozioni umane', vale a dire la religione e la società. Constateremo che in India la religione aveva ben poco a che fare con la scienza, anche se poteva essere evocata come giustificazione o aggiunta in seguito come sovrastruttura, quasi come un ripensamento; è la stessa conclusione cui si giunge in alcuni dei capitoli che seguono. Così, nel cap. XVI, David G. White scrive che sebbene l'alchimia indiana, quanto a visione del mondo e assunti metafisici, sia eminentemente hindu, non si può negare che il mercurio, sua sostanza basilare, sia ovunque assente nel subcontinente indiano, eccetto che sotto forma di tracce. White prosegue affermando che una serie di istruzioni tutt'altro che scontate, ma sostanzialmente identiche, relative all'estrazione del mercurio, sono state rinvenute in testi siriaci (300-400 ca.), sanscriti (1150-1250 ca.) e cinesi (1600-1700 ca.). Queste analogie non dipendono dalle concezioni del mondo, ma dal "comportamento chimico dei reagenti stessi", cioè, "dalla cosa stessa" (vastutantram eva), per riprendere l'espressione di Śaṅkara. Allo stesso modo, nel cap. XVII Arun Kumar Biswas prende in esame la mineralogia e la metallurgia, nel cui sviluppo, che copre molti millenni e l'intero subcontinente, le etichette religiose non svolsero alcun ruolo. L'indipendenza della scienza dalla religione è illustrata anche nell'esempio relativo alla matematica e alla grammatica jaina; mentre in quello successivo si affronta la questione delle 'nozioni umane', vale a dire della società.
Un primo esempio: la matematica e la grammatica jaina
Nel cap. X dedicato alla matematica,Takao Hayashi afferma che gli scienziati jaina svolsero un ruolo di grande rilievo nello sviluppo della matematica indiana, precisando che ciò si spiega, almeno in parte, con il rigore religioso e il perfezionismo loro propri. Hayashi prosegue la sua analisi dimostrando che la geometria ebbe un ruolo molto importante nella cosmografia jaina, che prevedeva l'uso di numeri ancora più grandi di quelli maneggiati dagli hindu e dai buddhisti. I seguaci del jainismo usavano infatti numeri 'incalcolabili' e 'infiniti' accanto a quello che potrebbe essere definito il più piccolo cardinale transfinito, 'l'aleph zero' dei matematici moderni. L'uso di tali numeri nella matematica jaina appare legato alle caratteristiche di questo pensiero religioso, la loro esistenza però non dipende da esse, a meno di non voler supporre che George Cantor, lo scopritore delle gerarchie delle serie transfinite, non sia stato solamente l'ideatore di "un paradiso dal quale nessuno potrà scacciarci" (Boyer 1991, p. 570), ma anche un seguace del jainismo.
Non soltanto i seguaci del jainismo trattarono gli stessi numeri degli adepti di altre religioni, ma le diverse sette jaina usarono la stessa geometria. Il matematico jaina Vīrasena, il quale faceva parte della setta Digambara ('i cielo-vestiti'), usò la geometria per tentare di confutare la setta rivale Śvetāmbara ('i bianco-vestiti'). Quest'ultima sosteneva una particolare concezione relativa alla forma geometrica dell'Universo e Vīrasena s'impegnò a demolirla attraverso complesse costruzioni di geometria solida (tra cui menzioniamo, per es., la scomposizione del pentaedro in un prisma triangolare e in un numero infinito di prismi rettangolari).
Hayashi, inoltre, ricorda che i nomi attribuiti da Mahāvīra alle posizioni delle cifre decimali e il suo calcolo dell'area di una figura piana a forma di conchiglia derivavano dalle opere canoniche del jainismo, dimostrando così che l'universalità della matematica non si estende alla sua terminologia o al suo linguaggio, né determina i problemi da sottoporre all'indagine.
Questi esempi attestano che i seguaci del jainismo diedero un grande contributo allo sviluppo della matematica; tuttavia tali contributi non sono 'jaina', non più di quanto siano 'ebraici'. L'espressione 'scienza ebraica' è stata inventata dai nazisti e la definizione 'matematica jaina' risale ai nostri giorni. La differenza consiste nel fatto che, diversamente dai nazisti, noi non crediamo che questa etichetta denoti un 'genere' diverso di matematica. Lo stesso vale per la definizione più generale di 'scienza indiana', espressione che non indica una particolare varietà di scienza, ma semplicemente la 'scienza' così come era studiata dagli Indiani.
Sembra che i contributi dei saggi jaina alla scienza indiana del linguaggio siano stati meno importanti. George Cardona introduce questo tema nel cap. XIII prendendo in esame la più antica grammatica jaina sopravvissuta, il Jainendravyākaraṇa (Grammatica di Jinendra, probabilmente redatto verso la metà del V sec. d.C.); richiamandosi allo studio condotto nel 1881 da Kielhorn, Cardona afferma che questo testo "è di scarso interesse dal punto di vista teorico". Conviene citare di seguito due osservazioni di Kielhorn che chiariscono tale questione; inizieremo dalla seconda, che concerne i progressi compiuti dai grammatici più tardi: "In effetti, per i grammatici più tardi non era facile aggiungere qualcosa di nuovo al patrimonio di conoscenze accumulate da Pāṇini, Kātyāyana e Patañjali; tuttavia non mancarono gli studiosi che tentarono di perfezionare l'ordinamento dell'Aṣṭādhyāyī e che svolsero, anche se in modi diversi, un lavoro utile". Questa osservazione segue quasi come un ripensamento la prima, che è molto esplicita: "A questo proposito potrei osservare che tra le diverse grammatiche di cui ho potuto prendere visione, nessuna è più priva di originalità e di valore del Jainendra" (Kielhorn 1881, p. 76).
Il Jainendravyākaraṇa si distingue per l'uso di forme abbreviate fini a sé stesse e per il suo ottuso senso dell'economicità. Incidentalmente, ciò avvalora la tesi formulata nel 1979 da Paul Kiparsky, secondo cui Pāṇini aveva operato una distinzione sistematica fra tre livelli di opzionalità delle forme linguistiche mediante i termini vā, vibhāṣā e anyatarasyām, che sfuggirono all'attenzione di Patañjali e dei grammatici più tardi: orbene, anche nel Jainendra le ultime due espressioni sono state soppresse e si è conservato soltanto il termine vā.
Il secondo grammatico jaina che viene preso in esame da Kielhorn e Cardona è Śākaṭāyana. Come l'autore del Jainendra, Śākaṭāyana appare molto interessato all'economicità e alle abbreviazioni; come ha dimostrato Kielhorn (1881), gran parte del suo lavoro fu copiato dal più celebre grammatico jaina, Hemacandra, a proposito del quale Cardona si limita a osservare quanto segue: "Come nella maggior parte delle sue numerose opere, [anche qui] Hemacandra non dimostra grande originalità".
In conclusione si può affermare che né i contributi scientifici dei matematici jaina, che furono indubbiamente brillanti, né quelli dei grammatici jaina, che furono mediocri, avevano molto a che fare con la loro religione.
Un secondo esempio: i Namputiri del Kerala
Benché molto interessante, la descrizione sommaria del retroterra sociale della celebre scuola di Mādhava, di cui fecero parte molti matematici del Kerala, conduce alla conclusione che, come la religione, la società ha ben poco a che fare con la scienza. Questa conclusione non concorda tuttavia con quelle di altre opere dedicate alla sociologia della scienza.
La società in cui operarono molti matematici del Kerala presentava molti aspetti curiosi e forse persino unici. Questi studiosi appartenevano a una classe privilegiata che dominava la gerarchia sociale; erano brahmani estremamente ortopratici, ossia 'interessati a fare cose giuste', più che ortodossi, cioè 'sostenitori di opinioni giuste'. La maggior parte dei membri della scuola di Mādhava apparteneva alla casta Namputiri, anche se lo stesso Mādhava era un Emprantiri, faceva parte cioè di un'altra casta brahmana, originaria di una regione del Karnataka meridionale che confinava con il Kerala settentrionale. I brahmani Emprantiri sono sempre stati poco numerosi. Secondo C.A. Innes, un membro britannico dell'amministrazione statale indiana che, nel 1908, compilò il volume dedicato al Malabar del District Gazetteer (Dizionario geografico regionale) di Madras, gli Emprantiri erano una comunità particolarmente arretrata, almeno a giudicare in base a criteri occidentali (Innes 1951).
La casta Namputiri era la più importante casta brahmana del Kerala ed era rigorosamente patrilineare. Prima della legislazione del 1933, all'interno di questa comunità soltanto i primogeniti erano autorizzati a sposarsi legalmente, potevano cioè contrarre un matrimonio vedico (vivāha). La maggior parte delle figlie rimaneva nubile e tutti i figli cadetti stabilivano 'alleanze matrimoniali' (sambandha) con altre caste alte (famiglie aristocratiche dei Nayar o le cosiddette caste 'intermedie'), per lo più matrilineari. I figli nati da queste unioni appartenevano alla casta materna, non potevano pranzare o bagnarsi con i loro padri Namputiri, i quali, a loro volta, non potevano mangiare il cibo preparato dalle mogli. Questo sistema rafforzò le relazioni non rituali con le altre caste superiori, preservando, al tempo stesso, l'integrità del patrimonio ancestrale, che ‒ in assenza di eredi legittimi ‒ dopo la morte del primogenito passava al fratello minore. I fratelli più giovani trascorrevano la notte con le loro mogli e la maggior parte del giorno nella casa d'origine.
Grazie alla relativa prosperità materiale di cui godevano, molti figli cadetti dei brahmani Namputiri poterono dedicarsi alla scienza, alla filosofia, alla letteratura e alle arti. Secondo K. Kunjunni Raja, a sua volta figlio di un Namputiri, la primogenitura "contribuì non soltanto a preservare l'integrità della proprietà terriera, ma anche a creare una classe agiata di intellettuali brahmani che, non dovendo occuparsi dei problemi della vita quotidiana, poté dedicare tutto il suo tempo e la sua energia ai riti religiosi e allo studio della letteratura e delle belle arti" (Kunjunni Raja 1983, p. 301).
Le grandi famiglie Namputiri, all'interno delle quali il fratello più anziano compiva i suoi doveri rituali e secolari e i fratelli minori si dedicavano ai loro passatempi preferiti, erano solite ospitare membri della propria e di altre caste alte, con cui condividevano i propri interessi non nel campo delle pratiche vediche, ma certamente in quelli della matematica, dell'astronomia e dell'astrologia. Questa circostanza spiega perché alcuni matematici del Kerala appartenevano a caste intermedie, quali i Pisharoti o i Poudval. Alcune dimore Namputiri divennero veri e propri centri culturali e ospitarono grandi collezioni di libri: per es., nella biblioteca Deśamaṅgalam, descritta da K.V. Sarma (1993), erano conservati 1640 manoscritti che a loro volta contenevano fra i cinquemila e i seimila testi. L'esame del contenuto e delle caratteristiche di questi manoscritti consente di individuare i temi più studiati dai Namputiri; il nucleo della biblioteca era costituito da opere dedicate ai Veda, al rituale, alla poesia, alla letteratura drammatica e in genere alle belles lettres. In campo scientifico, dopo la grammatica, le discipline più rappresentate erano l'astronomia, la matematica, la medicina, la critica letteraria e la logica. Nel 1985 David Pingree ha messo in luce l'importanza di alcuni aspetti dell'organizzazione sociale Namputiri nel successo, straordinario anche se isolato, della scuola matematica del Kerala, e ha sottolineato anche la natura giocosa dei matematici del Kerala: "un uomo come Mādhava probabilmente si dedicò a questa disciplina semplicemente perché lo dilettava". Sfortunatamente, non sappiamo molto dei caratteri degli scienziati indiani del passato; in conclusione però si può dire che le scoperte della scuola di Mādhava furono facilitate, ma non determinate, dalla singolare struttura sociale della casta brahmana Namputiri.
Universalità, astrazione e Rivoluzione scientifica
Nei paragrafi precedenti si è accennato all'importanza attribuita da Needham al "grande movimento progressivo della scienza naturale di tutta l'umanità": una posizione accettabile, a condizione, tuttavia, di aggiungere alla 'scienza naturale' le scienze umane e sociali e di combinare il 'grande movimento' con una serie di sviluppi tortuosi e di vicoli ciechi. Com'è stato già osservato (v. sopra), la stessa scoperta può condurre a ulteriori scoperte in una certa civiltà e a una fase di stagnazione in un'altra. È giusto quindi parlare di un 'grande movimento progressivo', ma, discendendo dalle vette olimpiche di tutta l'umanità alla concretezza dei dettagli storici e geografici, s'individuano movimenti in diverse direzioni. Per esempio, nella trasmissione delle scienze sono state riconosciute interazioni complesse tra diverse aree culturali e, nell'ambito di questo processo, l'India ha svolto un ruolo estremamente importante e attivo di ricezione, di trasformazione e di trasmissione. Né si può sottovalutare il ruolo 'propulsore' svolto dalla civiltà indiana, come testimoniano l'invenzione dei simboli numerici, del sistema decimale posizionale che includeva lo zero e dei metodi di calcolo basati su tale sistema, invenzione definita da Kurt Vogel (1963, p. 42) "un contributo essenziale allo sviluppo della civiltà e una delle più grandi conquiste dell'intelligenza umana". Altrettanto significativo è stato il contributo dell'India alla scienza del linguaggio. A prescindere dall'esistenza di legami storici tra la linguistica e la matematica, queste discipline presentano una serie di analogie dal punto di vista concettuale, esemplificate dal caso dello 'zero'.
Lo 'zero linguistico', o 'grammaticale', fu scoperto da Pāṇini o dai grammatici sanscriti che operarono nel periodo precedente. Questa scoperta nacque da un processo di generalizzazione delle regole, come, del resto, il suo equivalente matematico, il 'numero zero'. Lo zero linguistico può essere individuato anche nella lingua inglese: supponendo che tutti i nomi singolari inglesi possano essere trasformati in plurali attraverso l'aggiunta di un 'suffisso plurale' che indicheremo con x, non definiremo la parola sheep (che è invariabile al plurale) come un'eccezione, ma affermeremo che nella parola sheep 'x=0'. Anche lo zero matematico deriva da una generalizzazione. Precisamente, definendo la sottrazione in generale con 'a−b=x', non descriveremo il caso in cui 'a=b' come un'eccezione, ma affermeremo che se 'a=b' allora 'x=0'.
Pāṇini scoprì la necessità di postulare diversi tipi di zero linguistico, ugualmente 'invisibili' ma dotati di proprietà diverse. Egli avrebbe descritto, per esempio, la trasformazione in plurali dei tre seguenti sostantivi inglesi, i cui plurali non si formano semplicemente aggiungendo una 's', introducendo tre diversi tipi di zero:
sheep + plurale → sheep + 0′ → sheep,
mouse + plurale → mouse + 0″ → mice,
woman + plurale → woman + 0‴ → women.
Questi tre tipi di zero sono diversi tra loro perché il primo lascia invariato il sostantivo, mentre gli altri due lo modificano in modi diversi.
La prima testimonianza dell'uso dello zero matematico sia come numero sia come simbolo risale al VI sec. d.C.; Pāṇini invece scoprì differenti tipi di zero linguistico mille anni prima e per definirli usò nomi diversi da quelli usati per lo zero matematico. Il retroterra concettuale dello zero matematico può essere posto in relazione alla nozione buddhista di vacuità (śūnyatā; Ruegg 1978) ed è in ogni caso molto complesso; sappiamo, tuttavia, che tutti gli scienziati indiani che usarono la lingua sanscrita conoscevano a fondo Pāṇini o altri grammatici sanscriti e possedevano la nozione dello zero grammaticale. è probabile, quindi, che la scoperta dello zero matematico sia stata almeno in parte ispirata da quella del suo più antico equivalente grammaticale; tuttavia, non esiste alcuna testimonianza al riguardo. In ogni caso, lo zero fu scoperto in modo autonomo in diverse civiltà, non tutte storicamente in contatto tra loro, dal momento che quella maya, geograficamente e storicamente isolata dal continente eurasiatico, disponeva non soltanto di un sistema posizionale, ma anche di un simbolo che indicava lo zero.
I rapporti esistenti tra la linguistica e la matematica indiane possono essere individuati soltanto a un livello relativamente elevato di astrazione. Abbiamo già ricordato che l'India era più avanzata della Cina nel campo delle scienze astratte e teoriche come, per esempio, la matematica, la logica e la linguistica. Ma l'astrazione è una virtù? Dobbiamo tener conto che secondo gli studiosi l'astrazione non è uno strumento neutro in quanto è stato variamente utilizzato (alcuni ritengono che sia "un programma di ricerca di grande successo", Elzinga 1999, p. 81). In realtà, certi programmi di ricerca riguardano temi astratti e altri hanno come oggetto cose concrete, come, per esempio, le specie rare o i linguaggi, ma nessuno di questi due generi di programma è destinato a un sicuro successo. A prescindere dai programmi di ricerca e dagli usi impropri di questo concetto, la scienza non può esistere senza l'astrazione e nessuno studioso delle scienze indiane può evitare di considerare con grande serietà questa nozione.
L'astrazione è applicabile alla realtà perché rivela strutture implicite o altre forme di ricorrenza regolari non immediatamente visibili o completamente invisibili. Descrivendo il 'punto' come 'ciò che non ha parti' e la linea come 'ciò che si estende nel senso della sola lunghezza', Euclide era consapevole di non riferirsi al mondo concreto, ma di elaborare una 'idealizzazione' astratta che gli avrebbe consentito di afferrare le caratteristiche del mondo concreto. Anche la tesi secondo cui la Terra è una sfera è un'astrazione idealizzante di questo genere; essa consente di spiegare perché lo stesso punto possa essere raggiunto attraversando la superficie terrestre nella direzione opposta, una congettura che a sua volta spiega perché Colombo navigò verso ovest per raggiungere l'Oriente. In Occidente, Aristotele per primo fece uso del termine aphaíresis in senso moderno riferito agli oggetti matematici come 'cose arrivate all'astrazione'.
Per comprendere il concetto di astrazione può essere utile prendere in esame il caso di un grande pensatore che non lo aveva compreso, vale a dire Friedrich Nietzsche. In Umano, troppo umano, un'opera giovanile redatta tra il 1878 e il 1879, quando il filosofo occupava ancora la sua cattedra presso l'Università di Basilea ed era alle soglie del percorso che lo avrebbe portato a criticare il razionalismo illuministico, Nietzsche sottolinea gli effetti negativi del linguaggio, collegandoli alla scienza. Verso la fine di un breve paragrafo intitolato Il linguaggio come presunta scienza, egli afferma che l'uomo usa il linguaggio per creare un nuovo mondo che sovrapponendosi all'altro (il mondo esterno) gli consente di ergersi a sovrano di quest'ultimo (v. Genesi, 2, in cui Adamo attribuisce un nome agli animali). Gli esseri umani credevano che le loro parole esprimessero il più elevato livello di conoscenza delle cose; "molto più tardi ‒ soltanto adesso ‒ agli uomini balena questo, che essi hanno propagato, nella loro credenza nel linguaggio, un enorme errore" (Umano, troppo umano, I, 11).
Forse Nietzsche intendeva sostenere che il linguaggio rappresenta la prima forma di conoscenza sistematica e che quindi esso può essere considerato la prima scienza, ma che come tale è inadeguato. Il paragrafo citato prosegue così:
Anche la logica poggia su premesse a cui nulla corrisponde nel mondo reale, per esempio sul presupposto della uguaglianza delle cose, dell'identità della stessa cosa in diversi punti del tempo; ma quella scienza sorse dall'opposta fede [che ci fossero veramente cose simili nel mondo reale]. Così stanno le cose anche per la matematica, che certamente non sarebbe sorta se si fosse saputo sin da principio che in Natura non esiste né una linea esattamente retta, né un vero cerchio, né un'assoluta misura di grandezza. (ibidem)
La profonda conoscenza del carattere idealizzante dell'astrazione dimostrata da Euclide è sufficiente a confutare la tesi di Nietzsche. La più fondata obiezione che può essere opposta alla sua critica della matematica e della logica è che essa può essere applicata allo stesso linguaggio naturale. I termini 'albero' e 'triangolo' non indicano oggetti particolari bensì una classe di oggetti. Ogni parola è un'astrazione che si riferisce a una molteplicità di cose, a volte a un numero infinito di cose concrete. Se i nomi si riferiscono alle cose, i verbi, poi, si riferiscono ad azioni identiche nei diversi punti dello spazio e del tempo. Pur con le dovute precisazioni, questa nozione è abitualmente usata dai filosofi moderni che hanno studiato la logica e non era sconosciuta ai linguisti e ai logici indiani, che da Patañjali a Dignāga e oltre si domandarono se le parole designassero cose particolari o classi di cose (per es., Hattori 1968). La nozione di astrazione non è soltanto implicita nel linguaggio, ma è anche usata nella scienza del linguaggio; essa è connessa al concetto di 'zero' ed è alla base della categoria dei sūtra o 'regole'.
Questa nozione è connessa anche ad altri concetti le cui connotazioni sono frequentemente messe in discussione, per esempio al 'riduzionismo', un concetto di cui non possono fare a meno molte scienze che non si limitano alla semplice descrizione dei fenomeni e che postulano l'esistenza di una realtà a cui i fenomeni devono essere 'ridotti' (come, per es., il calore deve essere ridotto al moto). Criticare il riduzionismo per la sua tendenza a ridurre ogni fatto ai suoi elementi essenziali, afferma W.V. Quine, "equivale a criticare la fisica per la sua incapacità di catturare la ricchezza della foresta pluviale" (Quine 1981, p. 186). Un esempio di riduzionismo riscontrabile, benché soltanto a un livello speculativo, sia in India sia nell'Antichità classica occidentale, ma non attestato in Cina, è rappresentato dalla teoria atomistica che ha raggiunto l'apice del suo trionfo con la riduzione del mondo fisico all'equazione di Schrödinger e con quella delle forme della vita al DNA.
Come le definizioni euclidee del punto e della linea, le leggi del moto di Newton sono splendide illustrazioni della caratteristica capacità di astrazione della spiegazione scientifica che fuorviò Nietzsche e che seguita a confondere e a irritare alcuni dei nostri contemporanei. Si potrebbe supporre che nel caso di Newton la misteriosa apparizione di queste leggi sia stata provocata o favorita dall'uso del linguaggio artificiale della matematica, ma si dà il caso che esse siano state formulate in latino. Chiaramente enunciata in un linguaggio naturale compreso da molti, la sua ipotesi gravitazionale, poco familiare, astratta e distante dalla vita di tutti i giorni, colpì, con la stessa potenza di un fulmine, l'immaginazione dei suoi contemporanei. Nella maggior parte dei casi, le cose cadono o scivolano verso il basso fino ad arrestarsi e soltanto allora rimangono ferme; non si muovono però praticamente mai in modo uniforme e rettilineo, come affermano le leggi di Newton.
I risultati di Newton contraddicono l'ipotesi aristotelica secondo cui "tutto ciò che si muove è mosso da qualcosa" su cui si basava la tesi della separazione del cielo e della Terra. Essi non soltanto dimostrarono l'unicità dell'Universo, ma erano compatibili con l'idea secondo cui esisteva un parallelismo tra microcosmo e macrocosmo, idea riscontrabile in India, in Cina, nel neoplatonismo, nello gnosticismo, nel Corpus Hermeticum e altrove. Benché Einstein abbia confutato Newton, questo parallelismo speculativo seguita ad adattarsi perfettamente alla fisica: non soltanto è stata dimostrata l'esistenza di orbite degli elettroni e di altre onde o particelle contenute negli atomi che sono analoghe alle orbite dei pianeti, delle stelle e delle galassie, ma l'intero sviluppo della cosmologia e dell'astrofisica contemporanee a partire dalla fisica delle particelle può essere considerato una perfetta illustrazione di questa tesi.
Il parallelismo tra microcosmo e macrocosmo è una caratteristica delle filosofie tradizionali, ampiamente basate su vane speculazioni e infarcite di miti; occorre quindi operare una distinzione tra miti 'fuorvianti' e miti 'utili': la separazione della Terra dal cielo è una mitologia del primo tipo, perché ostacola il progresso della conoscenza; l'idea secondo cui il microcosmo riflette il macrocosmo dell'Universo è invece una mitologia innocua o persino utile. Il mito descritto nelle Upaniṣad e nei testi buddhisti secondo cui la struttura dell'uomo è formata da cinque 'guaine' che ricordano quelle delle cipolle è meno nocivo del mito europeo in base al quale l'uomo è costituito da un corpo e da una mente perché il numero cinque è meno limitato del numero due; naturalmente, la realtà è più complessa di quella descritta da entrambi i miti (Staal 1993b).
Joseph Needham ha spesso sostenuto che le affermazioni mistiche contenute nelle opere taoiste, gnostiche, ermetiche e alchimistiche sono compatibili con la concezione scientifica secondo cui vi è soltanto un Universo. La sua analisi delle concezioni cinesi abbonda di sagaci osservazioni sulle analogie esistenti tra queste ultime e le idee nate in altre regioni del mondo; secondo Needham, per esempio, la tesi enunciata nella Tabula smaragdina, un testo alchimistico redatto nel III sec. nell'Egitto cristiano, in base alla quale "ciò che si trova in basso è simile a ciò che si trova in alto" esprime una 'dottrina corretta', al contrario dell'asserzione di Tommaso d'Aquino secondo cui "una piccola conoscenza delle cose più elevate ha più valore della più grande conoscenza di cose poco elevate e piccole". Needham paragona questa idea alla concezione buddhista volta in ridicolo nell'XI sec. da Cheng Ming-Tao: "Se si sforzano soltanto di conoscere le cose elevate senza studiare ciò che si trova in basso, come possono raggiungere una conoscenza corretta delle cose elevate?" (Needham 1956, p. 299).
Wilhelm Rau (1986) ha sostenuto che il principale ostacolo all'apparizione della scienza moderna in India era costituito dal desiderio di individuare simmetrie e analogie, oltre che dalla speculazione sul parallelismo tra il microcosmo e il macrocosmo considerato il modello della perfetta armonia a prescindere dall'esperienza e dalla sperimentazione. È vero che l'idea di perfetta armonia è essenzialmente speculativa, ma Rau non tiene conto del fatto che essa è coerente con lo sviluppo della scienza e non ne ostacola il percorso; è un mito utile, anche se non fornisce una risposta all'interrogativo su cui ci accingiamo a ritornare: perché la scienza moderna è nata in Europa e non in Asia?
Alcuni storici hanno sostenuto che il problema dell'origine europea della scienza o della cosiddetta 'rivoluzione scientifica' europea è privo di interesse o non è un vero problema, al contrario delle questioni relative ai rapporti tra la scienza e i contesti o i retroterra culturali, religiosi, linguistici, sociali e politici (Sivin 1982; Graham 1989; Elzinga 1999). Needham ha espresso un'opinione opposta; per questo studioso il più importante interrogativo a cui fornire una risposta era indubbiamente il seguente: "Perché la Rivoluzione scientifica non ha avuto luogo in Cina?"; talvolta egli enunciò negli stessi termini questo interrogativo in relazione all'India.
Una delle prime formulazioni di questa domanda di Needham risale al 1936, anno in cui la sua amicizia con tre giovani scienziati cinesi giunti a Cambridge lo condusse alla seguente riflessione: "Il fatto che la loro intelligenza scientifica fosse così simile alla mia fece emergere chiaramente nella mia coscienza il problema relativo ai motivi per cui la scienza moderna è nata esclusivamente in Europa e non in Cina o in India" (Elzinga 1999, p. 94). Durante la sua lunga carriera, nell'opera monumentale, così come in altre pubblicazioni, Needham ha preso in esame un gran numero di risposte diverse a questo interrogativo. In un primo momento pensò che tale questione fosse legata al fatto che in Cina non era mai esistita l'idea europea (sia greca sia cristiana) di legge divina o di ispirazione divina (Needham 1951). In seguito, tuttavia, egli osservò che fino al XVI sec. la matematica e la conoscenza della Natura avevano avuto uno sviluppo analogo in Cina e in Europa ‒ e potremmo aggiungere in India ‒ rimanendo, tuttavia, separate tra loro. In seguito, afferma Needham, la scienza moderna si sviluppò in Europa perché soltanto in quest'area la matematica era applicata alla conoscenza della Natura. Molti studiosi non hanno accettato questa spiegazione; in particolare, l'obiezione secondo cui questa tesi non poteva essere applicata alle scienze della vita turbò sempre Needham, in quanto egli sosteneva che il principale merito della scienza cinese fosse la sua visione organicistica. Con la scoperta del DNA e lo sviluppo della linguistica moderna, la matematica è stata però applicata tanto alle scienze della vita quanto alle scienze umane e sono venuti meno i presupposti di queste obiezioni.
Il 'grande quesito' di Needham si rivela ancora più enigmatico nel caso dell'India. Come si è detto, il livello raggiunto dalla matematica indiana era vicino a quello conseguito dalla matematica europea nel corso della rivoluzione scientifica. La risposta di Needham pure in questo caso si rivela corretta, anche se a certe condizioni che saranno discusse più avanti. Bisogna, tuttavia, prendere in esame un problema connesso a tale questione, sul quale Needham ha riflettuto anche se in modo non esauriente: la 'geografia' della Rivoluzione scientifica. Questo problema è stato messo in luce da A.C. Graham, non da uno specialista della scienza cinese quindi, ma da un eminente sinologo, noto per le sue traduzioni di opere poetiche cinesi, per le sue indagini sulla grammatica e sulla filosofia cinese, per essere stato il primo a dare un senso alla logica moista e per le sue ricerche filosofiche in generale. Dopo aver osservato che la combinazione tra la matematica greca e quella indiana era una condizione necessaria, ma non sufficiente alla genesi della scienza moderna, Graham dichiara:
La Rivoluzione scientifica si presenta come un evento unico e complesso, influenzato da condizioni sociali e di altro genere, tra le quali va segnalata la confluenza di scoperte (greche, indiane, cinesi, arabe, in qualche caso persino romane) originate dalla combinazione dell'aritmetica e dell'algebra indiana con la logica e la geometria greca. Dal momento che questa combinazione decisiva si affermò, per ragioni prevalentemente geografiche, tra gli Arabi, per poi diffondersi nella Cristianità latina, è inutile domandarsi perché la Rivoluzione scientifica non abbia avuto luogo in altre regioni del mondo. Mi sembra che l'intera questione delle ragioni per cui i Cinesi non siano mai giunti all'elaborazione della scienza moderna sia un falso problema. (Graham 1989, p. 317)
Questa prospettiva, benché ammirevole per la sua acutezza, non dimostra che tutti i problemi in questione sono falsi problemi, ma li rende, al contrario, ancora più interessanti. La descrizione geografica di Graham è più equilibrata di quella di Needham e non contraddice l'analisi di quest'ultimo, secondo cui 'la combinazione decisiva' consistette nell'applicazione della matematica alla conoscenza della Natura. Ma perché questa 'combinazione decisiva' fu determinata da ragioni prevalentemente 'geografiche'? La risposta è in parte ovvia: a causa delle conquiste arabe. Queste ultime, infatti, furono un importante fattore della "convergenza tra Oriente e Occidente nel periodo compreso tra il 1200 e il 1400", per menzionare l'espressione usata nell'Historical atlas of South Asia (mappa V1c) di J.E. Schwartzberg (1978). L'area compresa tra la Spagna e il Giappone, in questa rappresentazione grafica, coincide in gran parte (se si esclude l'Asia orientale) con quella della civiltà globale islamica, che includeva anche quella che era stata la regione della cosiddetta scienza 'ellenistica'.
È sufficiente gettare uno sguardo allo 'spazio' di questa 'convergenza' per comprendere l'affermazione di Needham secondo cui la rivoluzione scientifica avrebbe potuto aver luogo soltanto in un'area interna o vicina ai confini di questo spazio. Il fattore decisivo quindi non era lo spazio ma il tempo, come ha dimostrato Marshall Hodgson (1974), che ha studiato la civilizzazione e la società islamica nella prospettiva della 'storia globale'. Secondo Hodgson, nel corso del XII e del XIII sec. "la società islamica e quella cristiana avevano raggiunto all'incirca lo stesso livello di crescita e non è facile capire in quale delle due società abbia avuto origine il nuovo sviluppo" (Hodgson 1974, p. 365). Egli ha quindi spiegato in modo molto eloquente che non è corretto parlare dell'impatto dell'Occidente sul resto del mondo e che bisognerebbe invece riconoscere che qualcosa di nuovo (che egli definisce 'la grande trasmutazione') si verificò nel mondo, qualcosa che doveva necessariamente manifestarsi per la prima volta in un certo luogo in un dato momento storico. La sua spiegazione non soltanto chiarisce perché la Rivoluzione scientifica ebbe luogo in questo periodo, ma anche la circostanza per cui dopo essersi prodotta per la prima volta essa si diffuse ovunque. Uno dei corollari di questa concezione è che il verificarsi della Rivoluzione scientifica non riflette, così come non rivela, una gerarchia di popoli e di culture. Ernest Gellner, che ricorre alla nozione relativistica di 'stile', tenta di spiegare questa tesi: "Non siamo in presenza del sottoprodotto del corredo genetico di un particolare insieme di popolazioni. La popolazione o la cultura all'interno della quale questo stile ebbe origine sarebbe stata del tutto incapace di produrlo poche generazioni prima; dal momento della sua apparizione, questo stile fu acquisito con facilità da altre popolazioni" (Gellner 1995, p. 49).
Se la prospettiva corretta non è quella spaziale bensì quella temporale ‒ e le testimonianze indiane confermano indubbiamente questa tesi ‒ il carattere più interessante della rivoluzione scientifica non va ricercato nel 'luogo' ma nel 'momento' della sua apparizione. Dobbiamo quindi combinare le prospettive di Hodgson e di Gellner tra loro e con quelle di Needham e Graham. Sostituendo l'avverbio 'là' con l'espressione 'in quel periodo', l'affermazione di Needham acquista un nuovo spessore: 'la scienza moderna si è sviluppata nel corso del XVI e del XVII sec. perché soltanto in quel periodo la matematica iniziò a essere applicata alla conoscenza della Natura'. Negli anni in cui iniziò a elaborare in termini più precisi la sua idea, lo stesso Needham si era orientato in questa direzione e spiegava che la matematica stessa doveva essere trasformata: "le entità matematiche dovevano essere avvicinate alla fisica, messe in movimento e considerate non nel loro essere, ma nel loro divenire o come 'flusso'. Il calcolo infinitesimale elaborato da Newton (1665) e da Leibniz (1684) non era che il coronamento di questa tendenza" (Needham 1959, p. 155).
Gli sviluppi manifestatisi in Europa dimostrano che le ricerche indiane sulla serie di potenze contribuirono ad aprire la strada al calcolo; il caso dell'India diviene così ancora più enigmatico: la scuola di matematica di Mādhava del Kerala, infatti, aveva scoperto la serie di potenze di π e di alcune funzioni trigonometriche nel XV secolo. Nel cap. X Hayashi afferma che nel XII sec. Bhāskara II già usava una relazione equivalente al differenziale d(senα)=cosαdα, e questo notevole livello di precisione ripropone l'interrogativo sul perché in India non siano maturate le condizioni necessarie all'emergere della Rivoluzione scientifica.
Origine e sviluppo dei linguaggi artificiali
La scienza indiana può essere compresa soltanto se esaminata in una prospettiva globale, e proprio adottando questo punto di vista Needham ha probabilmente dato il suo contributo più duraturo alla storia della scienza. Catherine Jami, che ne ha criticato le concezioni relative alla cronologia della matematica cinese, elaborate più di cinquant'anni fa e quindi suscettibili di una revisione alla luce delle successive scoperte, si è mostrata molto esplicita sulla questione: "le recenti ricerche hanno confermato la tesi centrale di Needham, secondo cui nello studio della scienza antica e medievale, il continente eurasiatico deve essere considerato come un tutto e non diviso in una serie di culture impermeabili" (Jami 1999, p. 265). Per rafforzare tale affermazione, Jami ricorda che lo sviluppo delle serie di potenze delle funzioni trigonometriche nella matematica cinese è da attribuire a un astronomo della corte imperiale mongola del XVIII sec., Minggantu; questa conclusione decreta la sconfitta del relativismo, nella misura in cui esso presuppone che gli Arabi, i Cinesi, gli Europei e gli Indiani vivessero in mondi cognitivi separati (Staal 1998).
Nello studio della matematica antica e medievale, la tesi secondo cui il continente eurasiatico deve essere considerato come un tutto invece che come una serie di culture tra loro impermeabili non può essere considerata rivoluzionaria. Nell'ormai celebre History of mathematics, Carl B. Boyer e Uta C. Merzbach aprono il capitolo dedicato all'Europa nel Medioevo con una sezione intitolata 'Dall'Asia all'Europa' che si conclude con questo brano:
Una visione storica prevalentemente incentrata sull'Europa ha spesso condotto a una descrizione semplicistica del Medioevo; ricordiamo quindi ai lettori che gran parte della storia della matematica si deve a cinque grandi civilizzazioni, che usavano cinque lingue diverse. Nei due capitoli che precedono abbiamo descritto i contributi di tre delle più importanti culture medievali, la cinese, l'indiana e l'araba. In questo capitolo prenderemo in esame le tradizioni matematiche delle altre due: (1) l'Impero Orientale o bizantino, che aveva il suo centro nella città di Costantinopoli (o Bisanzio) e in cui il greco era la lingua ufficiale; (2) l'Impero Occidentale o romano, privo di un centro e in cui si parlavano diverse lingue, ma in cui il latino era la lingua franca degli studiosi. (Boyer 1991, p. 246)
In questo passaggio, gli autori accennano (implicitamente ed esplicitamente) alle cinque grandi lingue classiche del continente eurasiatico, che possiamo dividere in due gruppi. Il primo è costituito dal cinese, dal sanscrito e dal greco, vale a dire da lingue classiche diffuse anche oltre i confini delle loro aree d'origine, anche se in misura limitata: il cinese era usato per scopi scientifici anche in altre regioni dell'Asia orientale; il sanscrito era usato nell'Asia sudorientale e il greco come linguaggio 'comune' in quella che (soltanto per questa ragione e quindi in modo improprio) è stata definita la regione dell'ellenismo (intendendo con questo termine, seguendo O. Neugebauer [1957], anche la scienza mesopotamica). Le tre aree in questione erano relativamente omogenee dal punto di vista della cultura e della civilizzazione, ma all'interno di ciascuna di esse si usavano anche altre lingue oltre a quella classica, che era il principale veicolo di espressione dei testi scientifici. Il secondo gruppo comprende l'arabo e il latino. L'arabo era usato come mezzo d'espressione di opere scientifiche nate all'interno di tre culture diverse: greco-romana, giudaico-cristiana e indo-iranica; queste opere includevano quanto sopravviveva o era accessibile della scienza ellenistica. Il latino era usato, come l'arabo, per trasmettere le opere degli scienziati che avevano operato nel contesto culturale greco-romano o in quello giudaico-cristiano, e assimilò anche una parte non trascurabile dell'eredità araba. Gli scienziati che scrivevano in latino parlavano anche diverse altre lingue; da questo punto di vista, l'arabo e il latino, pur non essendo lingue universali, erano quindi più cosmopolite del cinese, del sanscrito o del greco.
Le cinque lingue classiche, soprattutto nei casi in cui erano usate per enunciare verità scientifiche, svilupparono una serie di idiomi formali, ma non sufficientemente formali per operare come veicoli di una rivoluzione scientifica. Inoltre, nessuna di queste lingue divenne effettivamente globale o universale (come, del resto, l'arabo, il cinese o l'inglese nel mondo contemporaneo). Effettivamente globale e universale divenne invece il linguaggio della matematica, così come altri tipi di linguaggio artificiale o formale che però, proprio in quanto 'artificiali', sono integralmente formali e quindi piuttosto differenti da quelli 'naturali' e non rispondono dunque alle condizioni o ai requisiti del 'linguaggio universale' teorizzato dai linguisti. In effetti, i linguaggi artificiali non sono del tutto diversi da quelli naturali e dipendono, in una certa misura, da essi, precisamente dalle loro proprietà 'universali', ovvero, non dai caratteri distintivi di questo o quel linguaggio. Non sappiamo molto riguardo a questo rapporto di dipendenza, ma possiamo individuarne un esempio piuttosto semplice nel processo di transizione dai 'predicati' alle 'funzioni'. Nei linguaggi naturali, la distinzione tra il soggetto e il predicato è una caratteristica universale; benché vi siano state lunghe discussioni sui cosiddetti linguaggi 'configurativi', che sembrano costituire un'eccezione a questa regola, l'ipotesi dell'universalità del soggetto e del predicato, infatti, non è stata più seriamente messa in discussione dopo Noam Chomsky (1965, 1986; Staal 2001).
La prova che i predicati dei linguaggi naturali costituiscono il retroterra della formazione delle 'funzioni' logiche può essere desunta dal fatto che queste ultime assumono la forma scritta f(x) e non x(f) o altro. Questa circostanza è determinata dal principio in base al quale la negazione di una proposizione si identifica con la negazione del predicato e non del soggetto. Aristotele ha spiegato questo concetto così: "Per esempio, la negazione del giudizio 'essere uomo', risulta 'non essere uomo', e non già: 'essere non uomo'" (De interpretatione, 12, 21b, 1-2). Introducendo un simbolo che rappresenti la negazione, per esempio '∼', il modo più naturale e pratico di esprimere la negazione della proposizione sarà quello di indicare la negazione del predicato e quindi di far precedere il soggetto dal predicato come, per esempio, in ∼f(x), che equivale a (−f)(x), e non di far precedere il predicato dal soggetto, come, per esempio, in x(∼f); per poter fare questo dobbiamo partire da f(x) e non da x(f).
L'espressione f(x) presenta la stessa forma della funzione matematica y=f(x). In matematica, la funzione f′esprime una relazione tra due oggetti che associa a ogni elemento x, almeno un elemento y, il 'valore' di f(x). Il linguaggio artificiale delle funzioni può essere usato per rappresentare espressioni del linguaggio naturale; per esempio, f(x,y) può rendere la frase 'Bruto ha ucciso Cesare', f(x,y,z) 'Giovanni diede il libro a Maria', f(x) & g(x) & h(x) 'Riccardo è vivace, vendicativo e volgare', f(x) & f(y) & f(z) 'Amir, Maria e Gopal sono negligenti', e così via. Queste espressioni artificiali evitano le ambiguità del linguaggio naturale; per esempio, la proposizione 'Amir e Maria sono sposati' può essere privata della sua implicita ambiguità attraverso l'accostamento di due espressioni artificiali: m(x) & m(y) (entrambi sono sposati) e n(x,y) (sono sposati tra loro).
Il concetto matematico di funzione è più ricco e profondo di quanto i semplici esempi summenzionati lascino intravedere. L'analisi funzionale si estende a gran parte del campo della matematica e a una parte ancora più grande del vasto corpus matematico usato nella fisica. I matematici che introdussero le espressioni delle funzioni, tuttavia, parlavano e scrivevano usando il linguaggio naturale e conoscevano a fondo, anche se spesso soltanto in modo implicito, alcune delle sue strutture universali. Non bisogna quindi stupirsi nel constatare l'esistenza di serie di connessioni tra i linguaggi naturali e quelli artificiali. Un essere umano che non abbia appreso il linguaggio naturale non sarebbe in grado di elaborare un linguaggio artificiale, come dimostra il caso dello zero naturale che fu scoperto da individui che avevano una certa familiarità con lo zero linguistico. Questo processo iniziò molto presto, in condizioni ancora oscure; sappiamo tuttavia che ad aprire la strada a questa evoluzione furono i Babilonesi, gli Indiani e gli Arabi. A questo proposito va ricordato che i Cinesi erano in grado di risolvere sistemi di equazioni simultanee lineari senza ricorrere a notazioni scritte, usando il metodo delle bacchette all'interno di una 'matrice'; questo procedimento condusse a un sistema "tutto sommato abbastanza completo da rendere inutili i nostri simboli fondamentali. Sfortunatamente, nonostante la sua grande efficacia, tale sistema genera una posizione di stallo" (Needham 1959, p. 112). è molto improbabile, quindi, che gli Indiani abbiano adottato il sistema cinese e lo abbiano perfezionato "trascrivendo i numeri in forma scritta" (Lam 1986, p. 193), anche se non esistono prove certe al riguardo.
Johannes Tropfke (1921) ha diviso la storia delle espressioni algebriche in tre periodi. Nel corso del primo periodo domina la parola, ossia il linguaggio ordinario è esteso, ma le estensioni sono prevalentemente limitate al vocabolario. Questo periodo include la matematica greca fino ai primi secoli d.C. e gran parte della matematica medievale europea e araba fino a Regiomontano (XV sec.). Nel secondo periodo, per indicare le espressioni più usate s'introducono su larga scala le abbreviazioni, che tuttavia sono ancora usate secondo la sintassi del linguaggio ordinario. La maggior parte dell'algebra indiana appartiene a questa fase. Il più importante esempio europeo citato da Tropfke è quello di Diofanto, che però non ebbe mai molta influenza, benché la sua opera fosse stata commentata in arabo nel X secolo. Il livello conseguito da Diofanto fu raggiunto per la seconda volta soltanto nel XV sec. e dopo Regiomontano. Subito dopo ha inizio il terzo periodo, in cui si cominciano a usare nuovi simboli e notazioni combinati tra loro in proposizioni artificiali che non richiedono più di essere spiegate attraverso un linguaggio naturale, come, per esempio, il latino. A questo punto diviene evidente che il linguaggio matematico artificiale non è assimilabile al linguaggio naturale o alle abbreviazioni di ciò che è espresso nel linguaggio naturale, ma che è qualcosa di completamente diverso e nuovo. Fu François Viète, nel XVI sec., ad aprire la strada di questa evoluzione, seguito, in rapida successione, da Descartes, Leibniz, Newton e molti altri fino a Leonhard Euler (1707-1783), "il più ingegnoso ideatore di sistemi di notazione di tutti i tempi" (Boyer 1991, p. 442).
Il terzo periodo di Tropfke corrisponde all'elaborazione di quello che è stato chiamato 'linguaggio artificiale'. Nella forma assunta in Europa, questa nozione, sia dal punto di vista teorico sia da quello pratico, deve molto a Leibniz, il quale considerava insoddisfacenti i linguaggi naturali, come, per esempio, il latino, che nel XVII sec., prima di essere sostituito dai linguaggi matematici, era ancora il linguaggio della scienza. Egli si proponeva di creare un linguaggio filosofico universale in cui la struttura del pensiero umano fosse perfettamente rappresentata e tale da poter essere usato non soltanto per comunicare, ma anche per esprimere la conoscenza e la scienza. Leibniz aveva in mente un linguaggio 'logico', il genere di linguaggio cioè che Aristotele aveva elaborato per i predicati, che i logici usarono più tardi per le proposizioni, e che condusse, attraverso gli stessi contributi di Leibniz (compresi e assimilati soltanto due secoli più tardi), ai linguaggi logici e informatici dei nostri giorni. Leibniz definiva il suo linguaggio ideale lingua philosophica e lingua rationalis o universalis. Naturalmente, questo idioma non era tanto ispirato dalla logica quanto dalla matematica, il linguaggio dell'Universo secondo la definizione di Galileo. Leibniz diede un grande contributo all'elaborazione di questo linguaggio ‒ introducendovi più simboli, ancora oggi in uso, di qualsiasi altro matematico ‒ ed espresse l'opinione secondo cui il progresso nel campo della matematica era in gran parte determinato dal perfezionamento dei sistemi di 'notazione'.
La storia della scienza europea del XVII e del XVIII sec. ha confermato la tesi di Leibniz, dimostrando l'importanza delle notazioni e dei linguaggi artificiali. La prima fase di questo percorso fu piuttosto difficoltosa, come dimostra la seconda legge del moto di Newton, oggi insegnata nelle aule scolastiche per mezzo dell'espressione artificiale f=ma che si legge: 'la forza è il prodotto della massa e dell'accelerazione', dove il termine 'accelerazione' designa il cambiamento di moto che può essere espresso dal quoziente che divide la velocità per il tempo. Newton, tuttavia, formulò questa legge attraverso una frase latina così tradotta da C. Truesdell: "Il cambiamento del moto è proporzionale alla forza motrice impressa, e ha luogo lungo la linea retta in cui questa forza è espressa" (Truesdell 1968, p. 88). Newton non formulò nessuna delle sue leggi del moto in forma di equazione. Le sole equazioni contenute nei Principia riguardano le proprietà delle figure geometriche. David Park (1980, 1988) ha precisato che i loro caratteri non sono molto diversi da quelli delle espressioni contenute negli Elementi di Euclide, redatti più di duemila anni prima, e che fu soprattutto Euler a tradurre le proposizioni latine di Newton in notazioni algebriche, rendendole così ampiamente accessibili. Tutte le formule a cui i fisici moderni si riferiscono con l'espressione 'equazioni di Newton' sono state introdotte da Euler, Daniel Bernoulli e da altri matematici più tardi: "è vero che oggi possiamo ritrovarle senza difficoltà nelle parole di Newton, ma soltanto retrospettivamente" (Truesdell 1968, p. 167).
Come i linguaggi naturali, i linguaggi artificiali si sviluppano molto lentamente. Per indicare i punti, le linee e le figure, Euclide aveva usato le lettere dell'alfabeto, che in seguito furono utilizzate anche da Aristotele per designare i termini logici, ma furono i testi arabi a ispirare François Viète che nel XVI sec. iniziò a usare sistematicamente le lettere per indicare i numeri, sviluppando così l'algebra 'simbolica'. Uno dei più importanti risultati di questo processo di astrazione era che una lettera o 'variabile' poteva rappresentare qualsiasi numero o quantità. Anche i simboli che legavano tra loro queste quantità, per esempio, i segni 'più' (+) e 'meno' (−) o l'espressione della moltiplicazione attraverso la semplice concatenazione dei fattori, furono introdotti in Europa nel XV secolo. Il segno 'meno' offre un'efficace illustrazione del percorso di questa evoluzione; esso fu espresso per la prima volta nell'algebra indiana con un puntino inserito al di sopra del numero negativo, ma nel periodo in cui giunse in Europa attraverso la mediazione araba il puntino era stato trasferito al di sotto del numero. Il puntino entrò allora in competizione con il segno negativo '−', dal quale fu molto probabilmente sostituito. Quest'ultimo discendeva dalla tradizione di al-ḫwārazmī e di Fibonacci ed esprimeva, in combinazione con il segno '+', il rispecchiamento reciproco della positività e della negatività che il puntino non mostrava in modo chiaro o non mostrava affatto. Questi sviluppi semplificarono immensamente il calcolo, ma richiesero almeno un millennio. I sistemi di notazione euroasiatici, così come le altre tecniche di espressione artificiali, si svilupparono lentamente e si combinarono tra loro per formare un linguaggio artificiale soltanto dopo quella che oggi chiamiamo rivoluzione scientifica, e indubbiamente grazie ad essa. Ogni elemento di questo linguaggio, oggi considerato scontato, ha dietro di sé una lunga preistoria iniziata in una delle regioni del continente euroasiatico e consolidata grazie al lavoro di Leibniz, Bernoulli ed Euler.
Abbiamo dedicato un certo spazio all'esame delle formule e delle equazioni non soltanto perché la loro origine spesso va ricercata nel pensiero scientifico indiano, ma anche per spiegare le ragioni per cui la rivoluzione scientifica non ha avuto luogo in India. Newton era rimasto legato al latino, così come i matematici del Kerala al sanscrito, due linguaggi classici non abbastanza formali da innescare una rivoluzione scientifica. Ma diversamente da Mādhava e dai suoi successori, Newton aveva iniziato a elaborare la transizione verso l'uso del linguaggio artificiale e il lavoro lasciato incompiuto da lui fu portato a termine subito dopo da Euler e da altri studiosi. I matematici indiani non soltanto non imboccarono questa strada, ma peggiorarono le cose: essi, infatti, usarono singolari sistemi di notazione invece di ricorrere alla grande scoperta indiana della notazione decimale con lo zero e ai semplici metodi di calcolo basati su di essa. Questo sorprendente sviluppo e la sua conclusione in un'impasse è uno dei più grandi paradossi della scienza indiana e presenta indubbiamente una connotazione negativa. Nella scienza indiana è peraltro individuabile anche un altro e forse ancora più sorprendente paradosso, del tutto privo di qualsiasi connotazione negativa: l'origine della nozione di linguaggio artificiale e il primo linguaggio artificiale stesso devono essere attribuiti all'India. Per gli Europei e gli Americani, che associano il linguaggio artificiale alla matematica e alla fisica, questo secondo paradosso può apparire incomprensibile, ma dal punto di vista indiano questo sviluppo non è così sorprendente. Gli Indiani, infatti, erano grandi studiosi del linguaggio e il linguaggio artificiale, dopotutto, non è che una forma di linguaggio.
Nella seconda parte di questa Sezione descriveremo a grandi linee l'origine di questa evoluzione, basandoci sulle informazioni offerte da George Cardona nei capp. VIII e XIII, già discusse dal punto di vista del progresso; e illustreremo la nascita del linguaggio artificiale con l'aiuto di una tipica derivazione di Pāṇini.
Occorre ricordare che gli inizi della scienza indiana del linguaggio sono legati alla trasmissione dei Veda, che in India furono il primo oggetto dell'indagine scientifica. Per trasmettere oralmente il Ṛgveda (Veda degli inni) si analizzarono 'parola per parola' le proposizioni in esso contenute, e le regole di questa analisi erano fornite dai Prātiśākhya. La grammatica di Pāṇini inizia con una nuova classificazione dei suoni, che deriva da una revisione a prima vista sorprendente della classificazione Prātiśākhya. Pāṇini sostituì il sistema bidimensionale varga con una sequenza lineare, lo Śivasūtra:
a i u Ṇ / ṛ ḷ K / e o Ṅ / ai au C / ha ya va ra ṭ / la Ṇ / ña ma ṅa ṇa na M / jha bha Ñ / gha ḍha dha ṣ / ja ba ga ḍa da ś / kha pha cha ṭha tha ca ṭa ta V / ka pa Y / śa ṣa sa R / ha L // .
In questa traslitterazione i suoni indicati dalle lettere minuscole sono i suoni del sanscrito come oggetto-linguaggio, mentre le lettere maiuscole si riferiscono ai contrassegni metalinguistici, il cui uso è spiegato da una metaregola (paribhāṣa) del sūtra 1.1.71 dell'Aṣṭādhyāyī: "un suono iniziale unito a un suono finale (metalinguistico) denota anche gli elementi seguenti fino al suono finale". Così, aK denota 'a i u ṛ ḷ', iK denota 'i u r l', yaṆ denota 'ya va ra la' e aC denota le vocali; nel sanscrito le vocali i, u, ṛ e ḷ se seguite da vocali diverse sono sostituite rispettivamente dalle semivocali y, v, r e l. Pāṇini inizia col formulare questo fatto nel seguente modo: "iK è sostituito da yaṆ quando è seguito da una diversa aC", anche se l'aggettivo 'diversa' è omesso nel testo perché era già stata enunciata un'altra regola relativa alle vocali identiche. Per esprimere la nozione di 'rispettivamente' è invocata un'altra metaregola.
Espressioni come: 'iK quando è seguito da aC è sostituito da yaN' ricorrono frequentemente nella grammatica. La maggior parte delle regole fonologiche e molte altre di diversa natura assumono la seguente forma: 'Dopo A, al posto di B, si inserisce C, quando segue D'. Pāṇini esprime questa formula e rende tale generalizzazione relativa al linguaggio introducendo espressioni artificiali che fanno un uso metalinguistico dei casi del sanscrito, del suo oggetto-linguaggio. Questo importante procedimento non è limitato all'uso di espressioni artificiali isolate, ma conduce all'elaborazione di un '(meta)-linguaggio artificiale'. Il punto di partenza è il soggetto della regola, vale a dire l'elemento che è sostituito e che quindi è espresso dal caso nominativo. Gli usi metalinguistici degli altri tre casi sono enunciati da tre metaregole (ibidem, 1.1.49, 66 e 67) che riguardano rispettivamente il genitivo, il locativo e l'ablativo:
(1) la desinenza del genitivo è usata per 'quello' al posto 'del quale' [si inserisce un sostituto];
(2) quando qualcosa è indicato dalla desinenza del locativo, [il sostituto appare] al posto dell'elemento precedente;
(3) quando [qualcosa è indicato] dalla desinenza dell'ablativo, [il sostituto appare] al posto dell'elemento seguente.
Adottando queste regole, Pāṇini riformula l'enunciato (1) nel seguente modo: 'A+desinenza dell'ablativo, B+desinenza del genitivo, C+desinenza del nominativo, D+desinenza del locativo'. Applicando questo procedimento alla regola presa in esame, dove non vi sono restrizioni a sinistra e quindi non vi è alcun bisogno dell'ablativo, si giunge a: 'iK+genitivo, yaṇ+nominativo, aC+locativo', che in sanscrito diviene ikah yaṇ aci, a cui si applica il sandhi, giungendo alla regola formulata nella grammatica di Pāṇini (ibidem, 6.1.77): iko yaṇ aci. Questo caso elementare dimostra che Pāṇini, al contrario dei matematici indiani, seppe conferire al metalinguaggio della sua grammatica un elevato grado di artificialità, elaborando una serie di costituenti artificiali, creando un meccanismo attraverso il quale questi costituenti potevano essere legati tra loro e incorporati in un nuovo linguaggio artificiale, il metalinguaggio della sua grammatica. Questo metalinguaggio presuppone un uso interamente formalizzato di molti espedienti artificiali, incluse le terminazioni dei casi dell'oggetto-linguaggio. A quanto risulta, si tratta del primo linguaggio artificiale elaborato, inventato o scoperto nel corso della storia umana.
Nella linguistica moderna è possibile trovare un'equazione che traduce le espressioni di Pāṇini: la regola 'sensibile al contesto': B→C / A→D, dove A rappresenta il 'contesto di sinistra' e D il 'contesto di destra'. I sūtra che ho citato definiscono le regole della sensibilità al contesto in modo metalinguistico (Staal 1988). La principale differenza tra le espressioni artificiali della matematica e il linguaggio artificiale della linguistica in India deriva dal semplice fatto che il linguaggio non è costituito soltanto da parole, ma usa le parole per costruire 'proposizioni'. Il linguaggio di Pāṇini contiene non soltanto costituenti assimilabili ad abbreviazioni o notazioni speciali corrispondenti a parole, come, per esempio, iK, yaṇ, e aC, ma anche espressioni che corrispondono a proposizioni come, per esempio, iko yaṇ aci, e rientra quindi nel terzo dei tre periodi precedentemente descritti in cui Tropfke ha diviso la storia delle espressioni algebriche. In India, la matematica compì qualche passo in questa direzione, ma non giunse mai all'elaborazione di un linguaggio di questo tipo.
Il caso di Pāṇini solleva quindi un ulteriore problema secondario: i linguaggi artificiali sono essenzialmente linguaggi scritti e in definitiva sono correlati all'invenzione della scrittura? La grammatica di Pāṇini consente di rispondere negativamente a questo interrogativo. Essa, infatti, faceva parte di una tradizione orale che fu messa per iscritto soltanto nelle ultime fasi della sua formazione. Per quanto possa essere difficilmente comprensibile per gli studiosi moderni, questa circostanza è del tutto normale per l'India: la civiltà indiana è l'unica tra le grandi culture ad aver superato le prime fasi della sua formazione senza la scrittura (Staal 1986, 1989a; von Hinüber 1990; Falk 1993).
Tornando ancora una volta all'ipotesi di Needham relativa alla rivoluzione scientifica, essa era sostanzialmente corretta, ma occorre ampliare il concetto di 'matematizzazione' in modo da includere la 'formalizzazione' o i linguaggi artificiali. La formalizzazione introduce due nuove dimensioni: si applica a un maggior numero di scienze e conferma la concezione di Leibniz, secondo cui il linguaggio è una caratteristica importante, se non essenziale, della scienza. Gli esseri umani possono comprendere qualcosa dell'Universo, e quindi di sé stessi, soltanto perché sono in grado di catturare alcune delle sue caratteristiche nella rete di un linguaggio progettato in modo appropriato.
Bibliografia
Ariel 1998: Ariel, Yoav - Biderman, Shlomo - Rotem, Ornan, Relativism and beyond, Leiden-Boston, E.J. Brill, 1998.
Bhattacharya 1986: Situating Indian history. For Sarvepalli Gopal, edited by Sabyasachi Bhattacharya and Romila Thapar, Delhi, Oxford University Press, 1986.
Boyer 1991: Boyer, Carl B., A history of mathematics, 2. ed. rev. by Uta Merzbach, New York, J. Wiley & Sons, 1991 (1. ed.: 1968).
Bronkhorst 1991: Bronkhorst, Johannes, Pāṇini and the Veda reconsidered, in: Pāṇinian studies: Professor S.D. Joshi felicitation volume, edited by Madhav M. Deshpande and Saroja Bhate, Ann Arbor, Center for South and Southeast Asian Studies, University of Michigan, 1991, pp. 75-121.
Caillat 1989: Dialectes dans les littératures indo-aryennes, édité par Colette Caillat, Paris, Collège de France, 1989.
Caland 1907: Caland, Willem - Henry, Victor, L'Agniṣṭoma. Description complète de la forme normale du sacrifice de soma dans le culte védique, Paris, E. Leroux, 1906-1907, 2 v.
Chand 1946: Chand, Tara, Influence of Islam on Indian culture, Allahabad, Indian Press, 1946 (rist. della 1. ed. del 1936; 2. ed.: 1963).
Chomsky 1965: Chomsky, Noam, Aspects of the theory of syntax, Cambridge (Mass.), MIT Press, 1965.
‒ 1986: Chomsky, Noam, Knowledge of language: its nature, origin and use, New York, Praeger, 1986.
Datta 1962: Datta, Bibhutibhusan - Singh, Avadesh Narayan, History of Hindu mathematics. A source book, Bombay-New York, Asia Pub. House, 1962 (1. ed.: Lahore, Motilal Banarsidass, 1935-1938, 2 v.; v. I: Numerical notation and arithmetic, 1935; v. II: Algebra, 1938).
Deshpande 1991: Pāṇinian studies: Professor S.D. Joshi felicitation volume, edited by Madhav M. Deshpande and Saroja Bhate, Ann Arbor, Center for South and Southeast Asian Studies, University of Michigan, 1991.
‒ 1997: Śaunakīyā Caturadhyāyikā. A Prātiśākhya of the Śaunakīya Atharvaveda, with commentaries Caturadhyāyībhāṣya, Bhargava-Bhāskara-Vṛtti and Pañcasandhi, critically edited, translated and annotated by Madhav M. Deshpande, Cambridge (Mass.), Dept. of Sanskrit and Indian Studies - Harvard University, distributed by Harvard University Press, 1997.
Dodds 1973: Dodds, Eric R., The ancient concept of progress and other essays on Greek literature and belief, Oxford, Clarendon Press, 1973.
Dyson 1988: Dyson, Freeman J., Infinite in all directions. Gifford lectures given at Aberdeen, Scotland, april-november 1985, New York, Harper & Row, 1988.
Elzinga 1999: Elzinga, Aant, Revisiting the 'Needham Paradox', in: Situating the history of science. Dialogues with Joseph Needham, edited by S. Irfan Habib and Dhruv Raina, New Delhi-New York, Oxford University Press, 1999, pp. 73-113.
Embree 1971: Alberuni's India, translated by Edward C. Sachau, abridged ed. with introd. and notes by Ainslie T. Embree, New York, W.W. Norton & Company, 1971.
Falk 1993: Falk, Harry, Schrift im alten Indien. Ein Forschungsbericht mit Anmerkungen, Tübingen, Günter Narr, 1993.
Fuller 1999: Fuller, Steve, Prolegomena to a world history of science, in: Situating the history of science. Dialogues with Joseph Needham, edited by S. Irfan Habib and Dhruv Raina, New Delhi-New York, Oxford University, 1999, pp. 114-151.
Gellner 1995: Gellner, Ernest, Anthropology and politics. Revolutions in the sacred grove, Oxford-Cambridge (Mass.), Blackwell Publishers, 1995.
Graham 1973: Graham, Angus C., China, Europe, and the origins of modern science: Needham's The grand titration, in: Chinese science. Explorations of an ancient tradition, edited by Shigeru Nakayama and Nathan Sivin, Cambridge (Mass.), MIT Press, 1973, pp. 45-69.
‒ 1985: Graham, Angus C., Reason and spontaneity, London, Curzon Press, 1985.
‒ 1989: Graham, Angus C., Disputers of the Tao. Philosophical argument in ancient China, La Salle (Ill.), Open Court, 1989 (trad. it.: La ricerca del Tao. Il dibattito filosofico nella Cina classica, Vicenza, Neri Pozza, 1999).
Habib 1999: Situating the history of science. Dialogues with Joseph Needham, edited by S. Irfan Habib and Dhruv Raina, New Delhi-New York, Oxford University Press, 1999.
Harbsmeier 1998: Needham, Joseph, Science and civilization in China, Cambridge, Cambridge University Press, 1954-; v. VII,1: Harbsmeier, Christoph, Language and logic, 1998.
Hattori 1968: Dignāga on perception. Being the pratyakṣapariccheda of Dignāga's Pramāṇasamuccaya from the Sanskrit fragments and the Tibetan versions, translated and annotated by Masaaki Hattori, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1968.
Hawking 1996: Hawking, Stephen, The illustrated 'A brief history of time', updated and expanded edition, New York, Bantam Books, 1996 (1. ed.: A brief history of time. From the big bang to black holes, 1988).
Hayashi 1989: Hayashi, Takao - Kusuba, Takanori - Yano, Michio, Indian values for π derived from Āryabhaṭa's value, "Historia scientiarum", 37, 1989, pp. 1-16.
Heidegger 1950: Heidegger, Martin, Holzwege, Frankfurt a.M., Klostermann, 1950 (trad. it.: Sentieri interrotti, Firenze, La Nuova Italia, 1968).
von Hinüber 1989: Hinüber, Oskar von, Der Beginn der Schrift und frühe Schriftlichkeit in Indien, Mainz, Akademie der Wissenschaften und der Literatur; Stuttgart-Wiesbaden, Steiner, 1989.
Hodgson 1974: Hodgson, Marshall G.S., The venture of Islam. Conscience and history in world civilization, Chicago, University of Chicago Press, 1974.
Hofmann 1974: Hofmann, Joseph E., Leibniz in Paris 1672-1676. His growth to mathematical maturity, London-New York, Cambridge University Press, 1974.
Ingalls 1959: Ingalls, Daniel, The Brahman tradition, in: Traditional India. Structure and change, Milton Singer editor, Philadelphia, The American Folklore Society, 1959, pp. 3-9.
Innes 1951: Innes, C.A., Malabar, Madras, reprinted by the Superintendent Government Press, 1951 (1. ed.: Malabar and Anjengo, 1908).
Jami 1999: Jami, Catherine, Joseph Needham and the historiography of Chinese mathematics, in: Situating the history of science. Dialogues with Joseph Needham, edited by S. Irfan Habib and Dhruv Raina, New Delhi-New York, Oxford University Press, 1999, pp. 260-278.
Jha 1987: Jha, Vashishtha N., Studies in the Padapāṭhas and Vedic philology, Delhi, Pratibha Prakashan, 1987.
Joseph 1991: Joseph, George G., The crest of the peacock. Non-European roots of mathematics, London-New York, I.B. Tauris, 1991 (trad. it.: C'era una volta un numero. La vera storia della matematica, Milano, Il Saggiatore, 2000).
Kasulis 1993: Self as body in Asian theory and practice, edited by Thomas P. Kasulis, Roger T. Ames and Wimal Dissanayake, Albany, State University of New York Press, 1993.
Keynes 1951: Keynes, John M., Newton, the man, in: Keynes, John M., Essays in biography, new ed. with three additional essays, London, Rupert Hart-Davis, 1951, pp. 310-323 (1. ed.: London, Macmillan, 1933).
Kielhorn 1881: Kielhorn, Franz, On the Jainendra Vyākaraṇa, "Indian antiquary", 10, 1881, pp. 75-79 (rist. in: Kielhorn, Franz, Kleine Schriften, Wiesbaden, Steiner, 1969, pp. 180-184).
‒ 1887: Kielhorn, Franz, The grammar of Śakaṭāyana, "Indian antiquary", 16, 1887, pp. 24-28 (rist. in: Kielhorn, Franz, Kleine Schriften, Wiesbaden, Steiner, 1969, pp. 246-250).
‒ 1965: Kielhorn, Franz, Kātyāyana and Patañjali. Their relation to each other and to Pāṇini, Bombay, printed at the Education Society's Press, 1876 (rist.: Osnabrück, Otto Zeller, 1965).
‒ 1969: Kielhorn, Franz, Kleine Schriften, mit einer Auswahl der epigraphischen Aufsätze, hrsg. von Wilhelm Rau, Wiesbaden, Steiner, 1969.
Kiparsky 1979: Kiparsky, Paul, Pāṇini as a variationist, edited by S.D. Joshi, Cambridge (Mass.), MIT Press; Poona, Centre of Advanced Studies in Sanskrit, University of Poona, 1979.
Kuhn 1970: Kuhn, Thomas S., The structure of scientific revolutions, 2. Enl. ed., Chicago, The University of Chicago Press, 1970 (1. ed.: 1962) (trad. it.: La struttura delle rivoluzioni scientifiche, Torino, Einaudi, 1968).
Kunjunni 1983: Kunjunni, Raja K., Sanskrit and Malayalam references from Kerala, in: Staal, Frits, Agni, the Vedic ritual of the fire altar, in collaboration with C.V. Somayajipad and M. Itti Ravi Nambudiri, Berkeley (Ca.), Asian Humanities Press, 1983, 2 v.; v. II, edited by Fritz Staal with the assistance of Pamela MacFarland, pp. 300-310.
Lam 1986: Lam, Lay-Yong, The conceptual origins of our numeral system and the symbolic form of algebra, "Archive for history of exact sciences", 36, 1986, pp. 183-195.
Nakayama 1973: Chinese science. Explorations of an ancient tradition, edited by Shigeru Nakayama and Nathan Sivin, Cambridge (Mass.), MIT Press, 1973.
Nasr 1968: Nasr, Seyyed Hossein, Science and civilization in Islam, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1968 (trad. it.: Scienza e civiltà nell'Islam, Milano, Feltrinelli, 1977).
Needham 1951: Needham, Joseph, Human laws and laws of nature in China and the West, "Journal of the history of ideas", 12, 1951, pp. 3-30.
‒ 1956: Needham, Joseph, Science and civilization in China, Cambridge, Cambridge University Press, 1954-; v. II: History of scientific thought, 1956 (trad. it.: Storia del pensiero scientifico, Torino, Einaudi, 1981).
‒ 1959: Needham, Joseph, Science and civilization in China, Cambridge, Cambridge University Press, 1954-; v. III: Mathematics and the sciences of the heavens and the earth, 1959 (trad. it.: La matematica e le scienze del cielo e della terra, Torino, Einaudi, 1985-1986, 2 v.).
‒ 1976: Needham, Joseph, Science and civilization in China, Cambridge, Cambridge University Press, 1954-; v. V, 3: Spagyrical discovery and invention. Historical survey, from cinnabar elixirs to synthetic insulin, 1976.
Neugebauer 1957: Neugebauer, Otto, The exact sciences in antiquity, 2. ed., Providence, Brown University Press, 1957 (1. ed.: København, E. Munksgaard; Princeton, Princeton University Press, 1951).
Park 1980: Park, David, The image of eternity. Roots of time in the physical world, Amherst, University of Massachusetts Press, 1980.
‒ 1988: Park, David, The how and the why. An essay on the origins and development of physical theory, Princeton, Princeton University Press, 1988.
Penrose 1989: Penrose, Roger, The emperor's new mind. Concerning computers, minds and the laws of physics, Oxford-New York, Oxford University Press, 1989.
‒ 1990: Penrose, Roger, Précis of 'The emperor's new mind'. Concerning computers, minds and the laws of physics, "Behavioral and brain sciences", 13-14, 1990, pp. 643-655.
Pingree 1981: Pingree, David, Jyotiḥśāstra. Astral and mathematical literature, Wiesbaden, O. Harrassowitz, 1981.
‒ 1985: Pingree, David, Power series in medieval Indian trigonometry, in: Science and technology in South Asia, edited by Peter Gaeffke and David A. Utz, Philadelphia, Department of South Asia Regional Studies, University of Pennsylvania, 1985, pp. 25-30.
Quine 1981: Quine, Willard V., Theories and things, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1981.
Rahman 1999a: History of Indian science, technology and culture. AD 1000-1800, edited by Abdur Rahman, general editor and project director Debiprasad Chattopadhyaya, Oxford, Oxford University Press, 1999.
‒ 1999b: Rahman, Abdur, A perspective of Indian science; Science and social movements. Bhakti and Sufi movements, in: History of Indian science, technology and culture. AD 1000-1800, edited by Abdur Rahman, general editor and project director Debiprasad Chattopadhyaya, Oxford, Oxford University Press, 1999, pp. 7-31; 415-436.
Rau 1986: Rau, Wilhelm, Naturbeobachtung und Handwerkskunst im vorislamischen Indien, Stuttgart, Steiner, 1986.
Renou 1940: Śaraṇadeva, La Durghatavṛtti. Traité grammatical en sanskrit du XIIe siècle, édité et traduit par Louis Renou, Paris, Les Belles Lettres, 1940-1956, 2 v.; v. I,1: Introduction, 1940.
‒ 1953: Renou, Louis - Filliozat, Jean, L'Inde classique. Manuel des études indiennes, Paris, Payot, 1947-1953, 2 v.; v. II, 1953.
Righini Bonelli 1975: Reason, experiment and mysticism in the scientific revolution, Maria L. Righini Bonelli and William R. Shea editors, New York, Science History Publications, 1975.
Ruegg 1978: Ruegg, David S., Mathematical and linguistic models in Indian thought. The case of zero and sunyata, "Wiener Zeitschrift für die Kunde Südasiens", 22, 1978, pp. 117-181.
Ryle 1939: Ryle, Gilbert, Plato's Parmenides, "Mind", 48, 1939, pp. 128-151; 302-325.
Sarma 1993: Sarma, K. Venkateswara, Manuscripts collection of the Desamangalam Variyam (Kerala). An annotated catalogue, Madras, Kuppuswami Sastri Research Institute, 1993.
Scharfe 1977: Scharfe, Hartmut, Grammatical literature, Wiesbaden, O. Harrassowitz, 1977.
Scharfstein 1989: Scharfstein, Ben-Ami, The dilemma of context, New York, New York University Press, 1989.
Schwartzberg 1978: A historical atlas of South Asia, edited by Joseph E. Schwartzberg, with the collaboration of Shiva G. Bajpai [et al.], final map drafts by the American Geographical Society of New York, Chicago, University of Chicago Press, 1978.
Singer 1959: Singer, Milton, Traditional India. Structure and change, Philadelphia, The American Folklore Society, 1959.
Sivin 1968: Sivin, Nathan, Chinese alchemy. Preliminary studies, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1968.
‒ 1970: Sivin, Nathan, Chinese alchemy as science, in: "Nothing concealed". Essays in honor of Liu Yü-Yün, edited by Frederic Wakeman jr., Taipei, Cheng wen chubanshe, 1970, pp. 37-50.
‒ 1982: Sivin, Nathan, Why the scientific revolution did not take place in China - or did it?, "Chinese science", 5, 1982, pp. 45-66.
Staal 1961: Staal, Frits, Nambudiri Veda recitation, 's-Gravenhage, Mouton & Co., 1961.
‒ 1965: Staal, Frits, Context-sensitive rules in Pāṇini, "Foundations of language", 1, 1965, pp. 63-72 (rist. in: Staal, Frits, Universals. Studies in Indian logic and linguistics, Chicago, University of Chicago Press, 1988, pp. 171-180).
‒ 1982: Staal, Frits, The science of ritual, Poona, Bhandarkar Oriental Research Institute, 1982.
‒ 1983: Staal, Frits, Agni. The Vedic ritual of the fire altar, in collaboration with C.V. Somayajipad and M. Itti Ravi Nambudiri, Berkeley (Ca.), Asian Humanities Press, 1983, 2 v.
‒ 1986: Staal, Frits, The fidelity of oral tradition and the origins of science, Amsterdam-New York, North-Holland Pub. Co., 1986, pp. 251-288.
‒ 1988: Staal, Frits, Universals. Studies in Indian logic and linguistics, Chicago, University of Chicago Press, 1988.
‒ 1989a: Staal, Frits, The independence of rationality from literacy, "Archives européennes de sociologie. European journal of sociology", 30, 1989, pp. 301-310.
‒ 1989b: Staal, Frits, Rules without meaning. Ritual, mantras and the human sciences, New York, Peter Lang, 1989.
‒ 1993a: Staal, Frits, Concepts of science in Europe and Asia, Leiden, International Institute for Asian Studies, 1993 (ed. riv. in: "Interdisciplinary science reviews", 20, 1995, pp. 7-19).
‒ 1993b: Staal, Frits, Indian bodies, in: Self as body in Asian theory and practice, edited by Thomas P. Kasulis, Roger T. Ames, and Wimal Dissanayake, Albany, State University of New York Press, 1993, pp. 59-102.
‒ 1995: Staal, Frits, The Sanskrit of science, "Journal of Indian philosophy", 23, 1995, pp. 73-127.
‒ 1998: Staal, Frits, Beyond relativism, in: Relativism and beyond, edited by Yoav Ariel, Shlomo Biderman, Ornan Rotem, Leiden, E.J. Brill, 1998, pp. 37-66.
‒ 1999: Staal, Frits, Greek and Vedic geometry, "Journal of Indian philosophy", 27, 1999, pp. 105-127.
‒ 2000: Staal, Frits, A breakthrough in Vedic studies, "The book review", jan.-feb. 2000, pp. 17-20.
Subbarayappa 1985: Indian astronomy. A source-book, based primarily on Sanskrit texts, compiled by Bidare V. Subbarayappa, K.V. Sarma, Bombay, Nehru Centre, 1985.
Thapar 1978: Thapar, Romila, The tradition of historical writing in early India, "Indian church history review", 6, 1, 1978, pp. 1-22 (rist. in: Thapar, Romila, Ancient Indian social history. Some interpretations, New Delhi, Orient Longman, pp. 268-293).
‒ 1986: Thapar, Romila, Society and historical consciousness. The itihāsa/purāṇa tradition, in: Situating Indian history. For Sarvepalli Gopal, edited by Sabyasachi Bhattacharya and Romila Thapar, Delhi-New York, Oxford University Press, 1986, pp. 353-383.
Thieme 1982-83: Thieme, Paul, Meaning and form of the grammar of Pāṇini, "Studien zur Indologie und Iranistik", 8/9, 1982-1983, pp. 3-34.
Tropfke 1921: Tropfke, Johannes, Geschichte der Elementar-Mathematik in systematischer Darstellung mit besonderer Berücksichtigung der Fachwörter, 2. verb. und sehr verm. Auflage, Berlin-Leipzig, Vereinigung Wissenschaftlicher Verleger, 1921-1924, 7 v.; v. I-II, 1921 (1. ed.: Leipzig, Veit & Comp., 1902-1903, 2 v.).
‒ 1980: Tropfke, Johannes, Geschichte der Elementar-Mathematik, vollständig neu bearbeitet von Kurt Vogel, Karin Reich, Helmuth Gericke, 4. Aufl., Berlin-New York, W. De Gruyter, 1980-; v. I: Arithmetik und Algebra, 1980 (1. ed.: Leipzig, Veit & Comp., 1902-1903, 2 v.).
Truesdell 1968: Truesdell, Clifford, Essays in the history of mechanics, Berlin-New York, Springer, 1968.
Vogel 1963: al-Hwarizmi, Muhammad Ibn-Musa, Mohammed Ibn Musa Alchwarizmi's Algorismus. Das früheste Lehrbuch zum Rechnen mit indischen Ziffern, nach der einzigen (lat.) Handschrift (Cambridge Un. Lib. Ms. I i. 6.5) in Faks., mit Transkription und Kommentar hrsg. von Kurt Vogel, Aalen, Zeller, 1963.
van der Waerden 1979: Waerden, Bartel L. van der, Die Pythagoreer. Religiöse Bruderschaft und Schule der Wissenschaft, Zürich-München, Artemis, 1979.
‒ 1983: Waerden, Bartel L. van der, Geometry and algebra in ancient civilizations, Berlin, Springer, 1983.
Weber 1873: Weber, Albrecht, Über den padapāṭha der Taittirīya-Saṃhitā, "Indische Studien", 13, 1873, pp. 1-128.
Westfall 1975: Westfall, Richard, The role of alchemy in Newton's career, in: Reason, experiment, and mysticism in the scientific revolution, Maria L. Righini Bonelli and William R. Shea editors, New York, Science History Publications, 1975, pp. 189-232.
Witzel 1989: Witzel, Michael, Tracing the Vedic dialects, in: Dialectes dans les littératures indo-aryennes, édité par Colette Caillat, Paris, Collège de France, Institut de Civilisation Indienne, 1989, pp. 97-266.
‒ 1997: Inside the texts, beyond the texts. New approaches to the study of the Vedas, edited by Michael Witzel, Cambridge (Mass.), Harvard University Dept. of Sanskrit and Indian Studies, 1997.
‒ 1999: Witzel, Michael, Substrate languages in old-Aryan, "Electronic journal of Vedic studies", sept. 1999.