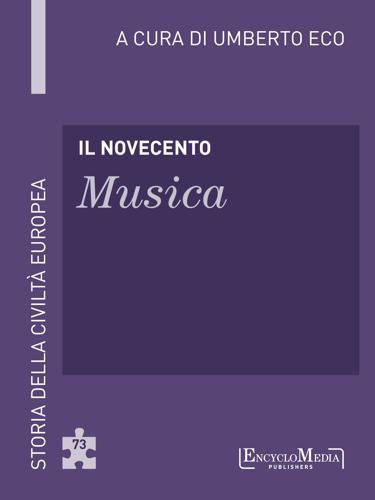Lo spettacolo d’intrattenimento in Italia: dal caffè concerto all’avanspettacolo
Il contributo è tratto da Storia della civiltà europea a cura di Umberto Eco, edizione in 75 ebook
In Italia lo spettacolo di intrattenimento, sia caffè concerto, rivista o avanspettacolo, ha sempre un carattere di evasione; solo con l’esperienza futurista negli anni Dieci o con la breve stagione del cabaret degli anni Cinquanta si ha anche un connubio fra spettacolo di intrattenimento e avanguardie.
1900-1945
La situazione italiana all’inizio del Novecento vede da una parte ormai affermato il caffè concerto, sul modello francese, dall’altra l’ascesa dei teatri di varietà, simili al caffè concerto, ma strutturati già come veri teatri. Quest’ultimo si basa sulle diverse attrazioni affidate ad artisti provenienti dal circo (in decadenza), dagli spettacoli di strada comici e buffi che non trovano più posto nel teatro borghese del tempo e, infine dalla canzone napoletana. I nomi che troviamo sul palcoscenico dei caffè concerto negli anni del primo Novecento sono Maldacea, Pasquariello, Elvira Donnarumma, Fregoli, “l’uomo-fenomeno”, come viene chiamato per i suoi funambolici trasformismi.
Lo spettacolo d’intrattenimento italiano è privo di qualsiasi rimando intellettuale, è luogo di divertimento anche “peccaminoso”, è luogo dove mettersi in mostra come un tempo nei foyer dei teatri. Il pubblico è quello borghese, ma esiste anche un caffè concerto per le classi più povere, che sbeffeggia la classe politica e il teatro colto senza mai avere la forza di una graffiante satira politica. All’inizio del Novecento il pubblico è essenzialmente maschile, e la famiglia ne è esclusa; tuttavia negli anni Dieci si inizia ad allargare il pubblico per poter aumentare i guadagni, così cominciano a comparire spettacoli pomeridiani per famiglie, più castigati. Questi sono gli anni della trasformazione dal caffè concerto al varietà, la consumazione perde d’importanza, lo spettacolo comincia ad avere orari prestabiliti, la qualità dei numeri è più curata e soprattutto scompaiono la “mossa” e gli abiti provocanti delle canzonettiste. Entra il ceto medio nel teatro di varietà, la piccola borghesia, che si cerca di strappare al cinema. Con la prima guerra mondiale il varietà arriva a un successo strepitoso convogliando la smania di divertimento di tutto quel mondo di arricchiti che con la guerra ha fatto fortuna.
La sola esperienza legata alle avanguardie è quella dello spettacolo di varietà dei futuristi, da loro considerato come l’unica forma di teatro che si opponga al teatro contemporaneo “passatista”. Con il Teatro di Varietà. Manifesto futurista, Marinetti nel 1913 si scaglia contro i valori del teatro del tempo: simultaneità, rapidità e destrezza, imprevisto e improvvisazione, questi sono i valori alternativi che Marinetti vede nel varietà. Le serate futuriste, come quelle dada, presentano musica, poesia, azioni polemiche, sketches in cui gli artisti, come Giacomo Balla, Fortunato Depero, Francesco Cangiullo, Marinetti, Enrico Prampolini si espongono in prima persona al gioco della provocazione. Ma sono Raffaele Viviani, Ettore Petrolini e Rodolfo De Angelis gli attori del varietà che più si avvicinano per scelta e affinità al futurismo. La piccola borghesia, con i suoi valori dannunziani, è l’oggetto della loro satira, irriverente, graffiante e grottesca.
Con la prima guerra mondiale lo spettacolo d’intrattenimento si tinge di patriottismo e “sciantose” avvolte in bandiere italiane intonano canti patriottici. Ma anche la tensione sociale entra nel caffè concerto e nel varietà, sebbene per poco. Gli scioperi e l’occupazione delle fabbriche nel 1918 portano sul palcoscenico bandiere rosse e canti politici, contro cui si scatena una campagna della stampa poiché il varietà fornisce un’immagine non edificante dell’Italia per i reduci dal fronte.
Con l’ascesa del fascismo gli esperimenti teatrali del varietà e del teatro della sorpresa futurista finiscono. Il varietà stesso inizia un processo di autocensura: gli scontri e le spedizioni punitive fasciste cancellano il tentativo dello spettacolo d’intrattenimento di entrare nel dibattito politico e così la satira si limita a quella bonaria di costume. La Belle Époque è definitivamente finita con la prima guerra mondiale, una nuova musica come il jazz, i foxtrot e i primi ragtime si affaccia nel varietà. Il cinema diventa il concorrente più pericoloso per lo spettacolo d’intrattenimento. Gli anni Trenta vedono l’affermarsi della rivista che, rispetto al varietà e al caffè concerto, si costruisce attorno a una sceneggiatura, a un testo scritto, quindi teatrale nel pieno senso del termine, anche se la struttura rimane la stessa del varietà, cioè costituita da numeri sfarzosi con i divi del momento, tutti lustrini e vedettes.
Sono anche gli anni dell’avanspettacolo, parente povero del varietà e della rivista, che si svolge nelle sale cinematografiche prima o fra le proiezioni. Ma, mentre la rivista si pone in concorrenza con il cinema proponendo divi in carne e ossa, l’avanspettacolo scende a patti con il cinematografo, lusingando il pubblico che non può permettersi la rivista e offrendo un mondo un po’ abborracciato ma reale, che ristabilisce la vecchia complicità fra palco e spettatori.
L’avanspettacolo arriva al suo massimo fulgore negli anni prima della seconda guerra mondiale, con personaggi come Totò, Dapporto e Fanfulla, che fanno trionfare la figura dell’attore capocomico, non più legato alla macchietta ma al gioco dell’invenzione di testi e storielle, con ampio spazio per l’improvvisazione assoluta. Negli anni della guerra sui palchi della rivista e dell’avanspettacolo appaiono volti nuovi come Anna Magnani, Aldo Fabrizi, Alberto Sordi e ancora, Renato Rascel, , il Quartetto Cetra, Ugo Tognazzi. Gli spettacoli si conformano al clima di guerra con una comicità evasiva e un repertorio di canzoni lirico-sentimentali. Con il coprifuoco, i bombardamenti e poi l’occupazione tedesca si continua a fare teatro, ma con orari pomeridiani e spettacoli sempre più corti, poveri, senza scene e con corpi di ballo di scarso rilievo.
1945-1970
Con la fine della guerra ritorna la possibilità e la voglia della vis polemica e della satira politica, e la rivista, se rimane qualunquista e reazionaria, scatena vere e proprie sommosse del pubblico, come a Milano nell’agosto del 1945 contro Soffia so’ di Garinei e Giovannini. In questi anni trionfa la coppia Anna Magnani - Totò, con la sua maschera da marionetta disarticolata, carica di angoscia surreale ed eccentrica follia. La rivista imbocca due strade differenti: quella sempre più spettacolare e lussuosa, dove accanto a comici come Totò o Macario continua a salire e scendere le scale fra decine di boys Wanda Osiris, e quella per attori di teatro di prosa e comici specializzati.
Dopo la guerra si modifica essenzialmente l’aspetto musicale dello spettacolo d’intrattenimento: alle canzoni lirico-sentimentali con gorgheggi e filati alla Luciano Tajoli si accostano i ritmi che provengono dall’America. Rivista e simili vivono, però, su formule già collaudate, come l’operetta, Broadway, la canzone melodica d’evasione che si afferma sempre più grazie ai concorsi canori, primo fra tutti il Festival di Sanremo. Unica eccezione alla fine degli anni Cinquanta, anche se tangenziale rispetto allo spettacolo di intrattenimento, è il gruppo di Cantacronache che, nato a Torino nel 1958, mette insieme musicisti come Giacomo Manzoni, Valentino Bucchi, Sergio Liberovici, Fausto Amodei, e letterati quali Italo Calvino, Franco Fortini, Michele Straniero ed Emilio Jona. Allontanandosi dalla canzone disimpegnata e “gastronomica” del tempo, proponendo testi di alta fattura letteraria e nuove modalità musicali nel cantare la quotidianità, i Cantacronache modificheranno il futuro della canzone italiana.
Negli anni Cinquanta nasce un modo diverso di fare la rivista, un nuovo umorismo colto e attento al teatro d’autore e di regia con Vittorio Caprioli e Franca Valeri. Altra esperienza importante è quella de Il dito nell’occhio di Franco Parenti, Dario Fo e Giustino Durano, in cui la satira politica diventa esplicita e militante.
Negli anni Sessanta si può parlare per la prima volta di cabaret in Italia, anche se per un brevissimo periodo, con Paolo Poli, Giancarlo Cobelli, Laura Betti, Gino Negri e ancora Enzo Jannacci, Fiorenzo Carpi, Giorgio Strehler: è un cabaret di parola, ma la musica ha un’importanza centrale, sia quella scritta appositamente sia il repêchage critico delle canzoni popolari e del café chantant. Ultimo exploit dello spettacolo d’intrattenimento è la commedia musicale degli anni Sessanta e Settanta alla Garinei e Giovannini, ma è anche il declino finale. La televisione riassorbe dentro di sé il teatro di varietà, distruggendo la complicità fra pubblico e palcoscenico, ormai fittizia e precostituita.