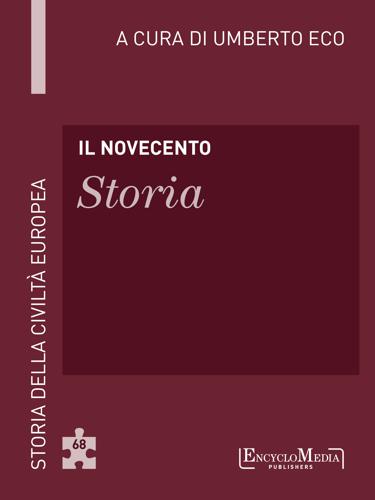Le agenzie internazionali
Il contributo è tratto da Storia della civiltà europea a cura di Umberto Eco, edizione in 75 ebook
All’indomani della seconda guerra mondiale molto avvertita è l’esigenza di un nuovo ordine mondiale che risparmi a vincitori e vinti un’altra grave e prolungata depressione come quella degli anni Trenta. Questa volta, però, gli Stati Uniti mostrano di aver appreso la “lezione della storia” e già nel corso della guerra manifestano concretamente l’intenzione di non isolarsi politicamente ed economicamente. La consapevolezza di essere il centro finanziario ed economico del mondo oltre che il baluardo anticomunista dei nuovi equilibri creatisi con la divisione del mondo in due blocchi contrapposti, conferisce al grande Paese d’oltreoceano la responsabilità di guidare le nazioni occidentali fuori dalle devastazioni della guerra, avviando da subito una nuova fase espansiva degli scambi e il rilancio dell’economia e del commercio internazionale.
Il sistema di Bretton Woods
Tanto gli Stati Uniti erano apparsi restii, nel primo dopoguerra, a interpretare con coerenza il ruolo di prestatore di ultima istanza, lubrificando i rigidi mercati delle merci e dei capitali, tanto nel secondo dopoguerra appaiono seriamente impegnati a favorire la ripresa dispiegando generosamente mezzi e risorse a favore degli Alleati e della stessa Germania messi in ginocchio dagli sforzi bellici. La leadership americana procede lungo questa strada con grande determinazione, costruendo in un breve volgere di tempo le condizioni e le istituzioni che avrebbero governato e guidato l’imponente espansione dell’economia internazionale per il ventennio successivo.
L’elemento più originale e significativo dei nuovi scenari della cooperazione internazionale risiede innanzitutto nella struttura istituzionale pensata per gestire l’intero processo di sviluppo e nella sapiente attribuzione di funzioni tra enti che, sotto l’attenta guida americana, riescono a garantire contestualmente gli interessi del loro maggiore azionista e quelli dei suoi principali partner. In effetti, il pericolo che si vuole a tutti i costi scongiurare è la chiusura dei mercati mondiali alla penetrazione commerciale degli Stati Uniti, i quali devono poter fare affidamento su mercati liberi da restrizioni dove poter esportare le proprie merci. Su tale base i pianificatori americani propongono la creazione di tre nuove istituzioni destinate a controllare i pagamenti internazionali, il movimento dei capitali e il commercio: il Fondo Monetario (FMI), la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (meno formalmente Banca Mondiale, BIRS) e l’Organizzazione Internazionale per il Commercio (ITO).
Il FMI e la Banca Mondiale sono approvati nel 1944 alla conferenza di Bretton Woods, nel New Hampshire. Più complicato il parto dell’organismo chiamato a liberalizzare il commercio, abolendo le pesanti bardature protezioniste di cui si erano dotati gli Stati nel periodo delle due guerre mondiali. L’ipotesi di garantire un sistema commerciale aperto, infatti, si sostanzia soltanto nel 1947, con l’Accordo Generale sul Commercio e le Tariffe (GATT) che dà vita a un forum negoziale, inizialmente tra 23 Paesi membri, allo scopo di rimuovere tutte le barriere tariffarie e non tariffarie che bloccavano gli scambi internazionali. Le tre istituzioni si basano tutte sul postulato del libero commercio senza discriminazioni e del libero movimento dei capitali nel lungo periodo come fonte di armonia a livello internazionale. Il mantenimento di tassi di cambio fissi avrebbe garantito la necessaria stabilità monetaria per raggiungere gli altri due obiettivi.
Tre finalità, tra loro strettamente connesse, per tre organismi con funzioni specifiche ma con una identica logica di funzionamento. Il FMI è incaricato di far funzionare il sistema monetario internazionale, su una base concordata di regole, e di fornire assistenza finanziaria ai Paesi con momentanee difficoltà nella propria bilancia dei pagamenti, considerato che è proprio ai deficit dei conti con l’estero che sono attribuite le cause di maggiore turbativa dell’ordine finanziario. A questo scopo il fondo è dotato di risorse provenienti dalle quote versate dai Paesi membri, costituite per il 25 percento da oro e da monete forti, il dollaro innanzitutto, e per il restante 75 percento dalle monete nazionali. La dimensione del prestito a cui un Paese può accedere è proporzionale alla quota da esso versata ed è vincolata al sistema di condizionalità deciso dal fondo per far rientrare il Paese debitore dai suoi temporanei squilibri di bilancio. Di diversa natura le attività della Banca Mondiale e le sue stesse provviste finanziarie che solo per una modesta parte provengono dalle quote dei Paesi membri, mentre la gran parte è costituita da capitali ottenuti sul libero mercato finanziario attraverso l’emissione di obbligazioni. I suoi interventi sono rivolti essenzialmente a finanziare progetti di sviluppo, nei Paesi più poveri, dopo una breve iniziale parentesi rivolta a sostenere il processo di ricostruzione in Europa.
Il piano Marshall
È proprio rispetto all’Europa, mercato di sbocco prevalente per le merci statunitensi ma anche area strategica per consolidare i confini geopolitici fissati alla conferenza di Yalta, che si applica la lungimiranza del progetto americano. Per evitare che le istituzioni varate a Bretton Woods siano stressate dalle ingenti richieste di aiuti provenienti dai Paesi del Vecchio Continente, si pensa a uno schema di intervento coordinato e organico al fine di sostenere specificamente la ripresa dell’economia europea. L’ERP (European Recovery Program, meglio noto come Piano Marshall), risponde mirabilmente a questa esigenza, ma, prima ancora, a quella degli Stati Uniti di uscire dall’economia di guerra garantendo lo smaltimento del surplus della sua capacità produttiva. Avviato nel 1948, per la durata di un quadriennio, con una dotazione di oltre 12 miliardi di dollari, sottoforma di beni e attrezzature acquistati sul mercato americano, esso si avvale di una filiera istituzionale – l’ECA, Economic Cooperation Administration, in America, con il compito di coordinare la domanda europea di beni con l’offerta americana e l’OECE, Organizzazione Europea di Cooperazione Economica, in Europa, come organismo collettivo di esecuzione del Piano –, nella quale non è difficile intravedere, a partire dall’Unione dei pagamenti europei (UEP) alla Comunità economica per il carbone e l’acciaio (CECA) i prodromi della futura integrazione europea.
A ogni modo il funzionamento delle diverse istituzioni sorte all’indomani della seconda guerra mondiale passa attraverso il riconoscimento della leadership del loro principale finanziatore, gli Stati Uniti. La sua supremazia è assicurata in particolare da un processo decisionale affidato al voto ponderato, dal peso specifico dei singoli Stati membri commisurato al valore delle loro contribuzioni. Una logica a cui non sfugge, pur con modalità apparentemente diverse (un Paese, un voto), la stessa Organizzazione delle Nazione Unite (ONU), nata a San Francisco nel 1945, per opera di cinquanta Paesi, per riorganizzare dal versante diplomatico la cooperazione politica tra gli Stati. I suoi organi fondamentali – l’Assemblea generale e il Consiglio di Sicurezza – rispondono alla necessità di una partecipazione paritaria e democratica ma anche al bisogno di rafforzare il controllo e l’egemonia delle potenze vincitrici, attraverso il diritto di veto riconosciuto a Stati Uniti, Unione Sovietica, Gran Bretagna, Francia e Cina.
La fine del sistema di Bretton Woods
L’intero sistema di cooperazione internazionale, frutto di accorti dosaggi e contrappesi, sotto la tutela degli Stati Uniti, fino agli anni Settanta costituisce un efficiente modello di governance mondiale, in grado di far prosperare l’economia e il commercio internazionale a ritmi fino ad allora sconosciuti e in un quadro di grande stabilità finanziaria. Da quel momento, però, soprattutto le istituzioni di Bretton Woods non sembrano più in grado di svolgere le funzioni per cui erano state create. La crisi economica, annunciata nel 1971 dal ritorno ai cambi fluttuanti deciso da Nixon per alleggerire la pressione sul dollaro precipita con l’impennata del prezzo del petrolio nel 1973-1974. Il primato economico degli USA è messo in discussione da economie più dinamiche e competitive come quella del Giappone o dall’affermarsi di regionalismi economici in concorrenza per mezzo di sempre più agguerrite politiche protezioniste.
I petrodollari alimentano la crescita imponente del mercato finanziario internazionale, ridimensionando il ruolo degli attori istituzionali pubblici a tutto vantaggio degli spregiudicati finanzieri privati che dilatano le traiettorie del credito internazionale catturando i Paesi in via di sviluppo nella spirale del debito e, per questa strada, minano il controllo sul movimento dei capitali che era stata la principale preoccupazione dei negoziatori di Bretton Woods. Con la crisi del debito dei primi anni Ottanta, il Fondo Monetario e la Banca Mondiale, stravolgendo le loro originarie attribuzioni, si trovano accomunati nella funzione di prestatori di ultima istanza dei Paesi in via di sviluppo più esposti finanziariamente e più tardi delle debilitate economie dei Paesi ex comunisti. Ma allo stesso tempo si ergono come tenaci paladini di una filosofia ultraliberista che, attraverso il sistema delle condizionalità, e l’imposizione di pesanti programmi di aggiustamento strutturale cerca di imporre, a qualsiasi latitudine, il primato del mercato, con costi e insuccessi che saranno all’origine delle crisi finanziarie degli ultimi anni del XX secolo in Messico, nel Sud-Est asiatico, in Russia.
Contemporaneamente anche il GATT sembra risucchiato nel suo anacronismo dal moltiplicarsi e differenziarsi degli scambi internazionali. Impegnato esclusivamente a liberalizzare il commercio dei prodotti industriali, è travolto dalle problematiche connesse allo sviluppo e allo scambio dei servizi, alla spinosa questione della commercializzazione dei diritti della proprietà intellettuale, alla crescente conflittualità tra USA e Europa unita sul mercato dei prodotti agricoli. Nel lungo Uruguay Round (1983-1994) questi nodi vengono al pettine, segnando il tramonto dell’istituzione e la nascita della più elefantiaca e pletorica struttura del WTO (World Trade Organization). Non è un caso che l’incapacità della nuova istituzione ad affrontare e dirimere le questioni connesse alla nuova dimensione degli scambi e l’inconcludenza dei sempre più ravvicinati incontri degli oltre 180 Paesi che ne fanno parte la eleggono, a partire da Seattle nel 1999, a principale accusato dei movimenti no global. Ma è tutto l’impianto della cooperazione internazionale del secondo dopoguerra che sembra paralizzato, per molti addirittura complice e artefice, dell’accentuarsi del divario tra Nord e Sud del mondo, della finanziarizzazione selvaggia dei processi di integrazione, dell’acuirsi delle emergenze ambientali, sanitarie, militari.
In molti casi siamo di fronte a critiche eccessive e semplificanti, ma che proprio perché volgono gli strali contro le istituzioni che per molto tempo hanno rappresentato il crocevia dello sviluppo internazionale, e con altrettanta superficialità lasciano in ombra o assolvono il sistema cooperativo costruitosi sulla rete sempre più densa delle organizzazioni non governative, segnalano l’urgenza di un nuovo modello di governo dell’economia mondiale.