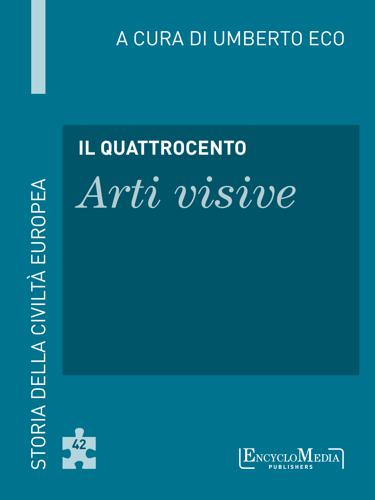La Roma di Sisto IV
Il contributo è tratto da Storia della civiltà europea a cura di Umberto Eco, edizione in 75 ebook
Sisto IV della Rovere, papa dotto, ambizioso e nepotista, fa della Chiesa una monarchia assoluta, a tratti aggressiva, spesso in conflitto con gli altri Stati italiani, e trasforma Roma da borgo medievale in una grande capitale del Rinascimento. L’Urbe è arricchita, specie in vista del giubileo del 1475, da splendide architetture, come l’Ospedale di Santo Spirito, il Ponte Sisto, Santa Maria del Popolo. I migliori pittori italiani sono chiamati a decorare la Biblioteca Vaticana (Melozzo da Forlì) e la Cappella Sistina (Perugino, Botticelli, Ghirlandaio, Signorelli).
Sisto IV della Rovere, primo “papa-re”
Il pontificato del francescano Francesco della Rovere (1414-1484), asceso al soglio papale con il nome di Sisto IV il 9 agosto 1471, rappresenta un momento fondamentale nell’affermazione del papato come monarchia assoluta e nel rinnovamento umanistico-rinascimentale di Roma. Appena eletto, il pontefice “restituisce” al popolo romano alcune celebri statue bronzee antiche, la Lupa, i tre frammenti del Colosso di Costantino (testa, mano, globo), lo Spinario e il Camillo, definite “monumento dell’antica eccellenza e virtù”, spostandole dal Laterano al Campidoglio.
L’atto, lontano preludio alla nascita dei Musei Capitolini (1734), dietro l’omaggio formale ratifica nella sostanza l’esautoramento da ogni potere reale delle magistrature comunali: la lupa di Romolo e Remo (i gemelli furono aggiunti alla fine del XV sec.) sostituisce il leone della Roma municipale, stabilendo un legame simbolico tra la grandezza della Roma antica e la sua moderna rinascita sotto il segno dei papi.
Per rafforzare il proprio potere da autentico “papa-re”, Sisto IV non esita a praticare il nepotismo su una scala senza precedenti, ponendo le basi di quel malcostume che tante critiche attirerà ai papi del Rinascimento.
L’instabile situazione politica italiana, i rapporti ora di alleanza ora di ostilità con gli Stati più influenti della penisola come il regno aragonese di Napoli, la Firenze di Lorenzo il Magnifico (1449-1492), gran nemico di Sisto IV, la Repubblica di Venezia e il ducato sforzesco di Milano, rendono d’altro canto urgente un controllo saldo dei propri domini territoriali e la scelta di persone fidate nei posti chiave. Purtroppo Sisto e i nipoti non brillano sempre per saggezza politica: le sconsiderate ambizioni di Girolamo Riario, elevato alla signorìa di Imola, si risolvono nell’appoggio alla congiura antimedicea dei Pazzi a Firenze nel 1478 e nel fallimentare tentativo di annettere Ferrara nel 1482, mentre nel Lazio il sostegno agli Orsini rinfocola l’annosa faida con i Colonna.
Sul fronte esterno Sisto IV deve fronteggiare il pericolo dell’espansionismo turco: ma gli appelli alla crociata rivolti ai principi italiani ed europei non producono che i limitati successi in Asia Minore nel 1472 del cardinale Oliviero Carafa e la riconquista nel 1481 di Otranto.
Sisto IV renovator Urbis
Sisto IV, raccogliendo idealmente il testimone del piano di ammodernamento e abbellimento di Roma lasciato incompiuto da Niccolò V alla metà del Quattrocento, modifica in modo radicale la fisionomia della città con cospicui interventi viari ed edilizi, preludendo alle ancor più imponenti realizzazioni di suoi successori come il nipote Giulio II o l’emulo Sisto V.
Nell’ampliare il nucleo dei palazzi vaticani, Niccolò V aveva predisposto alcuni ambienti per ospitare una biblioteca, dotandola di centinaia di codici latini e greci. Da insigne teologo, Sisto IV, già generale del proprio ordine e confessore del dottissimo cardinale greco Bessarione, rivela una spiccata sensibilità per la cultura sia umanistica che religiosa. Riapre l’Accademia di Pomponio Leto sul Quirinale, cuore del culto archeologico-letterario a Roma, chiusa da Paolo II dopo la congiura antipapale del 1468. Inoltre incrementa notevolmente e rende pubblica la biblioteca di Niccolò V nel 1475. Gubernator et custos della biblioteca viene designato l’umanista lombardo Bartolomeo Sacchi detto il Platina, autore del Liber de vita Christi ac omnium pontificum: il testo, che raccoglie le biografie dei papi da san Pietro fino al pontefice regnante, viene presentato a Sisto IV nel 1474 in una pregevole copia manoscritta (Biblioteca Vaticana, Vat. Lat. 9044), ornata “all’antica” dal miniatore Gaspare da Padova e dal calligrafo Bartolomeo Sanvito.
L’inaugurazione della Biblioteca Vaticana è immortalata in un grande affresco, in origine posto nella Bibliotheca Latina – nella quale ancora si ammirano i Filosofi e i Padri della Chiesa affrescati dai fratelli Domenico (1449-1494) e Davide (1452-1525) Ghirlandaio tra il 1475 e il 1477 –, e oggi conservato nella Pinacoteca Vaticana, realizzato nel 1477 dal pictor papalis Melozzo da Forlì. L’affresco, vera summa del pontificato sistino, è uno straordinario ritratto di gruppo del papa e dei suoi familiares entro una grandiosa architettura rinascimentale. In primo piano sulla destra Sisto IV, di fronte a lui il Platina in ginocchio che, con la mano destra, indica l’epigrafe, da lui stesso composta, celebrante le opere architettoniche del pontefice. In secondo piano sono ritratti quattro nipoti del papa: a sinistra due laici, il signore di Senigallia Giovanni della Rovere e il già ricordato Girolamo Riario; a destra due ecclesiastici, il porporato Giuliano della Rovere, il futuro Giulio II, e, dietro il papa, Pietro Riario, – o, secondo altri, Raffaele Riario, creato cardinale alla fine del 1477.
Una celebrazione della grandeur sistina sotto il segno del nepotismo, enfatizzata dalle nobili pose statuarie, dall’inquadratura dal basso e dalla prospettiva, elementi che Melozzo aveva appreso da Andrea Mantegna e da Piero della Francesca.
A Roma il pittore forlivese aveva già realizzato tra il 1472 e il 1474 l’affresco absidale dei Santi Apostoli raffigurante l’Ascensione di Cristo, distrutto nel Settecento ma di cui si conservano pregevoli frammenti. La decorazione fu commissionata dal cardinale titolare della basilica, Pietro Riario, mecenate raffinato, amante delle arti e delle lettere nonché del lusso più smodato, la cui principesca dimora adiacente alla basilica fu ereditata alla sua morte dal cugino Giuliano della Rovere.
1475: l’anno del giubileo
Il 1475 è un anno cruciale del pontificato sistino: la ricorrenza del giubileo dà infatti impulso a una serie di iniziative volte a rendere magnifico il volto della città e ad assicurare accoglienza ai pellegrini. “IAM NUNC SIXTINA VOCARI ROMA POTEST” proclama in quell’anno una delle numerose epigrafi, redatte nella scrittura capitale tipica delle iscrizioni imperiali, che rendono omaggio al grande papa costruttore, definito renovator (o restaurator) Urbis.
Una delle costruzioni più imponenti è l’Ospedale di Santo Spirito in Sassia, nei pressi del Vaticano, che unisce le finalità assistenziali all’esaltazione del committente. La Corsia Sistina, lunga 125 metri, cinta da un porticato e contrassegnata al centro da un alto tiburio ottagonale, fu eretta tra il 1471 e il 1478. All’interno vi si dispiega un ampio ciclo di affreschi, corredato da didascalie latine, che illustra la Fondazione dell’Ospedale a opera di Innocenzo III e la Vita di Sisto IV dalla nascita fino al suo ingresso in Paradiso. All’interesse iconografico però corrisponde una qualità esecutiva modesta.
Antoniazzo Romano, l’artista prediletto dalla committenza romana di matrice confraternale e devozionale, non sembra aver ricevuto incarichi di rilievo dal papa della Rovere pur comparendo in vari documenti (ad esempio in società con Melozzo). Il pittore spagnolo Pedro Berruguete esegue invece un ritratto del pontefice in tiara e piviale, oggi conservato nel Museo di Cleveland, non molto dissimile da quello dipinto dallo stesso Pedro per lo studiolo di Federico da Montefeltro a Urbino.
Altra celebratissima creazione giubilare è il Ponte Sisto, il primo ponte costruito sul Tevere dopo l’età classica, sulle rovine di un antico ponte: opera di ardita ingegneria, in tufo e travertino, a dorso d’asino su quattro arcate, ebbe un benefico impatto sul traffico viario, decongestionando il Ponte Sant’Angelo. Il progetto spetta probabilmente al fiorentino Giovannino de’Dolci, coadiuvato da Fioravante Martinelli.
La Cappella Sistina
Giovannino de’ Dolci è noto soprattutto come architetto della Cappella Sistina, la più splendida commissione del papa della Rovere, le cui dimensioni ricalcano quelle del biblico Tempio di Salomone a Gerusalemme (40 x 13 x 20 m ca.).
Più ancora che per l’architettura, la Sistina è celebre per la ricchissima decorazione pittorica, sviluppata lungo tre fasce orizzontali e affidata ai più alti esponenti della pittura tardoquattrocentesca umbro-toscana: Pietro Vannucci detto il Perugino, Piermatteo d’Amelia (fl. 1467-1502, autore del cielo stellato nella volta), i fiorentini Alessandro Botticelli, Domenico Ghirlandaio e Cosimo Rosselli, e i loro collaboratori Pinturicchio, Luca Signorelli, Bartolomeo della Gatta, Piero di Cosimo, Biagio d’Antonio.
In alto, inserite entro nicchie dipinte, sono le figure dei primi 30 pontefici; in basso finti arazzi; al centro, accompagnate da tituli in latino, le Storie di Cristo affrontate alle Storie di Mosè, a comporre un doppio ciclo in cui si celebra, attraverso il canonico parallelismo tra Vecchio e Nuovo Testamento, il primato papale. Così al sacramento veterotestamentario della Circoncisione del figlio di Mosè di Botticelli corrisponde il sacramento cristiano non cruento del Battesimo di Cristo del Perugino; alla botticelliana Punizione di Core, Datan e Abiron, che sancisce il primato politico di Mosè e quello religioso di Aronne tra gli ebrei, corrisponde la peruginesca Consegna delle chiavi, affresco centrale del ciclo, che sancisce il primato sia temporale che spirituale di Pietro e dei suoi successori. All’elaborazione del programma, oltre che il pontefice in persona, potrebbe aver collaborato il dotto frate minorita Antonio da Pinerolo, menzionato in un documento del 1482.
La devozione mariana, l’architettura e la scultura
Sisto IV nutrì una profonda devozione per la Madonna, dimostrata da vari atti: dedica la Sistina all’Assunzione della Vergine, soggetto dell’affresco d’altare del Perugino, poi coperto dal Giudizio di Michelangelo Buonarroti; l’8 dicembre 1479 consacra all’Immacolata Concezione, culto approvato dal pontefice nel 1477, la propria cappella funebre nella vecchia basilica di San Pietro, affrescata dallo stimatissimo Perugino e andata distrutta nel 1609. Alla morte del papa il nipote Giuliano commissiona ad Antonio del Pollaiolo una monumentale tomba bronzea, già al centro della cappella funebre e oggi al Museo del Tesoro di San Pietro: l’opera, dall’originale struttura a catafalco, è un capolavoro della scultura del Rinascimento.
La devozione mariana del papa si manifesta anche nell’edilizia ecclesiastica: in primis con l’agostiniana Santa Maria del Popolo, riedificata a partire dal 1472 da Giovannino de’ Dolci, prima grande chiesa rinascimentale nell’Urbe, influenzata da Filippo Brunelleschi, Leon Battista Alberti e dall’architettura del duomo di Pienza di Bernardo Rossellino (1409-1464). La chiesa inoltre ospita, nella cappella di San Girolamo, la ricca decorazione del Pinturicchio, nella quale sono ravvisabili le prime tracce degli ornamenti a grottesche di recente scoperti nella Domus Aurea di Nerone, e il monumentale sepolcro marmoreo dei committenti, i cardinal nepoti Domenico della Rovere e Cristoforo della Rovere, opera del lombardo Andrea Bregno e del toscano Mino da Fiesole.
Mino e Andrea sono, con Giovanni Dalmata, i protagonisti della scultura a Roma nel periodo sistino. Mino, allievo di Desiderio da Settignano, è un elegante esponente della scultura proto-rinascimentale toscana, Bregno è invece portatore di un classicismo più maturo e archeologico, analogo a quello di cui in architettura si fa portavoce il fiorentino Baccio Pontelli.
Quest’ultimo, giunto a Roma da Urbino nel 1482, segna, con le chiese di San Pietro in Montorio a Roma e di Sant’Aurea a Ostia, e, ormai oltre l’età sistina, con il palazzo di Raffaele Riario, poi della cancelleria, il massimo traguardo del classicismo in Italia prima dell’avvento di Donato Bramante.