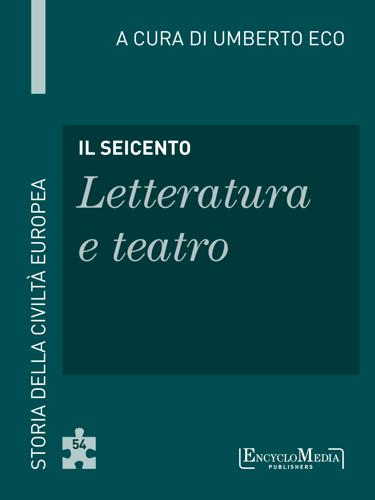La poesia spagnola
Il contributo è tratto da Storia della civiltà europea a cura di Umberto Eco, edizione in 75 ebook
Durante il XVII secolo, la lirica e la prosa spagnole, pur non elevandosi allo splendore del teatro, raggiungono tuttavia risultati importanti e in gran parte nuovi. La lirica, secondo la poetica cultista del suo caposcuola, Luis de Góngora, deve essere un’esperienza segreta e intima. Il grande scrittore di Cordova e i suoi molti discepoli sostengono, ancora, che in poesia i concetti debbano essere espressi attraverso lussureggianti e fastosi ornamenti (metafore scintillanti e ardite, latinismi, richiami mitologici peregrini, vocaboli musicali, inversioni di parole).
Luis de Góngora
Nella non breve carriera poetica di Luis de Góngora si possono distinguere (benché, in verità, non tutti gli studiosi siano concordi) due fasi: una prima fase, che va dagli esordi al 1610, e una seconda che comprende il periodo di tempo tra il 1611 e il 1627.
Se nel primo periodo il suo cultismo appare ancora moderato e intelligibile, nel secondo, invece, esso tende sempre più all’ermetismo e all’oscurità. Il poeta stesso, in verità, esprime a chiare lettere il deliberato proposito di orientare i suoi componimenti verso un ricchissimo e oscuro ermetismo. Mentre la prima produzione è quasi costantemente apprezzata dai critici, la seconda, per contro, è stata equamente rivalutata solamente nel Novecento.
Prescindendo da due commedie di scarso valore, l’opera di Góngora è esclusivamente lirica. Scrive poesia sacra e (soprattutto) profana: oltre alle opere maggiori, alcuni suoi cesellatissimi sonetti e talune romanze ispirate alle tradizioni patrie sono ancor oggi celebri.
Luis de Góngora
Suspiros tristes, lágrimas cansadas
Sonetos
II
Sospiri tristi, lacrime stremate,
che lancia il cuore, che piovono gli occhi,
bagnano i tronchi e muovono le fronde
di queste piante a Alcide consacrate,
ma del vento le forze congiurate
disperdono e confondono i sospiri,
e già le lacrime bevono i tronchi,
sì male sparse lacrime e sospiri.
Fin sul mio tenero volto il tributo
che danno gli occhi invisibile mano,
o d’ombra o d’aria, mi rasciuga tutto,
perché un angelo fieramente umano
non creda al mio dolore, e sia il frutto
questo piangere invano e sospirare.
Testo originale:
Suspiros tristes, lágrimas cansadas,
que lanza el corazón, los ojos llueven,
troncos bañan y las ramas mueven
estas plantas, a Alcides consagradas;
mas del viento las fuerzas conjuradas
suspiros desatan y remueven,
los troncos las lágrimas se beben,
ellos y peor ellas derramadas.
Hasta en mi tierno rostro aquel tributo
dan mis ojos, invisible mano
sombra o de aire me le deja enjuto,
porque aquel ángel fieramente humano
crea mi dolor, y así es mi fruto
osin premio y suspirar en vano.
L. de Góngora, Sonetti, a cura di C. Greppi, Milano, Mondadori, 1985
Góngora sa essere tanto satirico, beffardo e pungente, quanto lirico raffinatissimo e impenetrabile; nella Favola di Piramo e Tisbe, di ispirazione mitologica, armonizza mirabilmente toni burleschi e sottile idealizzazione.
Le sue opere più impegnative sono, comunque, le Solitudini (Góngora ha in animo originariamente di scriverne quattro, ma riesce a realizzare solo la prima parte della seconda) e la Favola di Polifemo e Galatea, vertici assoluti del cultismo dove la forma tocca uno splendore inedito. Quest’ultima composizione (di 63 ottave) è basata sulla storia dell’amore dell’orrido ciclope Polifemo per la ninfa Galatea, che lo respinge preferendogli il bel pastore Aci. Il mostro uccide barbaramente il giovane, il cui sangue, buttato in acqua viene a formare un fiume.
Luis de Góngora
L’antro di Polifemo
Fábula de Polifemo y Galatea
I.
Queste che mi ispirò rime sonore,
la colta, ma bucolica, Talia
- o conte eccelso - in purpuree ore,
che l’alba è rose e rosso il dì venia,
or che tua Niebla indori di splendore,
ascolta al suon della zampogna mia,
se te non vedano le mura di Huelva
fendere il vento e affaticar la selva.
II.
Calmo, ravvii sulla maestra mano,
il generoso falco la sua piuma,
o così muto alla catena, invano
pure il sonaglio imbianchi il freno d’or
col morso vano di cavallo andaluso oziosa spuma;
gema il levriero al guinzaglio di seta.
e al corno, alfine, succeda la cetra.
III.
Servan da tregua al faticar, robusto,
l’ozio attento, il silenzio dolce e intanto
tu ascolta, sotto il baldacchino augusto
del musico gigante il fiero canto.
Alterna con le Muse oggi il tuo gusto,
che se la mia ti possa offrire tanto
clamore (della Fama non secondo),
udrà il tuo nome il confine del mondo.
IV.
Dove spumoso il mare siciliano
tinge d’argento il piede al Lilibeo
(tetto della fucina di Vulcano
o tomba delle ossa di Tifeo),
pallidi segni, cinereo un piano,
- se pure non del desiderio reo
del grave officio dà. Lì un’alta rocca
col morso serra una grotta alla bocca.
V.
Fosco ornamento a questo scoglio duro
tronchi robusti alla cui foglia
meno deve di luce e d’aere puro
la caverna profonda che alla pietra;
caliginoso letto, grembo oscuro
qual ce lo mostra della notte tetra
lugubre stormo di notturne ali,
che tristi gemono e volano gravi.
VI.
Ecco, di questa orrenda della terra
apertura, il cavo malinconico,
a Polifemo, orror di quella serra,
è rustica dimora, albergo ombroso
e ovile capace ove tutte le capre che il pendio rugoso
ricoprono dei monti: greggia bella.
che un fischio aduna e una roccia suggella.
Testo originale:
I.
Estas que me dictó rimas sonoras,
culta sí, aunque bucólica, Talía
- ¡Oh excelso conde! - en las purpúreas horas
que es rosas la alba y rosicler el día,
ahora que de luz tu Niebla doras,
escucha al son de la zampoña mía,
si ya los muros no te ven, de Huelva,
peinar el viento, fatigar la selva.
II.
Templado, pula en la maestra mano
el generoso pájaro su pluma,
o tan mudo en la alcándara que en vano
aun desmentir el cascabel presuma;
tascando haga el freno de oro cano
del caballo andaluz la ociosa espuma;
gima el lebrel en el cordón de seda
y al cuerno, al fin, la cítara suceda.
III.
Treguas al ejercicio sean, robusto,
ocio atento, silencio dulce, en cuanto
debajo escuchas de dosel augusto
del músico jayán el fiero canto.
Alterna con las musas hoy el gusto,
que si la mía puede ofrecer tanto
clarín (y de la Fama no segundo),
tu nombre oirán los términos del mundo.
IV.
Donde, espumoso, el mar sicilïano
el pie argenta de plata al Lilibeo
(bóveda de las fraguas de Vulcano
o tumba de los huesos de Tifeo),
pálidas señas, cenizoso un llano,
- cuando no del sacrílego deseo -
del duro oficio da. Allí una alta roca
mordaza es a una gruta de su boca.
V.
Guarnición tosca de este escollo duro
troncos robustos son, a cuya greña
menos luz debe, menos aire puro
la caverna profunda, que a la peña;
caliginoso lecho, el seno obscuro
ser de la negra noche nos lo enseña
infame turba de nocturnas aves,
gimiendo tristes y volando graves.
VI.
De este, pues, formidable de la tierra
bostezo, el melancólico vacío
a Polifemo, horror de aquella sierra,
bárbara choza es, albergue umbrío
y redil espacioso donde encierra
cuanto las cumbres ásperas cabrío
de los montes esconde: copia bella
que un silbo junta y un peñasco sella.
L. de Góngora, Favola di Polifemo e Galatea, a cura di E. Cancelliere, Torino, Einaudi, 1991
Questa esile vicenda, tratta dalle Metamorfosi di Ovidio, viene arricchita, variata e decorata in mille guise da Góngora che, in questo poemetto, pare superare il suo stesso virtuosismo metaforico e musicale.
Moralista rigido e spesso acre, umorista disingannato e iperrealista, poeta concettoso e politico cristianissimo, Francisco de Quevedo è una delle figure più affascinanti ed enigmatiche del “secolo d’oro”. Con Calderón de la Barca e Baltasar Gracián, egli è poi fra gli scrittori più rilevanti del concettismo.
Pochi come Quevedo hanno saputo cristallizzare pensieri complessi in sottili concetti, spesso espressi in un linguaggio all’apparenza semplice. Nella maggior parte dei casi, infatti, le sue frasi piane e lineari racchiudono due o più significati.
Critica rabbiosa (e a tratti quasi parossistica) dell’uomo, sfiducia nelle sue possibilità di realizzarsi e di fare il bene, sofferto disagio di fronte alla vita e marcata misoginia sono alcune delle peculiarità del pensiero e del carattere di Quevedo. Egli, sempre tormentato e contraddittorio, tenta nelle sue opere di esplorare e comprendere le più diverse realtà da quella turbolenta, violenta e per certi versi crudele dei picari a quella misteriosa e inquietante del sogno visionario.
Il radicale pessimismo di Quevedo è palpabile anche quando canta, per esempio, la decadenza della sua diletta Spagna, sulla quale si proiettano minacciose le ombre della morte: invero, i motivi funebri e orrifici sono ricorrenti nella sua produzione in versi e in prosa.
È innegabile comunque che Quevedo, il quale sa passare con stupefacente disinvoltura dal genere burlesco al macabro, dall’erotico al mistico, dal lirico al morale, è stata una delle voci più versatili del suo tempo.
Lope de Vega
Come poi quell’individualità passionale e vulcanica che fu Lope de Vega avrebbe potuto fare a meno di scrivere poesie e poemi? Di fatto, egli pubblica versi sacri e profani, abbracciando una varietà di temi veramente straordinaria: dall’amore come passione al timore di Dio, dalle avventure epiche alle burle della Gattomachia, dalla storia nazionale alla vita dei santi.
Padrone di tutte le forme metriche, Lope elabora un corpus poetico che, da solo, sarebbe sufficiente ad assicurargli un posto di primo piano nella letteratura mondiale. Poeta colto (legge, oltre agli imprescindibili classici, Petrarca, Ariosto, Tasso e i petrarchisti italiani e spagnoli), egli dà il meglio di sé quando descrive con naturalezza e semplicità i suoi cangianti stati emotivi e la sua esistenza appassionata di grande amatore.
All’oscurità di Góngora, che lo attacca aspramente in più occasioni a causa del suo stile (a suo dire) basso, piatto e popolare, Lope contrappone una lieve eleganza, la chiarezza castigliana e la proprietà della lingua; l’esperienza cultista, comunque, influì anche su di lui (soprattutto sulle sue opere più tarde), stimolandolo a sperimentare forme difficili e a cimentarsi in generi letterari lontanissimi dalla sua prima e più autentica maniera.
Poeti minori
Tra le altre figure di una certa importanza nell’ambito della poesia spagnola del Seicento si possono ricordare Bartolomé Leonardo de Argensola, equilibrato poeta oraziano e lirico amoroso delicato che, come altri suoi contemporanei, oppone ai labirinti incantati del cultismo un ponderato e nitido classicismo; Esteban Manuel Villegas, nelle cui liriche garbate e vivaci si possono incontrare motivi platonico-cristiani; Francisco de Rioja, dotto umanista fondatore di un’autentica scuola poetica (scuola sivigliana), che canta in maniera particolarmente felice i temi della transitorietà di ogni creazione, divina e umana.
Sarebbe ingiusto, ancora, passare sotto silenzio queste altre significative personalità come Bernardo de Balbuena, sacerdote che, sulla scorta dei poemi cavallereschi italiani, compone il Bernardo o la vittoria di Roncisvalle, monumentale poema di cinquemila ottave; Juan de Jáuregui, traduttore instancabile dei classici e di italiani (Tasso in particolare), oltre che autore di mediocri poesie religiose; Juan de Tassi y Peralta conte di Villa Mediana, nobile colto e prestante, ha una vita breve, intensa e travagliata, scrive liriche petrarchiste, satire politiche, poemi mitologici e una commedia; Salvator Jacinto Polo de Medina, vicino sia al cultismo, sia al concettismo, è, fra l’altro, attento e spesso ironico osservatore della realtà; Augustin de Salazar y Torres, infine, autore drammatico e poeta, è influenzato, rispettivamente, da Calderón e da Góngora.