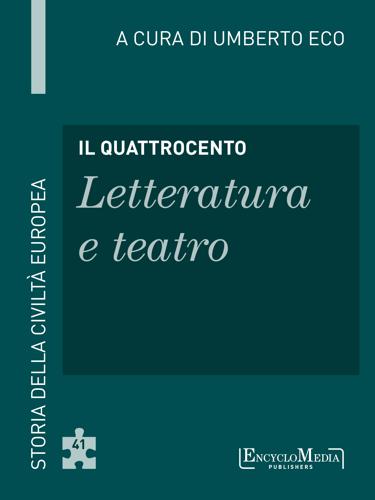L’umanesimo: caratteri generali
Il contributo è tratto da Storia della civiltà europea a cura di Umberto Eco, edizione in 75 ebook
Il sogno degli umanisti: la filologia a misura delle cose
La lezione petrarchesca, anticipata per certi versi da alcune figure del cosiddetto “preumanesimo padovano”, come Albertino Mussato e Lovato Lovati, lascia alle generazioni successive degli umanisti il senso di un dialogo continuo e proficuo tra un passato da riscoprire e un presente da risanare, da cui nasce la scommessa umanistica di una grande rinascita di tutti i saperi. Gli umanisti, per citare un celebre studioso spagnolo, Francisco Rico, coltivano infatti uno straordinario sogno, quello di costruire una nuova cultura che investa tutti gli ambiti del sapere e dei comportamenti umani, dell’individuo e della società, grazie a un’inedita consapevolezza della realtà, misurata con gli strumenti della filologia, la disciplina che ridisegna e definisce i confini dei saperi, delle cose, e delle potenzialità umane. Il metodo filologico – di cui il Petrarca aveva già fornito luminosi esempi, come accade per il testo di Livio, oggi manoscritto londinese Harley 2493 – viene recepito e approfondito nella prima metà del Quattrocento soprattutto dalla geniale figura di Lorenzo Valla, che vede nella parola rifondata, sottoposta ai nuovi metodi filologici, lo strumento di ricostruzione degli orizzonti di tutti i saperi, e nella correttezza linguistica del latino il potenziale fondamento per una rinascita della cultura e della civiltà non solo delle lettere ma di tutte le disciplinediscipli ne. La filologia è dunque l’arma con cui si emendano i testi, ma anche con cui si sovvertono luoghi comuni e interpretazioni distorte e fuorvianti spesso annidati tra le righe dei volumi di diritto, di medicina e di ogni dottrina tramandata dal passato, ben consolidata e talvolta concretamente applicata nella vita pratica e civile. Nel grande monumento delle Elegantiae (di lunga e laboriosa elaborazione dal 1441 al 1449), una grammatica “antinormativa” che analizza negli autori latini la proprietà e la correttezza dell’uso linguistico, Valla erige un solido baluardo contro quella forza barbarica e devastatrice delle tenebre dell’epoca di mezzo, mettendo in crisi l’astratto nominalismo medievale, nell’augurio che il rinnovato splendore di una lingua latina restituita alla sua purezza possa far rinascere quei valori di cultura e di civiltà che erano stati la vera grandezza di Roma. Il metodo ecdotico di Valla, sempre alla ricerca incondizionata di una veritas della parola, affronta ambiti inediti e talvolta assai rischiosi, come nel De falso credita et ementita Constantini donatione (scritto a Napoli nel 1440), volto a dimostrare la falsità della Donazione di Costantino – documento sul quale il papato fondava la legittimità dei propri privilegi temporali – alla luce di un serrato esame giuridico e storico, ma soprattutto squisitamente linguistico, o nella Collatio Novi Testamenti (di cui restano due redazioni), nella quale si indaga con inedita audacia la lettera dei testi sacri, lezione che aprirà la strada alla filologia di Erasmo da Rotterdam e a certe istanze della Riforma protestante.
Le scoperte dei codici latini e greci e la lezione degli antichi per il presente
La stagione dell’umanesimo è anche quella delle grandi scoperte dei classici greci e latini nelle biblioteche d’Europa (e anche in tal senso illustre precursore era stato Petrarca), imprese di cui ci rimangono affascinanti racconti epici soprattutto negli epistolari del tempo. Infaticabile ricercatore, scopritore e trascrittore di manoscritti antichi è Poggio Bracciolini, che in qualità di segretario apostolico ha la possibilità di compiere numerosi viaggi nei Paesi dell’Europa centrale e settentrionale, soprattutto tra il 1415 e il 1417, quando esplora le biblioteche di conventi e abbazie, portando alla luce opere di straordinaria importanza, come varie orazioni di Cicerone, il testo completo della Institutio oratoria di Quintiliano, il De rerum natura di Lucrezio, le Silvae di Stazio e altri testi dell’antichità latina. A Poggio, che copiava spesso di suo pugno i codici ritrovati, si deve inoltre una forma di grafia dai caratteri chiari e nitidi, in seguito denominata “umanistica”, che è all’origine dei sistemi grafici moderni.
Gli autori antichi, letti, corretti e assimilati, non si limitano tuttavia a offrire agli umanisti lezioni di stile o ricchezza di argomenti, ma incidono, con il loro esempio, sulla realtà concreta, sullo sviluppo della cultura, sulla vita politica e civile, forniscono esempi e paradigmi per il presente. La nuova scienza pedagogica, che annnovera nei primi decenni del Quattrocento figure di grandi maestri come Gasparino Barzizza, Vittorino da Feltre, Guarino Veronese, matura anche alla luce dello studio e della versione di classici tradotti dal greco, come il De liberis educandis dello Pseudo Plutarco o la Ciropedia di Senofonte, mentre si fa strada anche l’idea di un “canone” di letture formative, come avviene nel De studiis et litteris, composto tra il 1422 e il 1425, da Leonardo Bruni. La parola degli antichi diviene dunque, nella sensibilità umanistica, sempre atto, forma di vita, paradigma di sapere, di comportamento e di gusto individuale e sociale. D’altra parte alcuni importanti umanisti traducono in prassi politica e in agire concreto gli insegnamenti tratti dai testi letti, tradotti o emendati. Prestigiose figure della cancelleria fiorentina, come Coluccio Salutati, Leonardo Bruni, Carlo Marsuppini e Poggio Bracciolini sono intellettuali fortemente impegnati nella vita comunale e nelle istituzioni della repubblica e pongono al centro delle loro riflessioni l’elogio della vita attiva, evidenziando così il forte nesso fra letteratura e società, fra cultura e impegno politico che sarà proprio anche della generazione successiva di Machiavelli e di Guicciardini (1483-1540). Nella premessa alla sua versione latina della Politica aristotelica, nel 1434, Bruni ha modo di ribadire che la naturale debolezza dell’uomo riceve dalla società civile quella compiutezza e perfezione che non ha da sé. L’individuo dunque realizza se stesso e la sua vocazione alla felicità non in solitudine, ma nell’ambito delle istituzioni sociali e civili (la città, lo Stato). Perciò la scienza politica deve avere un ruolo di prim’ordine nella formazione dell’uomo, come strumento di promozione delle sue virtù civili. La difesa dell’impegno mondano costituisce un motivo ricorrente del pensiero di Coluccio Salutati, sulla base della convinzione, di origine ciceroniana, che gli studia humanitatis vadano costantemente correlati all’attività di governo. Alla passione di questi umanisti, ansiosi di leggere i testi nella lingua originale, si deve anche la nascita degli studi del greco in Italia e l’istituzione – già auspicata da Giovanni Boccaccio) – delle prime cattedre di quella lingua che Petrarca si era tanto rammaricato di non conoscere. Per intercessione di Coluccio Salutati giunge allo Studio fiorentino il maestro bizantino Emanuele Crisolora, che pone anche la base teorica per le modalità di traduzione dal greco in latino (non ad verbum ma piuttosto ad sententiam), autore di una grammatica, gli Erotemata, su cui una folta schiera di umanisti apprende i rudimenti della lingua ellenica.
D’altra parte anche il paesaggio urbano dell’Italia, in cui si contemplavano i magnifici monumenti, le testimonianze materiali di un passato illustre e grandioso (nel De varietate fortunae del 1448 Bracciolini passeggia fra le rovine archeologiche di Roma e riflette sulla vanità degli imperi e sulla fuggevolezza delle umane cose) fa avvertire agli umanisti il senso delle radici, del profondo legame che univa generazioni di uomini tanto lontani nel tempo ma che animano gli stessi scenari. Da questa nuova sensibilità prendono inoltre avvio opere che inaugurano i moderni studi di archeologia, di antiquaria, o di geografia storica, come la Roma triumphans, la Roma instaurata e l’Italia illustrata di Flavio Biondo (1392-1463), o anche la Descriptio urbis Romae di Leon Battista Alberti, a cui si ispirano nel complesso le prospettive estetiche dell’arte umanistica e rinascimentale, basti pensare alla pittura di Andrea Mantegna (1431 ca. - 1506) o all’architettura dello stesso Alberti o di Filippo Brunelleschi.
L’Alberti e la modernità dell’umanesimo
Mentre Valla attende alla stesura delle proprie opere ricercando un criterio di verità che partendo dalle parole misuri le cose, l’altra massima voce dell’umanesimo quattrocentesco, Leon Battista Alberti, negli stessi decenni del secolo, cerca in altro modo la continua rispondenza tra verba e res, tra letteratura ed esperienza del reale. Il volto dell’Alberti è un mosaico composito (per utilizzare un termine caro a uno dei più accorti studiosi dell’umanista, Roberto Cardini) che ha tutti i tratti della modernità: da una parte il volto costruttivo e solare dell’architetto e del teorico dell’architettura (nel De re aedificatoria), della pittura e della scultura (De pictura e De statua), dell’autore dei Libri della famiglia e della prima grammatichetta della lingua volgare, dell’ingegnere di testi concepiti sempre come “mosaici”; alla sua pars construens si riconduce anche la curiosità insaziabile di archeologo e di urbanista (si pensi alla Descriptio urbis Romae) che non sfocia mai nella pedanteria erudita, ma che anzi utilizza i modelli testuali (ad ampio raggio, dai classici ai medievali) come stimolo per la sua opera creativa; di contro, invece, il volto umbratile e chiaroscurale, occultato per lungo tempo anche dal trionfante dominio della dignitas hominis del neoplatonismo di Pico della Mirandola (1463-1494) e di Ficino (1433-1499), ma riscoperto dalla tenace genialità di Eugenio Garin. Questo è il profilo dell’Alberti vicino alla nostra sensibilità di moderni, nel carattere chiaroscurale della “maschera” che dà vita alle pagine delle Intercaenales e del Momus e alle folgoranti sentenze corrosive degli Apologi centum. Se Petrarca ammetteva persino nel monumento calligrafico della Posteritati la sua inquietudine, il suo stare nescius, Alberti, spingendosi ben oltre, e non confidando in nessun porto di quiete, sa che l’uomo è naufragus, inserito in un fluxus che è l’esistenza, sottoposto a continua vicissitudo. L’uomo è costretto ad assumere una maschera nel perenne fluire dell’esistenza. Non a caso nel Momus si fa strada proprio un lessico tecnico teatrale, maturato soprattutto alla lettura dei comici, Terenzio e soprattutto Plauto, divenuti paradigmi ermeneutici profondi, come rivelano le formule sumpta persona (Proemio) e desumpta persona (I libro) (“mettersi e togliersi la maschera”) o subsellium, il termine che si usa beffardamente sia per gli scranni dei tribuni che per le seggiole degli spettatori a teatro (con affascinanti invenzioni che ancora oggi fanno riflettere sulla teatralità del potere). A giusta ragione dunque è stato detto che Alberti è il fondatore di quel pensiero umoristico moderno che passando per Leopardi arriva a Pirandello. Alberti, come e forse più di altri umanisti, sa far vibrare la viva modernità della voce degli antichi, sa dialogare con Vitruvio e altri classici nei suoi scritti, ma sa donare accezioni sempre nuove ai singoli tasselli dei mosaici delle opere degli auctores, recuperati e genialmente ricomposti in caleidoscopici e mai casuali giochi combinatori. Recenti contributi hanno inoltre portato alla luce alcuni volumi della biblioteca dell’umanista che rivelano sia la prevalenza di interessi ciceroniani e matematici, sia un rapporto intimo e quasi affettivo con i suoi codici, sulle cui carte Alberti traccia oroscopi e quadri astrali, tra i quali il suo (ciò accade in un codice del De legibus ciceroniano di suo possesso, oggi alla Biblioteca Nazionale di Firenze), o annota date di ricorrenze familiari e addirittura una ricetta di un oleum contra vermes puerorum, una pozione contro i vermi dei bambini (su un suo manoscritto del Brutus di Cicerone, oggi in Marciana), quasi la memoria privata e le vicende della prosa del quotidiano meritassero di trovar luogo accanto alle nobili parole degli antichi.
La centralità dell’interprete e l’importanza del commento
Il lavoro filologico che, a partire da Petrarca, pone attenzione alla centralità dei testi, da indagare con le specifiche e non dilettantesche armi dell’intellettuale, conduce gli umanisti anche alla consapevolezza dell’importanza dell’interpres e del suo ingenium, che media tra il testo e il lettore. Prima con Valla, e poi soprattutto nel secondo Quattrocento con Poliziano e con il bolognese Filippo Beroaldo il Vecchio, a cui fanno da sfondo altre numerose figure – dal veronese Domizio Calderini, al milanese d’adozione Giorgio Merula, o al veneziano Ermolao Barbaro e tanti altri da passare in rassegna con i criteri della “geografia” dell’umanesimo, come ha insegnato Carlo Dionisotti – assume crescente rilievo il valore dell’interprete che si manifesta soprattutto negli interventi ope ingenii sul testo. Soprattutto nelle due Centurie dei Miscellanea di Poliziano (la cui voce dovrebbe sempre essere messa in relazione a quella dell’erudita poesia volgare, latina e greca dell’umanista fiorentino), la filologia diviene inscindibile dalla critica testuale, dalla contestualizzazione storica del testo, o, per dirla in termini moderni, la filologia diviene inscindibile dalla critica. Le due Centurie ebbero fortuna e diffusione assai diversa: mentre l’editio princeps della prima è quella fiorentina di Antonio Miscomini, del 1489 (poi emendata dall’autore stesso), la Centuria seconda fu pubblicata in edizione critica, fondata sull’autografo di Poliziano, a cura di Vittore Branca e Manlio Pastore Stocchi, soltanto nel 1972.
La centralità che l’opera dell’interprete e del commento assume nella seconda metà del XV secolo si può anche desumere dalle numerose ed eterogenee forme esegetiche che si moltiplicano a corredo dei testi classici spesso adottati durante i corsi universitari: dal commento continuo (in cui il testo viene sotteso e taciuto) alle Adnotationes a unico autore o ad autori diversi (come le Adnotationes centum di Filippo Beroaldo il Vecchio), alle Castigationes (come le Castigationes plinianae di Ermolao Barbaro), ai Sermones (i discorsi tenuti come prolusioni al principio dell’anno accademico) come quelli del maestro dello studio bolognese Antonio Urceo detto Codro. D’altra parte si deve proprio agli umanisti la coniazione di un lessico filologico in grandissima parte recuperato dalla moderna scienza ecdotica.