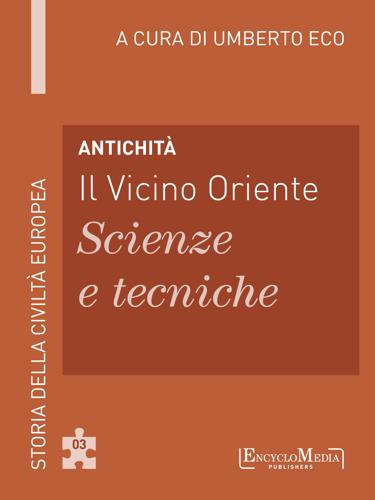L’astronomia nelle civiltà mediterranee
L'astronomia nelle civilta mediterranee
Il contributo è tratto da Storia della civiltà europea a cura di Umberto Eco, edizione in 75 ebook
L’interesse per gli astri nasce indipendentemente in quattro grandi aree geografiche: Europa continentale, Mediterraneo orientale, Estremo Oriente e America centrale. Le civiltà che risiedono in queste aree scrutano il cielo per regolare le attività agricole, rituali e civili sui ritmi scanditi da stelle e pianeti. Le testimonianze dell’Europa continentale preistorica sono tuttavia soltanto indiziarie. L’analisi dei monumenti megalitici rivela la presenza di allineamenti astronomici dettati da un simbolismo cosmico che collega i cicli del Sole e della Luna alla vita e alla morte.
L’archeoastronomia
Molte storie dell’astronomia scritte anche in tempi recenti iniziano con affermazioni pittoresche sul fascinoso timore che l’uomo prova da sempre nell’alzare lo sguardo alle stelle. Questo tipo di introduzioni, ormai datate, riposa sull’esistenza di sentimenti collettivi che si suppongono costanti nel tempo e, proprio per questo, non si addice a una narrazione “storica”. La storia si basa sull’analisi di documenti, in prevalenza testuali, e inizia di necessità solo con essi. Lo storico dell’astronomia non può esimersi da questo principio e appoggiarsi a un sentimento condiviso per riscoprire le emozioni dell’uomo preistorico innanzi al cielo. Nessuno ci dice che queste emozioni, plasmate da fattori culturali la cui conoscenza ci è preclusa, restino davvero costanti e coincidano con le nostre. Questo fatto dovrebbe apparire abbastanza chiaro se, per esempio, si pensa alla differenza fra le prime concezioni documentate del cielo e la concezione odierna. Il cielo antico è spesso concepito come una volta di modeste dimensioni che reca incastonate luci brillanti chiamate stelle ed è controllata da una o più divinità. Il cielo attuale è invece concepito come uno spazio sconfinato e vuoto, regolato da poche forze fisiche fondamentali, dove le stelle sono centinaia di miliardi di soli simili al nostro raggruppati in miliardi di galassie.
Nel caso particolare della storia dell’astronomia, esistono tuttavia anche altre fonti, diverse da quelle testuali, che si possono consultare per comprendere qualcosa di più sul passato remoto dell’interesse umano per le cose celesti. Queste fonti consistono da un lato nei fenomeni astronomici, i cui mutamenti apparenti sono ricostruibili in avanti o indietro nel tempo per alcuni secoli con elevata precisione, e dall’altro lato nei resti delle costruzioni del passato. Una disciplina del tutto particolare, nota come “archeoastronomia” (termine formato dall’unione delle parole “archeologia” e “astronomia”), si occupa di combinare queste due tipologie di fonti non testuali per trovare tracce dell’interesse delle società preistoriche per i fenomeni celesti.
L’archeoastronomia cerca in particolare di scoprire eventuali orientamenti astronomici delle rovine archeologiche. Tuttavia, proprio perché lavora in assenza di fonti testuali, chi la esercita è tenuto a una estrema cautela. Per accertare la significatività dei risultati trovati, l’archeoastronomo deve mettere in atto una serie di verifiche statistiche note come “test di attendibilità”. Non è infatti detto che l’allineamento di due pietre con il punto dell’orizzonte da cui sorge il Sole in un dato giorno dell’anno dipenda da un atto volontario. È sempre possibile che le pietre siano buttate lì a caso e che l’allineamento si produca per una pura combinazione. Per comprendere questo punto delicato basta pensare che se si uniscono due a due con delle rette dieci pietre messe a caso su una circonferenza, esse individuano ben 45 direzioni distinte, con una probabilità piuttosto elevata che almeno una di tali direzioni risulti allineata con qualche astro brillante (il Sole, la Luna, alcune stelle di prima grandezza). I test di attendibilità servono a stimare la significatività di un allineamento in base alle possibilità offerte dai punti di riferimento di un sito archeologico, alla quantità e all’importanza degli astri introdotti nella ricerca e alla precisione con cui si realizza l’allineamento. Più punti di riferimento ci sono e più astri si considerano, meno il risultato trovato è significativo. Maggiore è invece la precisione dell’allineamento, più il risultato è significativo.
Un grave rischio sempre presente in questo tipo di studi è la selezione arbitraria dei punti di riferimento da valutare. Non è infrequente che un ricercatore riesca, per così dire, a far tornare i conti prendendo un punto per cui le cose tornano e scartandone un altro per cui invece non tornano. Un tipico esempio di questo processo di selezione arbitraria è costituito dalle teorie che pretendono di individuare nella disposizione geografica di alcune piramidi dell’antico Egitto una rappresentazione della costellazione di Orione. La lista stilata nel 1842 dall’egittologo tedesco Karl Richard Lepsius include più di 60 piramidi; scegliendone di volta in volta sei o sette in modo opportuno, si riesce a individuare fra esse non solo Orione, ma quasi qualunque altra costellazione.
I fenomeni celesti
Per meglio comprendere il terreno di lavoro degli archeoastronomi, ma anche i motivi del forte interesse degli uomini antichi per le cose celesti, occorre ricordare quali sono i principali fenomeni astronomici che regolano i ritmi della vita sul nostro pianeta. La crescente tendenza a globalizzare le informazioni e il ricorso a tecnologie che risolvono in modo automatico alcuni problemi quotidiani, solo in apparenza banali, inducono nell’uomo contemporaneo una forma di indifferenza verso questi fenomeni e il loro significato esistenziale. Questa sorta di scollamento fra l’uomo e gli astri costituisce un ulteriore elemento di distanza storica fra presente e passato. Infatti, se nel remoto passato il cielo è concepito come incommensurabilmente più piccolo rispetto al presente, non per questo esso è ritenuto un’entità di scarsa importanza nella vita di tutti i giorni. Anzi, proprio la relativa vicinanza fra cielo e Terra, e la dipendenza delle attività umane da alcuni fenomeni astronomici, il tutto unito alla posizione centrale che l’osservatore sembra possedere rispetto ai movimenti celesti, crea un legame di fortissima dipendenza fra le società più antiche, gli astri e i loro mutamenti.
Il primo fenomeno astronomico da considerare consiste nella rotazione, per noi ormai solo apparente, di tutti gli astri intorno a chi li osserva. In prima approssimazione, questa rotazione coinvolge allo stesso modo il Sole, la Luna, i pianeti e le stelle, portandoli a compiere un giro completo da est verso ovest nella più elementare unità naturale di tempo. Questa unità, il “giorno”, è in origine concepita come l’intervallo che corre fra due apparizioni successive del Sole sulla linea dell’orizzonte orientale. Soltanto intorno al III secolo a.C., quando alcuni matematici dell’area mediterranea soggetta all’influenza greca cominciano a sentire l’esigenza di una maggiore precisione, si pensa di definire il giorno in modo astronomicamente più esatto.
Se si fissa il punto dell’orizzonte dove il Sole sorge giorno dopo giorno, si scopre che esso si sposta verso nord o verso sud rispetto a una posizione media corrispondente all’est geografico. La constatazione non richiede strumenti di misura; per rendersi conto dello spostamento del punto di levata del Sole basta osservare il profilo irregolare dell’orizzonte e registrare dietro quale rilievo o altro dettaglio del paesaggio il Sole compare di volta in volta. Questo spostamento, in sé minimo, è tuttavia cumulativo e, sulla distanza di alcuni giorni, produce effetti notevoli. Quando il punto di levata si sposta progressivamente verso nord, l’arco che il Sole percorre nel cielo per effetto della rotazione apparente che lo coinvolge si allunga. Corrispondentemente anche la durata della giornata, vale a dire il periodo nel quale il Sole rimane al di sopra dell’orizzonte, si allunga, mentre la durata della notte si accorcia. Quando invece il punto di levata si sposta verso sud, l’arco che il Sole percorre nel cielo si accorcia, così come la giornata, mentre è la notte a allungarsi.
Se si compie questo tipo di osservazione abbastanza a lungo, si nota che il punto di levata del Sole non supera mai un certo limite nord e un certo limite sud. I due limiti a nord e a sud recano da secoli il nome di “solstizi” (dal latino Sol stet = il Sole si ferma), in quanto per alcuni giorni il Sole sembra fermarsi e sorgere sempre dietro lo stesso punto dell’orizzonte. Una volta toccato uno dei due limiti, il punto di levata torna a spostarsi indietro. La constatazione della ciclicità del fenomeno di spostamento del punto dove sorge il Sole è alla base della definizione della seconda unità naturale di tempo. Questa unità, l’“anno”, è in origine concepita come il numero di giorni che intercorrono fra due levate successive del Sole nello stesso punto dell’orizzonte e con la stessa direzione di spostamento verso nord o verso sud.
Nel corso di un anno avvengono mutamenti straordinari, ben apprezzabili nelle regioni dell’Europa centrale, Mediterraneo e Vicino Oriente. Nel periodo dell’anno in cui il Sole sorge più a nord, la maggiore lunghezza della giornata produce un notevole aumento della temperatura atmosferica. In questo periodo più caldo le piante crescono, fioriscono e danno frutti. Nell’altro periodo dell’anno in cui il Sole sorge più a sud, la minore lunghezza della giornata produce invece una consistente diminuzione della temperatura. In questo periodo fa più freddo, le piante perdono le foglie ed entrano in stato di riposo. Nei periodi intermedi, quelli in cui la durata della giornata e della notte sono all’incirca uguali, il tempo atmosferico è meno stabile e le precipitazioni sono più abbondanti. Appare così evidente come una volta diminuita la tendenza a affidare la propria sopravvivenza alla caccia e passato a uno stile di vita basato in prevalenza sull’agricoltura, l’uomo provi un vivo interesse per il computo dei giorni e per la possibilità di prevedere i periodi di caldo, freddo e forti piogge. Solo nella consapevolezza del ciclo delle stagioni si possono seminare le piante e raccoglierne i frutti a tempo debito.
Un terzo fenomeno celeste, legato a un astro diverso dal Sole, appare di interesse nella definizione di una unità di tempo intermedia fra il giorno e l’anno di circa 365 giorni. La prima apparizione della Luna avviene verso ovest, subito dopo il tramonto, nella forma di una falce estremamente sottile che subito scompare sotto l’orizzonte. Giorno dopo giorno la Luna appare sempre più spostata verso est rispetto al Sole e mostra una porzione visibile sempre più estesa della propria superficie. Quando si è spostata così tanto verso est da sorgere mentre il Sole tramonta, la Luna è piena. Nei giorni successivi, in cui sorge sempre più tardi rispetto al tramonto del Sole, la Luna mostra una porzione visibile sempre più ridotta. Infine, la Luna sorge subito prima del Sole con l’aspetto di una falce sottilissima destinata a scomparire per alcuni giorni. Il ciclo delle fasi lunari, della durata di circa 29 giorni, è alla base della definizione del mese.
Anche per la Luna si può pensare di eseguire una serie di osservazioni del punto di levata rispetto all’orizzonte. Quello che si constata è un comportamento simile a quello del Sole. Anche il punto di levata della Luna si sposta verso nord e verso sud rispetto a una posizione media che coincide con l’est geografico. Questo spostamento avviene però lungo una fascia più ampia ed è molto più irregolare. Oggi sappiamo che questo comportamento del punto di levata dipende dal fatto che il piano dell’orbita lunare è inclinato rispetto al piano dell’orbita terrestre e che, inoltre, la linea lungo la quale i due piani si intersecano (linea dei nodi) cambia progressivamente direzione. Per le civiltà più antiche lo spostamento irregolare del punto di levata della Luna è un ulteriore fattore di mutevolezza dell’astro della notte, che si aggiunge alla sequenza delle fasi: Luna nuova, primo quarto, Luna piena e ultimo quarto, ritenute utili per definire una quarta unità di tempo della durata di sette giorni, la “settimana”.
Questi pochi cenni sui fenomeni celesti delineano un panorama nel quale l’osservazione assidua degli astri comporta la possibilità di gestire al meglio le attività legate alla sussistenza della specie umana. In particolare, il nesso ancestrale fra agricoltura e astronomia traspare ancora oggi dall’etimo di alcune parole connesse a un’idea proto-scientifica del modo di vivere consapevole, quali per esempio “computare” (dal latino cum putare = potare le piante con attenzione) e “considerare” (dal latino cum siderare = guardare il cielo con attenzione). Fatto sta che nelle società preistoriche e antiche il cielo gioca un ruolo fondamentale e, in dipendenza del grado in cui si è capaci di leggerne i segni, un gioco che può essere di vita o di morte. Gli astri regolano tutti i ritmi della vita quotidiana e si può giungere a pensare che lo facciano per influenze di tipo fisico (luce e calore) o divino (protezione e fortuna).
L’orientazione dei monumenti megalitici
Le indagini svolte fino a oggi evidenziano l’esistenza di quattro grandi aree dove in epoca preistorica e all’inizio dell’epoca storica sorgono civiltà con evidenti interessi astronomici. Non necessariamente queste aree vengono in contatto fra loro nel corso dei secoli; nonostante ciò esse sviluppano un comune interesse per il cielo dovuto all’esigenza condivisa di regolare le attività agricole, rituali e civili sui ritmi stagionali scanditi dai movimenti degli astri. In queste quattro aree – Europa continentale, Mediterraneo orientale, Estremo Oriente e America centrale – compaiono simbolismi, religioni e mitologie associate ai corpi celesti.
In linea di tendenza, il Sole appare riconducibile alla luce e alla vita, mentre la Luna è associata all’oscurità e alla morte. Si può supporre che ciò derivi dalla macroscopica constatazione che il Sole splende di giorno, quando tutto vive, mentre la Luna si vede di notte, quando tutto dorme. I simbolismi legati a singoli pianeti e alle stelle, corpi di minor rilievo nella definizione del tempo e delle stagioni, appaiono invece suscettibili di letture più ambigue o contrastanti. Per esempio, Marte è il pianeta della guerra per tutta l’area del Mediterraneo orientale, mentre tale ruolo nell’area dell’America centrale spetta a Venere, vale a dire al pianeta dell’amore nell’area del Mediterraneo orientale.
Il precoce interesse dei popoli preistorici per le cose celesti è testimoniato dai resti di antichissimi edifici scoperti dagli archeologi e studiati dagli archeoastronomi. Il continente europeo è particolarmente ricco di siti che rivelano allineamenti significativi con le posizioni assunte da alcuni astri subito sopra l’orizzonte (levata e tramonto). Gli allineamenti possono essere presenti sia in costruzioni isolate, sia in complessi di costruzioni simili le une alle altre, sia ancora in edifici molto articolati il cui pieno significato sfugge agli studiosi.
Gli esempi più antichi di siti europei astronomicamente orientati risalgono al I neolitico (IV millennio a.C.). Si tratta di tumuli di terra e di piccole tombe che si rivelano dirette, a seconda della regione, o verso nord-est o verso sud-ovest. Questi siti mostrano come l’uomo primitivo accordi una particolare importanza al simbolismo solare e, più specificamente, a quei periodi dell’anno in cui il Sole appare più alto e più basso nel cielo, corrispondenti ai solstizi estivo e invernale.
In alcune regioni gli originari siti funerari sono in seguito trasformati in strutture megalitiche. Una fra le più note è il complesso di Newgrange, in Irlanda, realizzato intorno al 3000 a.C. Il monumento funerario principale, di circa 60 metri di diametro, presenta un lungo corridoio d’accesso allineato con la posizione del Sole che nasce al solstizio d’inverno. In questo modo solo per alcuni giorni intorno al solstizio d’inverno i raggi solari che penetrano attraverso una stretta apertura percorrono tutto il corridoio fino a illuminare le tre stanze dove giacciono le ossa dei defunti. L’allineamento rivela dunque un’associazione simbolica fra la morte e il punto più basso toccato dal Sole sull’orizzonte. Monumenti funerari simili rivelano o lo stesso allineamento o uno simbolicamente affine verso il punto dell’orizzonte in cui il Sole tramonta al solstizio d’inverno.
Un altro esempio significativo, databile intorno al 2000 a.C., ha sede nei pressi di Aberdeen, nella Scozia nord orientale. Una serie di cerchi di pietre, realizzati da una società agricola dell’Età del Bronzo, presenta in una parte della circonferenza due pilastri verticali che sostengono una lastra orizzontale reclinata. Le lastre orizzontali appaiono scelte con attenzione in una cava lontana, trasportate sul posto e collocate sui due pilastri con estrema cura. Dei circa 100 cerchi di pietra individuati, più della metà è in stato di conservazione abbastanza buono per eseguire misurazioni. In ciascun cerchio, la congiungente dal centro della circonferenza al centro delle due pietre verticali di sostegno appare diretta verso sud-sud-ovest, e più precisamente verso il ristretto arco dell’orizzonte in cui la Luna piena tramonta in prossimità del solstizio estivo. Questo tipo di orientazione, che si riscontra in altri insiemi di cerchi di pietra di altre località scozzesi e irlandesi, è indizio di un culto diffuso fra le popolazioni del Nord Europa nel quale la Luna piena di mezza estate assume una qualche particolare importanza.
La maggior parte dei monumenti megalitici europei astronomicamente orientati risalenti fra l’Età della Pietra e l’Età del Bronzo segue tendenzialmente una delle direzioni dove il Sole sorge o tramonta all’estremo limite meridionale, una delle altre due direzioni dove la Luna sorge o tramonta all’estremo limite meridionale o, anche, una delle due direzioni dove il Sole sorge o tramonta all’equinozio, quando la durata della giornata eguaglia la durata della notte. Tali caratteristiche si riscontrano in vari siti preistorici del territorio italiano, come i cosiddetti “castellieri”, presenti in prevalenza nelle regioni settentrionali del paese (Veneto e Friuli). Si tratta di rilievi artificiali in terra battuta realizzati per sostenere antichi edifici per l’osservazione e la difesa del territorio. I castellieri, individuabili grazie alla forma geometrica del perimetro (ovale o ellittica), sono spesso orientati nella direzione del sorgere o tramontare del Sole al solstizio invernale. Nei complessi funerari gli orientamenti sono invece più differenziati. Per esempio, nell’area megalitica di Saint Martin de Corleans, in Val d’Aosta, risalente al II o III millennio a.C., si rilevano allineamenti con la posizione del Sole e della Luna in particolari momenti dei propri cicli. E ancora, nel sepolcreto di Mel, in provincia di Belluno, risalente all’VIII secolo a.C., gli ingressi delle sepolture risultano diretti verso il punto di levata della Luna piena al solstizio d’estate, verso il punto di levata del Sole al solstizio d’inverno e verso il punto di levata del Sole all’equinozio.
Molto più problematico è il caso di siti costituiti da un numero notevole di elementi, per i quali esiste la possibilità di realizzare fin troppi allineamenti. Un esempio di costruzione problematica è rappresentato dal complesso monumentale di Stonehenge, nei pressi di Amesbury, nell’Inghilterra meridionale, risalente alla seconda metà del III millennio a.C. Il complesso risulta così affascinante da essere preso di mira da studiosi di varia specie, i quali cercano di interpretarlo in tutti i modi possibili e immaginabili. Per certo si può dire soltanto che l’asse principale di Stonehenge, definito dal centro della costruzione circolare e dalla cosiddetta Heel Stone (Pietra del Calcagno), eretta separatamente verso nord-ovest, segue la direzione dei due punti dell’orizzonte in cui il Sole sorge al solstizio d’estate e tramonta al solstizio d’inverno. Tutti gli altri allineamenti rintracciati combinando fra loro le pietre del sito sono invece troppo imprecisi per superare con successo il vaglio dei test di attendibilità. Per quante siano le interpretazioni proposte, l’unico elemento certo di Stonehenge resta l’attenzione dei suoi antichi costruttori verso un simbolismo di tipo solare.
L’estrema prudenza costituisce una regola nel campo delle indagini archeoastronomiche, dove nessuna conclusione trova conferma nelle parole di un documento coevo. L’esame delle rovine preistoriche rivela al massimo la presenza di simbologie di vita e di morte attribuite alla ciclicità dei fenomeni riguardanti il Sole e la Luna. Inoltre occorre ricordare che quando si ha a che fare con i resti archeologici, gli allineamenti che si riscontrano non nascono da conoscenze astronomiche trascendentali possedute dalle culture più antiche. Gli allineamenti non sono realizzati a partire da calcoli più o meno raffinati, ma dalla diretta osservazione del Sole e della Luna nelle posizioni dell’orizzonte poi prese come riferimento per erigere le varie costruzioni.