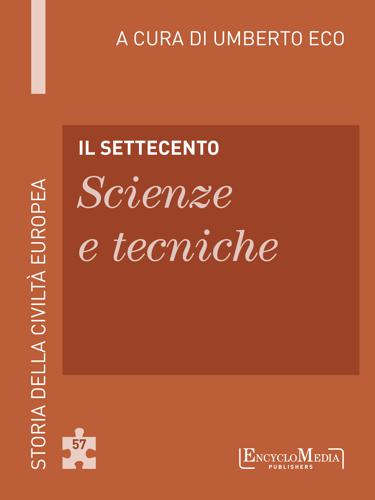Introduzione alla scienza e tecnologia del Settecento
Il contributo è tratto da Storia della civiltà europea a cura di Umberto Eco, edizione in 75 ebook
Il Settecento si presenta come un secolo caratterizzato da un vivace sviluppo delle scienze (che conoscono una crescente suddivisione e specializzazione disciplinare), delle istituzioni scientifiche (accademie, laboratori privati, gabinetti, biblioteche) e dell’editoria scientifica. Nella seconda metà del secolo si assiste inoltre al cauto inizio di un processo di professionalizzazione della scienza che da passatempo aristocratico o strumento di promozione sociale per facoltosi esponenti dei ceti professionali (ecclesiastici, medici, farmacisti, avvocati) si trasforma in una opportunità di impiego e di carriera per giovani ambiziosi privi di mezzi di sostentamento.
Premessa
La storiografia del periodo tende spesso a ignorare la pluralità di pratiche teoriche, sperimentali e letterarie che i contemporanei considerano come scienze, restringendo il campo delle ricerche a quelle discipline, figure e imprese intellettuali che sono entrate a far parte della tradizione scientifica occidentale. Così, gli esperimenti di personaggi come il celeberrimo teorico del magnetismo animale Franz Anton Mesmer, il leader rivoluzionario Jean-Paul Marat, che in giovinezza affida le proprie speranze di fama e di reddito a memorie di fisica e di chimica diligentemente inviate a tutte le accademie europee, o Johann Kaspar Lavater, il teorico della fisiognomica settecentesca, vengono spesso considerati alla stregua di bizzarre curiosità. Le ricerche degli ultimi due decenni mostrano invece che il panorama delle attività scientifiche – “giuste” o “sbagliate” che siano dal punto di vista della scienza moderna – è molto più ricco di quanto si sia ritenuto e che le tesi sostenute da Mesmer, Marat e Lavater, censurate o ignorate a livello delle grandi accademie scientifiche europee, incontrano il favore di un nutrito pubblico di lettori.
Scienze neglette e scienze pratiche
Nei Paesi più sviluppati dell’Europa dell’ancien régime, numerose pratiche scientifiche assumono un ruolo di crescente importanza sia per l’amministrazione dello Stato sia per iniziative private, quali la sperimentazione nella produzione metallurgica, lo sfruttamento di fonti di energia tradizionali come l’acqua o rivoluzionarie come il vapore, la prospezione mineraria e la costituzione di compagnie di assicurazione, o per lo sfruttamento delle risorse messe a disposizione dall’espansione del colonialismo.
Al personale scientifico si fa ricorso per risolvere problemi di ordine strutturale – marina, esercito, strade, ponti, finanze, esazione delle imposte – per stabilire le coordinate geografiche delle terre conquistate o da conquistare, per rendere più sicuri i viaggi transoceanici e di esplorazione. Parallelamente, si moltiplicano le piccole botteghe e le imprese artigianali impegnate nella costruzione di strumenti scientifici.
Il secolo di Newton
Una lunga e fortunata tradizione storiografica, attenta alle grandi scoperte e alle grandi figure in settori ritenuti di cruciale importanza per il progresso delle conoscenze, come la matematica e la fisica-matematica, definisce il Settecento “il secolo di Newton”. Sarebbe certamente errato non riconoscere l’importanza del lavoro di approfondimento e revisione critica dell’eredità newtoniana svolto da generazioni di matematici e fisici, molti dei quali – come Leonhard Euler, Jakob e Johann Bernoulli , Pierre-Louis Moreau de Maupertuis e Joseph Louis Lagrange – vengono contesi dalle più importanti corti europee, da Parigi a Berlino e San Pietroburgo. E sarebbe, del resto, parimenti riduttivo limitare una descrizione della scienza settecentesca alle sole discipline matematico-fisiche.
Per quel che concerne la matematica, le decisive innovazioni nel calcolo segnano la sconfitta del modello flussionale proposto da Newton e dai suoi discepoli e la fruttuosa ripresa del nuovo calcolo proposto da Leibniz, fino al perfezionamento dell’analisi infinitesimale e allo studio delle equazioni differenziali. Di grande portata sono anche i tentativi, condotti tra gli altri da Euler, da d’Alembert e da Lagrange, di unificare i principi generali delle leggi del movimento e di fondare una meccanica “razionale”, costruita su un piccolo numero di principi da cui poter procedere per rigorosa deduzione matematica. Il nuovo calcolo permette di consolidare l’edificio astronomico costruito da Newton e di fare della legge di attrazione universale, al centro di un vigoroso dibattito scientifico e filosofico nella prima metà del secolo, la chiave di volta per la costruzione di un sistema dell’universo che nell’ultimo quarto del secolo trova compimento nell’opera di Laplace.
Elettricità e chimica
Accanto allo sviluppo trionfale della matematica, della meccanica celeste e della fisica newtoniane, nuovi settori di ricerca, incentrati soprattutto sull’elettricità e sul magnetismo, attirano l’interesse dei dotti, delle corti, del pubblico colto e dei frequentatori delle fiere di città e di campagna. Sulla natura e le proprietà dell’elettricità le opinioni sono quanto mai divise, il che non impedisce la proliferazione di trattati e di esperimenti, la costruzione di strumenti sempre più sofisticati e il fiorire di un mercato di prodotti con cui effettuare esperienze sull’elettricità per divertire il pubblico colto. L’elettrologia settecentesca, che prende le mosse dal lavoro di Pieter van Musschenbroeck e Ewald Georg von Kleist, costruttori della famosa “bottiglia di Leida ” – un dispositivo che permette di accumulare le cariche elettriche – giunge a una svolta fondamentale nel marzo del 1800 con l’annuncio della costruzione della pila da parte di Alessandro Volta. Verso la fine del secolo, accanto al tentativo operato con successo da Charles Coulomb di spiegare l’azione delle cariche elettriche nei termini della fisica newtoniana, si assiste alla proliferazione di ricerche sull’elettricità vista come fluido etereo alla base del funzionamento del sistema nervoso degli animali – che trovano il loro punto di arrivo nella pubblicazione delle ricerche sull’elettricità animale di Luigi Galvani.
La chimica settecentesca si presenta come un settore disciplinare ancora strettamente legato alle pratiche e ai segreti del piccolo laboratorio, caratterizzato da forti tradizioni locali e da una fiorente produzione di speculazioni filosofiche sui quattro elementi che una lunga tradizione pone alla base di ogni composto materiale: fuoco, aria, acqua, terra. La scoperta della natura composita dell’aria da parte di Joseph Priestley e la rielaborazione teorico-sperimentale delle scoperte dello scienziato inglese operata da Antoine-Laurent Lavoisier producono una vera e propria rivoluzione nelle ricerche chimiche, con l’introduzione di una nuova nomenclatura filosofica, ispirata alle teorie di Condillac.
Il secolo della Natura
La relativa modernità delle scienze matematico-fisiche e la rivoluzione chimica introdotta da Lavoisier e dai suoi allievi hanno fatto sì che al Settecento si sia solitamente guardato per cogliere gli elementi che sono alla base dei successivi sviluppi ottocenteschi di queste discipline. Ma ricerche più recenti hanno evidenziato come accanto a sviluppi significativi se non addirittura epocali delle scienze matematiche, fisiche e chimiche, la cultura scientifica del Settecento sia di fatto caratterizzata da una forte attenzione verso le discipline naturalistiche e verso quell’insieme spesso eterogeneo di ambiti di ricerca noti col nome di histoire naturelle. I dibattiti sulla tassonomia botanica, zoologica e mineralogica, le diverse teorie cosmologiche e cosmogoniche proposte da autori spesso dotati di fertile fantasia, i tentativi di applicare la fisica cartesiana o newtoniana allo studio delle proprietà dei viventi, o al contrario la messa in opera di protocolli sperimentali volti a sottolineare l’irriducibilità dei fenomeni vitali alle leggi della fisica e della chimica e l’esplorazione di proprietà ancora misteriose dei viventi, come l’elettricità o lo studio dei singolari fenomeni del magnetismo animale, affascinano un pubblico sempre meno in grado di seguire le sofisticate manipolazioni matematiche della nuova astronomia o della nuova fisica, ma egualmente desideroso di contemplare l’infinita prodigalità e le meraviglie della natura.
Si guarda alla natura come a una miniera ancora inesplorata di ricchezze, come fondamento per una nuova estetica, una nuova morale e una nuova teologia liberate dal peso delle dispute dottrinali e settarie. Per tutto il Settecento, la teologia naturale trova nell’organizzazione animale e vegetale, nei meccanismi della generazione dei viventi, nelle miriadi di forme di vita e di delicate architetture organiche, un ricco materiale per esaltare l’opera del Creatore e i suoi disegni provvidenziali. Tuttavia, se nella prima metà del secolo la teologia naturale gioca un ruolo importante come diversivo alle dispute teologiche e al fanatismo religioso, il raggiungimento dello scopo finisce per conferire autorità ancora maggiore alle scienze, contribuendo senza volerlo alla diffusione del gusto per l’osservazione naturalistica e la narrazione delle meraviglie della natura.
Natura ed economia
La natura e le scienze promettono al grande pubblico la fine delle cicliche crisi di approvvigionamento che travagliano la vita di molti stati dell’ancien régime. I viaggi di esplorazione riportano in patria prodotti naturali come l’albero del pane o la patata (che nel Settecento inizia a diventare un alimento di larga diffusione) che infiammano l’immaginazione di governanti e governati, diffondendo l’illusione che l’acclimatazione di specie vegetali e animali scoperte nelle isole felici dei tropici o nelle terre australi permetterà in breve tempo di sfamare la crescente popolazione delle città.
Le scienze agricole conoscono un fiorire rigoglioso; così la fondazione di società dedite a promuovere il miglioramento scientifico delle tecniche di coltivazione e di allevamento, come quella dei Georgofili a Firenze (1753) – la prima in Europa insieme alla pubblicazione di riviste e di almanacchi indirizzati al mondo agricolo mostrano le possibili e benefiche applicazioni pratiche delle scienze naturali. Al Jardin des Plantes di Parigi vengono costruite grandi serre per gli esperimenti di acclimatazione dell’albero del pane e di molte altre piante esotiche da cui trarre legni pregiati, nuovi generi alimentari e nuove medicine; si progettano inoltre fattorie sperimentali sparse per tutta la Francia, per sfruttare al meglio le diversità geoclimatiche regionali e acclimatare il maggior numero possibile di animali e piante.
Anche nel campo delle nascenti scienze economiche, il sistema dei fisiocratici esalta il ruolo della natura come unica produttrice di ricchezze, contro un’industria e un commercio che si limiterebbero a rielaborare e a distribuire i suoi doni.
Natura ed etica
Nella riflessione etica e in particolare nelle opere di Jean-Jacques Rousseau, che rende popolari le escursioni botaniche tra il pubblico colto e l’aristocrazia europea, la natura incorrotta dagli equivoci costumi dell’uomo civilizzato appare in grado di fornire un fondamento sicuro per la costruzione di una comunità di saggi più giusta e più felice. In modo specularmente opposto, la letteratura clandestina esalta il ruolo delle passioni impiantate dalla natura nella costituzione umana, passioni che il clero, interessato solo a perpetuare superstizioni nelle quali nessuno più crede, cerca ipocritamente di reprimere. Bestseller come Thèrese la philosophe, o molte opere del conte Donatien-Alphonse-François (noto come Marchese) de Sade (1740-1814), rivelano alcuni esiti possibili e più scandalosi – ma non certo a ragione del contenuto pornografico – della cultura naturalistica settecentesca. Per de Sade l’ordine naturale è indifferente al male quanto al bene e anzi il concetto di bene propugnato dalla tradizione cristiana o da tanta filosofia è sempre destinato a soccombere, in quanto contrario agli istinti fondamentali che permettono la sopravvivenza.
Natura, filosofia, ateismo
Scandalo o quanto meno seria preoccupazione suscitano negli ambienti filosofici e teologici conservatori – ma non solo, vista l’opposizione di Voltaire alla dottrina – le speculazioni che accompagnano i dibattiti sulla generazione spontanea che riprendono vigore con la pubblicazione delle Nouvelles observations microscopiques di Joseph Needham (1745), fino alla refutazione della “generazione equivoca” da parte di Lazzaro Spallanzani (1729-1799) negli anni Settanta del secolo. Inoltre, scoperte come la generazione asessuata degli afidi delle piante da parte di Charles Bonnet o dei poteri di rigenerazione dei polipetti d’acqua dolce descritti nel 1740 da Abraham Tremblay, innescano un dibattito filosofico che vede impegnati i maggiori esponenti dell’illuminismo francese, da Denis Diderot e Pierre Louis Moreau de Maupertuis a Claude-Adrien Helvétius e Paul Henry Dietrich, barone d’Holbach. Per molti pensatori la natura vivente si presenta come un sistema di leggi di aggregazione e disgregazione di molecole dotate di poteri particolari – sulla cui definizione permane un certo disaccordo – in cui non esiste traccia di un ordine finalistico e che può fare a meno di un Dio creatore.
Nascita della biologia
A partire dalla seconda metà del secolo, lo studio delle leggi e delle caratteristiche peculiari dei viventi porta alla definizione di un nuovo ambito disciplinare, per cui si propone da più parti, con intenti e accentuazioni diversi, il nome di biologia. Per alcuni, come ad esempio gli esponenti della scuola medica di Montpellier quali Théophile Bordeu (1722-1776) e Paul-Joseph Barthez (1734-1806), la nuova disciplina dovrà marcare la radicale differenza dell’ordine della vita dalle leggi della materia; mentre per altri, come per Lamarck, la biologia è un capitolo della “grande fisica” che ha per oggetto i fluidi materiali e comprende la meteorologia, cioè lo studio dei fluidi atmosferici, l’idrogeologia, ovvero lo studio dei fluidi che scavano e trasformano la superficie terrestre, e appunto la biologia, la scienza dei fluidi che plasmano l’organizzazione animale e continuamente la trasformano, adattandola al mutare delle circostanze ambientali.
Catalogo dei viventi e studio dell’uomo
Meno controverse dal punto di vista della morale e dell’ordine pubblico, ma non prive di forti accenti polemici o di dottrine che richiedono l’intervento dei censori della Sorbona, sono le fortunate opere di autori quali Buffon, la cui Histoire naturelle conosce una straordinaria diffusione, o di scrittori che preferiscono seguire il rigore della tassonomia botanica e animale proposta dal naturalista svedese Linneo, grande avversario di Buffon. Anche gli esseri umani, per quel che concerne la loro struttura organica, sono soggetti della classificazione zoologica e la definizione dei criteri da adottare per mettere ordine tra le varie razze o specie umane, o stabilire quali siano gli animali a esse più affini, innesca nuovi dibattiti sul posto occupato dagli umani nell’ordine della natura.
Verso la fine del secolo si afferma la nozione di una scienza dell’uomo che ne esamini la struttura organica e affronti il tema delle sue caratteristiche intellettuali sotto il punto di vista della storia naturale. La nascita dell’antropologia fisica, il successo della fisiognomica o, con i primi anni dell’Ottocento, la grande diffusione delle dottrine frenologiche e di studi sul sistema nervoso umano e animale riflettono i diversi aspetti del processo di naturalizzazione della specie umana.
Il secolo della natura è anche il secolo del libro naturalistico, dei grandi cataloghi degli esseri animati e inanimati, delle descrizioni di terre esotiche e lussureggianti, dell’esaltazione di un mondo naturale che grazie alle scienze potrà finalmente soddisfare tutti i bisogni materiali, morali ed estetici dell’umanità.
Riforma della storia naturale e Rivoluzione francese
Gli ultimi anni del Settecento sono caratterizzati da due eventi molto diversi tra di loro, ma di notevole portata per lo sviluppo delle scienze. Si assiste infatti al fiorire di un vivacissimo dibattito sulla riforma della storia naturale; i riformatori si ispirano alla Philosophia botanica di Linneo, alle opere del filosofo Étienne Bonnot de Condillac e al saggio sulla nomenclatura chimica pubblicato nel 1788 da Lavoisier e dai suoi discepoli. Il detto di Condillac “la scienza è una lingua ben ordinata” ricorre in tutta la pubblicistica riformista: il metodo dell’analisi scomporrà i fenomeni studiati nelle loro parti componenti, discriminando tra le essenziali e le secondarie e un nuovo linguaggio, possibilmente formato di parole tratte da radici greche, opportunamente declinate con suffissi che riflettano le relazioni reciproche tra le parti essenziali studiate, permetterà di riflettere nella frase le proprietà degli oggetti indagati. Il linguaggio della nuova chimica diviene il modello per la nomenclatura della cristallografia, dell’anatomia comparata, della tassonomia zoologica e della nosologia medica.
Il secondo evento che segnerà lo sviluppo delle scienze europee è la Rivoluzione francese. Alle sciagurate teorie del materialismo e dell’ateismo scientifico, anzi, a una vera e propria cospirazione di filosofi e scienziati anche alcuni contemporanei, come il gesuita Barruel, fanno risalire la responsabilità degli eccidi rivoluzionari. Nel campo storiografico, invece, si è sottolineato come il movimento giacobino, con la sua soppressione dell’Académie des Sciences nel 1793 e l’uccisione di Lavoisier nel 1794 o la morte in carcere di Condorcet, sia portatore di una concezione della scienza più vicina ai deliri di Marat che alla rivoluzione scientifica della seconda metà del Settecento. In realtà, si è cercato di applicare a una società di ancien régime una concezione di univocità di rapporti tra politica e ideologia che mal si applica a un sistema di relazioni sociali fondato su legami familistici e di clan largamente trasversali; i più fedeli allievi di Lavoisier, ad esempio, sono giacobini convinti.
Così il giacobino Fourcroy, caposcuola del campo lavoisieriano, protegge a rischio della vita l’aristocratico proscritto Lacépède, portatore di una visione della scienza – buffoniana e antilavoisieriana – contraria a quella sostenuta dal suo protettore.
Fourcroy non può far nulla per salvare Lavoisier, condannato non per la sua chimica che le truppe rivoluzionarie diffondono in Europa, ma per il suo ruolo di esattore delle tasse del vecchio regime. Mentre l’aristocratico e filomonarchico Parmentier passa indenne la tormenta rivoluzionaria, grazie ai meriti ottenuti nel campo dell’alimentazione delle masse con la diffusione sistematica della patata e nell’ambito dell’esercito rivoluzionario con l’invenzione della galletta.
In Francia e in Europa il ruolo della scienza nella grande battaglia tra fede e ateismo, tra ordine monarchico e tentazioni repubblicane o democratiche, sarà al centro di un dibattito che percorrerà tutto l’Ottocento, dominato dall’ombra spaventosa, o a seconda dei punti di vista consolante, della Rivoluzione francese.