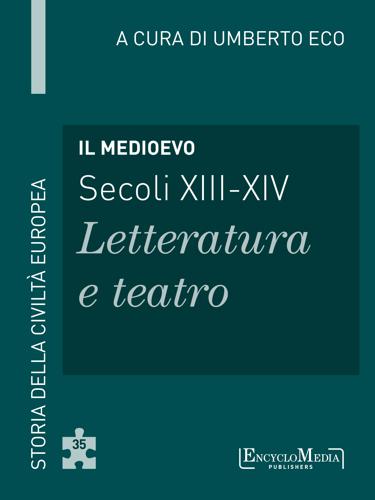Il Roman de la Rose
Il contributo è tratto da Storia della civiltà europea a cura di Umberto Eco, edizione in 75 ebook
Capolavoro del genere allegorico, il Roman de la Rose testimonia, già nella cronologia redazionale, le profonde trasformazioni in atto nella cultura e nella società francesi del Duecento. La prima parte del poema (4058 versi) risale ai primi decenni del secolo – opera di un altrimenti ignoto Guillaume de Lorris – e incarna ancora i gusti e la sensibilità del mondo altocortese. Diverso l’orizzonte della continuazione fiume di Jean de Meun (quasi 18000 versi), posteriore di oltre quarant’anni: tra enciclopedismo e satira è la realtà borghese e cittadina ad affacciarsi ora sulla scena del romanzo. La Rose, va sottolineato, ha goduto di un enorme successo di pubblico in tutta Europa, influenzando, tra gli altri, la poesia di Dante, Chaucer e Guillaume de Machaut.
I due autori
Guillaume de Lorris
Prologo Roman de la Rose, vv. 1-20
Alcuni sostengono che nei sogni
non ci sono che favole e menzogne;
ma si possono sognare tali sogni
che non sono affatto menzogneri,
al contrario si realizzano poi perfettamente,
e posso prendere come garante
un autore che si chiamava Macrobio,
che non considerò i sogni falsità,
anzi descrisse la visione
che ebbe il re Scipione.
Chiunque crede e dice
che è follia e dabbenaggine
credere che i sogni si realizzino,
se vorrà, mi consideri pazzo,
perché, per quanto mi riguarda, io credo
che il sogno è prefigurazione
di ciò che di bene e di male capita alle persone,
perché durante la notte i più sognano
molte cose indecifrabili
che poi si possono vedere apertamente.
Testo originale:
Aucunes genz dient qu’en songes
n’a se fables non et mençonges;
mes l’en puet tex songes songier
qui ne sont mie mençongier,
ainz sont aprés bien aparant,
si en puis bien traire a garant
au auctor qui ot nom Macrobes,
qui ne tint pas songes a lobes,
ançois escrit l’avision
qui avint au roi Scypion.
Qui c’onques cuit ne qui que die
qu’il est folor et musardie
de croire que songes aviegne,
qui se voudra, por fol m’en tiegne,
quar endroit moi ai ge fiance
que songes est senefiance
des biens as genz et des anuiz,
que li plusor songent de nuiz
maintes choses covertement
que l’en voit puis apertement.
in Antologia delle letterature romanze del Medioevo, a cura di P. Gresti, Bologna, Pàtron, 2006
Guillaume de Lorris
Dama oziosa Roman de la Rose, vv. 522-561
La porta, che era di carpine,
me l’aprì infine una fanciulla,
che era d’aspetto assai nobile e bella:
aveva i capelli biondi come un botton d’oro,
l’incarnato più delicato di quello d’un pulcino,
la fronte lucente, le sopracciglia arcuate;
lo spazio tra gli occhi non era piccolo,
anzi era abbastanza grande, in modo misurato;
aveva il naso ben fatto e come si deve
e gli occhi vivaci come [quelli dei] falchi,
per fare invidia ai malintenzionati.
Aveva un respiro dolce e profumato,
e il viso bianco e rosso,
la bocca piccola con le labbra un po’ carnose,
e nel mento aveva una fossetta.
Aveva il collo di giusta misura,
la carnagione più morbida di un vello,
non aveva né pustole né bubboni:
non c’era fino a Gerusalemme
una donna che avesse un collo più bello;
era liscio e vellutato al tatto.
La gola era bianca
come la neve sul ramo
quando ha nevicato da poco.
Aveva il corpo ben fatto e delicato;
non c’era da cercare in alcuna terra
una donna con un corpo più bello.
Fatta di filo d’oro aveva una graziosa corona,
mai nessuna fanciulla ne ebbe
una più bella né più straordinaria:
non avrei potuto descriverla in un giorno [intero].
Una corona di rose fresche
teneva sopra la corona d’oro.
In mano stringeva uno specchio,
e aveva, con una bella treccia,
decorata molto elegantemente la testa.
Per essere più elegante
aveva cucito entrambe le maniche;
e per evitare che le sue bianche mani
si raffreddassero, aveva un paio di guanti bianchi.
Testo originale:
Le guichoit, qui estoit de charme,
adonc m’ovri une pucele,
qui estoit assez gente et bele:
cheveus ot blons come bacins,
la char plus tendre que poucins,
front reluisant, sorciex votis;
li entr’ieuz ne fu pas petis,
ainz ert assez grant par mesure;
le nés ot bien feit a droiture
et les ieuz vers come faucons,
por feire envie a ces bricons.
Douce aleine ot et savoree,
et face blanche et coloree,
la bouche petite et grossete,
s’ot ou menton une fossete.
Le col ot de bone moison,
la char plus soëf que toison,
si n’i ot bube ne malem:
n’avoit jusqu’en Jerusalem
fame qui plus bel col portast;
polis ert et soés au tast.
Sa gorge estoit autresi blanche
come la nois desus la branche
quant il a freschement negié.
Le cors ot bien fet et dougié;
il n’esteüst en nule terre
nul plus bel cors de fame querre.
D’orfrois ot un chapel mignot,
onques nule pucele n’ot
plus cointe ne plus deguisé
ne l’avroie hui bien devisé.
Un chapel de roses tot frois
ot desus le chapel d’orfrois.
En sa main tint un miroër,
si ot d’un riche treçoër
son chief trecié mout richement.
Por estre plus apertement
ot andeus cousues ses manches;
et por garder que ses mains blanches
ne halassent, ot uns blans ganz.
in Antologia delle letterature romanze del Medioevo, a cura di P. Gresti, Bologna, Pàtron, 2006
Jean de Meun
La dimora di Fortuna
Roman de la Rose
In cima al monte, dove giù
pende, non dove è in piano su,
minacciando sempre un tracollo,
sempre pronta a subire un crollo,
pende la casa di Fortuna;
non c’è rabbia di venti alcuna
né tormento che possan dare
che non le tocchi sopportare,
e là spesso dalle tempeste
subisce aggressioni moleste.
Zefiro, dolce senza pari,
ci vien di rado a temperare
d’aspri venti gli assalti orrifici
coi suoi soffi dolci e pacifici.
Una parte della sua sala
va in su, quell’altra invece cala,
e sembra che debba cadere,
tanto pender si può vedere,
né tanto diversa dimora
vide nessuno, credo, ancora.
Da un lato luce tutta, infatti,
e d’oro e d’argento ha i muri fatti,
ed ha tutta la copertura
della medesima fattura,
fiammante di pietre preziose
molto chiare e molto virtuose;
la lodan tutti a meraviglia.
Dall’altro ha i muri di fanghiglia,
che un palmo non son spessi affatto,
ed il tetto ha di paglia fatto.
Da un lato se ne sta orgoliosa
perché è bella e meravigliosa,
e dall’altro trema impaurita
perché è debole e sbalordita,
e cinquecentomila e più
crepe la fendono su e giù.
E se cosa che non è stabile,
folleggiante essendo e mutabile,
ha residenza certa, allora
Fortuna ha là la sua dimora.
Testo originale:
En haut, ou chief de la montaigne,
ou pendant, non pas en la plaigne,
menaçant toujourz trebuichance,
preste de receveir cheance,
descent la maison de Fortune;
si n’est rage de venz nes une,
ne tormenz qu’il puissent ofrir
qu’il ne li couviegne a sofrir.
La receit de tantes tempestes
e les assauz e les molestes.
Zephirus, li douz venz senz per,
i vient a tart pour atremper
des durs venz les assauz orribles
par ses souflez mos e paisibles.
L’une partie de la sale
Va contremont, e l’autre avale;
si semble qu’el deie choeir,
tant la peut l’en pendant voeir;
n’onc si desguisee maison
ne vit, ce cuit, onques mais on.
Mout reluist d’une part, car gent
i sont li mur d’or e d’argent;
si rest toute la couverture
de cele meïsmes faiture,
ardanz de pierres precieuses,
mout cleres e mout vertueuses.
Chascuns a merveilles la loe.
D’autre part sont li mur de boe,
qui n’ont pas d’espès pleine paume;
s’est toute couverte de chaume.
D’une part se tient orguilleuse,
pour sa grant beauté merveilleuse,
d’autre tremble toute effraee,
tant se sent feble e esbaee,
e pourfendue de crevaces
en plus de cinc cenz mile places.
E se chose qui n’est estable,
come foleianz e mouvable,
a certaine abitacion,
Fortune a la sa mansion.
P. G. Beltrami, “Raccontare in poesia, tradurre in versi”, in Quaderni di filologia romanza, XIX, 2007
Alla grande officina del Roman de la Rose – poema d’amore allegorico di oltre ventimila octosyllabes – prendono parte due poeti del XIII secolo, entrambi originari dell’Orléanais. Del primo sappiamo solo ciò che scrive il secondo: proprio al centro dell’opera (vv. 10465-10648 dell’edizione Lecoy) Amore prende la parola per intonare l’epicedio di Guillaume, originario di Lorris, l’autore che ha cominciato il romanzo, interrompendolo poi al verso “car je n’ai mes aillieurs fiance” (“Perché non ho fiducia in altra persona”), v. 4058 (1225/1230 ca.). Segue una profezia: a Guillaume è destinato a succedere Jean Chopinel, detto il “bevitore” – o, in alcuni codici, Clopinel, ovvero “zoppo”: entrambi soprannomi di stampo goliardico – di Meung-sur-Loire, che, a distanza di più di quarant’anni, ne porterà a termine l’impresa (1269-1278 ca.).
Di Jean possiamo seguire le tracce anche al di fuori del testo. Chierico, magister, egli si forma nell’ambiente universitario di Parigi – forse con una visita alla Facoltà di Diritto di Bologna, negli anni 1265-1269 – dove matura una solida preparazione filosofica e teologica. All’attività poetica (oltre alla Rose, gli sono attribuiti il Testament maistre Jehan de Meun e il Codicile maistre Jehan de Meun) affianca quella, d’altissimo livello, di traduttore: dai moderni – tra cui la corrispondenza di Abelardo ed Eloisa – come dagli antichi – il De re militari di Vegezio dedicato a Jean de Brienne, conte di Eu, o la Consolatio di Boezio (480-526) dedicata allo stesso re Filippo IV il Bello) –.
Il Roman de la Rose di Guillaume de Lorris
Il nucleo originario del Roman de la Rose nasce all’intersezione di tre correnti maestre della letteratura medievale. L’impianto dell’opera, pensata come avventura onirica, dipende da quella tradizione di poemi allegorici che rampolla con speciale vitalità nella Francia del primo Duecento, a fini di edificazione religiosa. Dal Songe d’enfer (1210 ca.) di Raoul de Houdenc, che anticipa il motivo del sogno con cui si apre la Rose (vv. 1-20), al Tournoiement Antéchrist (1234-1240) di Huon de Méry, che unisce, come fa Guillaume, narrazione allegorica e autobiografia ideale (vv. 21 ss.).
Alla narrativa romanzesca, specialmente quella di materia bretone, appartiene invece il motivo della quête, “ricerca” (in questo caso della rosa), vettore dinamico inserito per rompere la staticità delle prime, lunghe carrellate allegoriche di vizi e virtù (vv. 139 ss.). Senz’altro Guillaume conosce i romanzi arturiani di Chrétien de Troyes: così, ad esempio, l’episodio della fontana di Narciso, “miroërs perilleus”, “specchio pericoloso” (v.1569) – già simbolo delle insidie d’amore in Can vei la lauzeta mover di Bernart de Ventadorn – rimanda alla prova della fontana incantata del Chevalier au lion (1177-1181) di Chrétien. Allo stesso tempo l’autore sembra ricordarsi dell’adespoto Lai de Narcisse (1165-1175), il primo adattamento volgare del mito ovidiano.
C’è infine, decisiva, l’influenza della lirica cortese. Come la fin’amors dei trovatori e dei trovieri, l’amore per la rosa è una forza nobilitante: il Roman mette in scena l’educazione sentimentale del giovane protagonista. Un “art d’Amors” (v. 38): richiamo all’Ars amandi di Ovidio, ma anche alla trattatistica amorosa medievale, non senza tracce dell’erotica clericale e goliardica – così la Vecchia guardiana (vv. 3902 ss.) fa pensare alla vetula protagonista della commedia elegiaca mediolatina. Un percorso iniziatico: dall’inclinazione amorosa ispirata dalla primavera (vv. 45-86), tema chiave della lirica cortese come di quella parafolklorica (molti i contatti con il genere della pastorella); all’incontro con le virtù trobadoriche nel giardino di Piacere (vv. 691 ss.), accompagnato da musiche e danze che ricordano le descrizioni dei divertimenti aristocratici nel Guillaume de Dole (1200-1228) di Jean Renart; alla sottomissione ad Amore secondo il rituale feudale (vv. 1879 ss.). Ecco poi, come a corte, i nemici dell’innamorato: il lauzengier, “maldicente”, simboleggiato da Malabocca, e il gilos, “geloso”, simboleggiato da Gelosia, rinchiudono la rosa in una fortezza inespugnabile (vv. 3493 ss.). Il protagonista, disperando di poterla raggiungere, rompe così in un lamento (vv. 3975 ss.) che porta l’eco della poesia di Jaufré Rudel, il cantore dell’amor de lonh, “amore da lontano”. L’amor cortese, del resto, è un sentimento che si alimenta nella tensione continua del desiderio e svilisce con la conquista. In questo senso si carica di particolare interesse l’ipotesi (David F. Hult, Self-fulfilling Prophecies) che l’incompiutezza del poema sia, piuttosto che un accidente, una scelta programmatica.
La grande novità di Guillaume sta nell’aver costruito, su questi modelli letterari, il primo roman centrato esclusivamente sui movimenti del cuore umano, mentre si afferma quel legame tra piano della realtà e piano della letteratura già anticipato nel romanzo adespoto Partenopeu de Blois (1188 ca.) e nel Bel Inconnu (1185 ca.) di Renaut de Beaujeu. Qui la realtà fa solo da cornice alla finzione del racconto, quando gli autori prendono la parola per dedicare l’opera alla donna amata, invitandola, da lettrice, ad intervenire a piacimento sull’intreccio. Nel Roman de la Rose, più radicalmente, Guillaume fa coincidere sogno e vita dello scrittore (“nel sogno non ci fu niente che non sia realmente accaduto”, vv. 28-29). Non ancora un’autobiografia poetica, come sarà poi la Vita Nova di Dante – troppo astratti e convenzionali i caratteri del soggetto della Rose. Piuttosto una sorprendente dilatazione romanzesca dell’io della lirica cortese, lungo quella linea di mediazione tra forme liriche e narrative inaugurata dal Guillaume de Dole di Jean Renart e dal Roman de la Violette (1227-1229) di Gerbert de Montreuil, che inseriscono testi lirici nel corpo del romanzo fingendo che siano i personaggi a recitarli. Nel tentativo di prolungare, in una nuova veste letteraria, l’utopia di una società aristocratica e oziosa in contrapposizione al mondo borghese e prosaico della città.
Il Roman de la Rose di Jean de Meun
Lo iato cronologico e culturale che separa Guillaume de Lorris – poeta ancora affascinato dagli ideali cortesi – da Jean de Meun – prototipo dell’intellettuale cittadino – si traduce, sul piano formale, in una chiara asimmetria, in una frizione tra le due parti del roman. Gli oltre 17mila octosyllabes di Jean rompono il delicato equilibrio tra narrazione e allegoria che caratterizza la Rose di Guillaume.
Il poema non è più da intendersi come semplice ars amandi, bensì come “miroër aus amoreus”, “specchio degli amanti” (v. 10621), dal latino speculum, che è il titolo specifico di diversi testi enciclopedici del XIII secolo. Ecco una prima chiave di lettura. Jean si serve della cornice allegorica della Rose per comporre un’opera di alta divulgazione, mettendo a disposizione del pubblico borghese una summa in volgare delle conoscenze del tempo, arricchita di exempla mitologici e storici, come di riferimenti all’attualità. Così, ad esempio, Ragione discute con Amante della teoria del linguaggio (vv. 6898 ss.) – nodo centrale della disputa sugli universali del XII secolo –, e Amico delle origini della società civile e del problema del libero arbitrio (vv. 8325 ss.), ricollegandosi al mito classico dell’età dell’oro, ma anche mettendo in campo precise conoscenze del diritto giustinianeo. L’intervento di Falso Sembiante (vv. 10976 ss.) è un attacco pamphlettistico all’ipocrisia degli ordini mendicanti che, nella Parigi di Jean, contendono ai magistri secolari il controllo dell’università. E qui Jean segue l’esempio di un altro poeta cittadino, come lui schierato dalla parte secolare, Rutebeuf. Natura e Genio (vv. 16035 ss.) – personaggi ripresi dall’allegoria del De planctu naturae (1171 ca.) di Alano di Lilla – disegnano un vasto affresco dell’universo e delle sue leggi: dall’alchimia, alla cosmologia, alla meteorologia e all’ottica.
In questa prospettiva il Roman de la Rose sembra adottare i modi, a tratti pedanteschi, della disputatio scolastica. Il protagonista, e con lui il lettore, è come lo studente che mette a confronto le diverse opinioni dei maestri (“bisogna provare tutto”, v. 21521): ma è solo attraverso questa maieutica che è possibile ricomporre il pensiero di Jean, che si presenta come glossatore dell’opera di Guillaume e ne rinnova, di fatto, la senefiance. Così alla fin’amor cortese, ma anche all’amore matrimoniale, viene contrapposto l’amore voluto da Dio, che consiste nel servire loialment Natura assecondando l’istinto sessuale e garantendo la perpetuazione della specie (vv.19409 ss.). Radicalizzazione del naturalismo cristiano della Scuola di Chartres, ma anche rivalsa dell’ideale ciceroniano dell’amicitia – nella lettura cristiana di Aelredo di Rievaulx, di cui Jean traduce il De spirituali amicitia – su ogni forma d’amore “interessato”, rappresentato da Amico e dalla Vecchia. Lo scarto tra le due Rose è simboleggiato dall’opposizione tra il giardino di Piacere, luogo di trufes et fanfelues, “inganni e futilità”, e della fonteine perilleuse, “fontana pericolosa”, di Narciso, e il paradisiaco giardino dell’Agnello, con la sua fonteine de vie, donatrice di vita e salute (vv. 19901 ss.). E ancora tra Narciso, inteso come mito della sterilità, e Pigmalione che, con l’aiuto di Venere, riesce invece a coronare il proprio amore per la statua (vv. 20787 ss.), anticipando di fatto il finale del roman. Espugnato il castello di Gelosia, la rose si presenta al protagonista come ymage, “statua, reliquia”, secondo uno stilema caro alla lirica trobadorica. La greve scena di devirginatio con cui si chiude l’opera (vv. 21185 ss.), appena mascherata dal velo allegorico, è dunque da un lato il trionfo dello slancio vitale, dall’altro la pungente parodia – già anticipata dal Chevalier de la Charrette di Chrétien – del mondo cortese di Guillaume.
La fortuna della Rose
Il Roman de la Rose è senz’altro uno dei testi volgari più amati e letti in tutto il Medioevo, secondo, per ampiezza della tradizione manoscritta, solo alla Commedia di Dante: oltre trecento testimoni, molti dei quali finemente miniati. Quindi, tra il 1481 e il 1538, ben 21 edizioni a stampa.
Aspetto precoce di questa enorme fortuna sono i rifacimenti e le traduzioni: dalla Rose fortemente interpolata e “moralizzata” di Gui de Mori, del 1280-1290, al Fiore considerato da alcuni attribuibile a Dante, che condensa la narrazione del roman in una catena di 232 sonetti, e alla versione in medio inglese attribuita a Geoffrey Chaucer. C’è poi l’influenza diretta sulla produzione di autori del tardo Medioevo come Guillaume de Deguileville, che riscrive il testo in chiave monastica nel suo Pélerinage de la vie humaine (1330-1355) e Guillaume de Machaut, che ne segue le suggestioni prima nel Dit dou vergier (opera giovanile), poi nel Remède de Fortune (1341 ca.) e nella Fonteinne amoureuse (1361 ca.), infine nel Voir dit (1364).
Da ultimo, al confine con l’età moderna, la Rose è al centro di una vivace querelle che anima gli ambienti culturali della Parigi d’inizio XV secolo: Christine de Pizan, la più celebre femme de plume dell’epoca, fustiga le posizioni misogine di Jean de Meun, sollecitando, con la sua Épître au Dieu d’Amour (1399), gli interventi d’intellettuali di spicco come l’umanista Jean de Montreuil e il grande teologo e cancelliere dell’università Jean de Gerson. Un dibattito letterario che per la prima volta, proprio sulla Rose, sperimenta temi cruciali come l’autorialità e la responsabilità creativa del poeta.