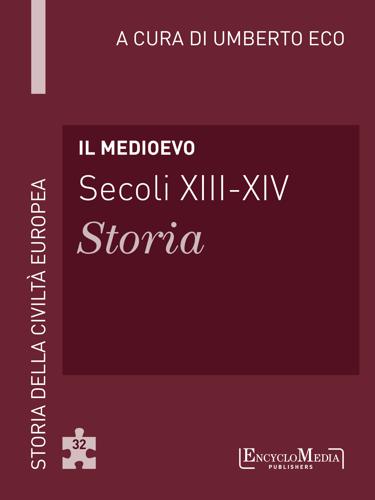Il Regno aragonese di Sicilia
Il contributo è tratto da Storia della civiltà europea a cura di Umberto Eco, edizione in 75 ebook
Il lunedì di Pasqua del 1282 a Palermo si scatena una rivolta contro il re Carlo I d’Angiò. I rivoltosi offrono la corona a Pietro III d’Aragona, capo dei fuorusciti ghibellini e filosvevi del Regno di Sicilia, perché marito di Costanza, figlia di Manfredi, il quale si impegna a rispettare le leggi del regno e a garantire che corona aragonese e siciliana costituiscono due entità distinte. Per poco più di 100 anni nell’isola regna una dinastia aragonese indipendente, nutrendosi di sogni autonomistici che lasciano una traccia duratura nei ceti dirigenti locali anche dopo l’inglobamento nei domini della corona d’Aragona avvenuto agli inizi del Quattrocento.
La forza della resistenza
Le modalità dell’assunzione della corona siciliana da parte di Pietro III e le successive vicende che vedono i successori del monarca costretti alla difensiva dai tentativi di riconquista angioina, determinano un peculiare rapporto tra ceti dominanti: non essendo Pietro un conquistatore ma un re eletto dall’aristocrazia isolana, i nobili rivendicheranno sempre nei confronti suoi e dei successori un ruolo di diretti interlocutori.
Pietro III, subito scomunicato da Urbano IV, è costretto a impegnarsi contro la potenza angioina, sostenuta pesantemente dal regno di Francia, venendo confortato dai successi conseguiti dalle milizie siciliane e dall’esperta flotta catalana.
Nel 1285 gli succede sul trono aragonese il primogenito Alfonso (1265-1291) alla cui morte diventa re d’Aragona il secondogenito di Pietro, Giacomo che, contravvenendo ai patti, non lascia la corona siciliana, nominando suo luogotenente in Sicilia il fratello Federico. Papa e Angioini si oppongono con particolare vigore a questa scelta e Giacomo, comprendendo di aver forzato troppo la situazione, accetta la pace che papa Bonifacio VIII impone ai contendenti: in base al trattato di Anagni (1295) la Sicilia torna agli Angioini. Giacomo in compenso viene investito dal pontefice dei regni di Sardegna e di Corsica.
Il ceto dirigente isolano, tuttavia, si oppone a tale soluzione, offrendo la corona a Federico (1272-1337), che dal 1296 si proclama re di Sicilia, scatenando un conflitto che lo vedrà opposto al fratello (il quale, però, quando avrà l’opportunità di sbaragliarlo si guarderà bene dal farlo). Nel 1302 le potenze belligeranti preferiscono arrivare a un accordo momentaneo (pace di Caltabellotta), che inizialmente trova l’ostilità pontificia. Alla fine Bonifacio VIII ratifica il trattato: Federico, che deve restituire agli Angioini la Calabria, ormai tutta in mano siciliana, regnerà sulla sola isola intitolandosi “re di Trinacria”; il titolo del Regno di Sicilia resta agli Angioini, ai quali l’isola tornerà alla morte di Federico III. Ma la corte siciliana si mostra quasi subito ostile all’accordo: Federico continua a intitolarsi re di Sicilia, rivendicando così l’intero regno, e nel 1321 associa al trono il figlio Pietro (1305 ca.-?), vanificando il nucleo del trattato di Caltabellotta. Ormai esiste un regno isolano di Sicilia retto da una dinastia aragonese indipendente, e a nulla varranno i ripetuti tentativi di conquista da parte dei sovrani angioini.
Questo nuovo regno ha caratteristiche pattizie ancora più marcate di quello di Pietro. La corona di Sicilia, infatti, si trova sul capo di Federico per esplicito atto di ribellione dei maggiorenti isolani, gli unici che nel corso degli anni reggeranno lo sforzo bellico di resistenza al nemico angioino. In cambio di questo vitale sostegno militare, le forze che hanno promosso l’elezione di Federico III ottengono un sempre maggior riconoscimento del potere esercitato sul territorio nonché l’ampliamento di domini e privilegi. I nobili di maggior peso, inoltre, detengono le principali cariche del regno e, con l’avallo regio, usurpano quote sempre maggiori di terre demaniali.
Il caso vuole inoltre che, morto Federico nel 1337, Pietro regni per pochi anni, morendo nel 1342, mentre i sovrani successivi, Ludovico e Federico IV, vivranno troppo poco per lasciare il segno della loro politica sull’isola. Queste circostanze porteranno a un periodo di serrate lotte di fazione tra gli schieramenti aristocratici che, divisi dietro le fuorvianti etichette di “Latini” e “Catalani” (denominazioni del tutto prive di matrice nazionalistica che al più indicano una linea di maggiore o minore apertura alla corona aragonese), saranno i veri attori della politica del regno, soprattutto a partire dalla morte di Giovanni, duca di Randazzo, unico personaggio di corte capace di bilanciare il peso dei diversi schieramenti. Non per caso, infatti, subito dopo questo momento di particolare crisi, l’isola torna quasi integralmente sotto l’egemonia angioina tra il 1354 e il 1357. Ma con la pace di Castronovo del 1362, le fazioni in lotta trovano un equilibrio che, tra alti e bassi, durerà per un trentennio. In questi anni alcune famiglie dell’aristocrazia isolana quali i Chiaromonte, i Ventimiglia, gli Alagona, i Peralta, i Moncada e i Rosso-Spatafora, insignite del titolo ereditario comitale e dotate di grandi patrimoni e di forti seguiti di armati e, in alcuni casi, anche di navi, riescono a controllare vaste aree del regno, garantendosi il possesso ereditario delle cariche pubbliche. Nel fare ciò inibiscono le velleità di crescita e di autogoverno delle città, nelle quali, comunque, si andranno sviluppando solidi ceti dirigenti, composti non solo da milites, ma anche da giuristi, proprietari terrieri, e mercanti-banchieri, originari, questi ultimi, soprattutto delle città liguri e toscane.
L’inserimento nella corona d’Aragona
Nel 1377 muore Federico IV, che lascia una figlia minorenne di nome Maria: il maestro giustiziere del regno, Artale Alagona (?-1389), in virtù dell’alta carica ricoperta si proclama allora, assieme ai rappresentanti di altre tre prestigiose famiglie aristocratiche dell’isola (Chiaromonte, Ventimiglia e Peralta), tutore dell’erede.
Inizia così il regime vicariale, durante il quale le quattro famiglie principali governano autonomamente nelle rispettive aree di influenza la quasi totalità dell’isola, arrivando anche, nel caso dei Peralta, a battere moneta. Ma i sovrani aragonesi non hanno mai smesso di considerare la Sicilia come una parte dei loro domini, rafforzando il legame con la dinastia isolana attraverso una serie di matrimoni incrociati che renderanno più facili al momento opportuno le loro rivendicazioni. Pietro IV d’Aragona, infatti, pur disconoscendo la successione di Maria, la fa rapire e la sposa a Martino, figlio omonimo del fratello, Martino duca di Montblanc. Nel 1392 Martino di Montblanc, maturate le condizioni per la conquista della Sicilia, fa armare una possente flotta che sbarca nell’isola, dove viene proclamato il diritto alla corona isolana del figlio Martino (poi detto il Giovane per distinguerlo dal padre). La volontà aragonese viene enfatizzata con la decapitazione del principale oppositore, Andrea Chiaromonte, fatto giustiziare davanti alla sua residenza palermitana, lo Steri, il 1º giugno 1392. Ai Martini occorreranno comunque almeno sei anni di dura guerra civile per conseguire l’effettivo potere: in questo periodo la maggiore aristocrazia isolana perde buona parte del prestigio conseguito nel corso del XIV secolo. Alcuni grandi lignaggi, come appunto i Chiaromonte, scompaiono del tutto, altri sono costretti ad accettare la riduzione drastica dei patrimoni. Di questo stato di cose si avvantaggiano soprattutto i nobili catalani venuti al seguito dei Martini e i molti Siciliani che si mettono al servizio della monarchia, sostenuta decisamente dai ceti dirigenti urbani che acquisiscono spazi di potere inconcepibili fino a pochi anni prima.
Nel 1398 Martino celebra la restaurazione regia presiedendo un parlamento a Siracusa, e prospettando l’unione della corona iberica con quella isolana. Martino, però, muore nel 1409, durante una spedizione contro i ribelli del regno di Sardegna. Gli subentra il padre e, alla morte di questi, la nuova regina siciliana Bianca di Navarra, in qualità di vicaria. Sia il Regno di Sicilia che quello d’Aragona rimangono senza titolari, per cui si rende necessaria un’assemblea di rappresentanti dei regni iberici a Caspe (1412), che stabilisce la successione al trono aragonese di Ferdinando di Trastàmara, secondogenito del re di Castiglia e Léon, che da Martino I eredita anche la corona di Sicilia. Da questo momento le corone dei due regni resteranno su una testa sola, e al governo dell’isola saranno destinati dei luogotenenti del sovrano: i viceré.