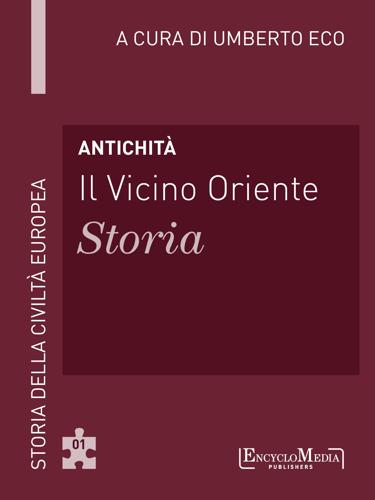Il crollo dell’Impero assiro e i suoi eredi: Babilonesi, Medi e Persiani
Il crollo dell'Impero assiro e i suoi eredi: Babilonesi, Medi e Persiani
Il contributo è tratto da Storia della civiltà europea a cura di Umberto Eco, edizione in 75 ebook
A metà del VII secolo a.C. l’Impero assiro è all’apice del suo potere. Pochi decenni dopo, le sue città principali sono distrutte e il suo ultimo re sconfitto. Il suo principale erede è l’Impero neobabilonese, fondato dall’usurpatore Nabopolassar, che con i Medi, suoi alleati, pone fine al dominio assiro sul Vicino Oriente. Benché l’Impero neobabilonese abbia la propria sede a Babilonia e nasca dal conflitto con l’Assiria, esso può essere considerato una sua continuazione dal punto di vista di molte delle istituzioni e delle pratiche amministrative. Negli anni Quaranta del VI secolo a.C. questo nuovo regno incontra a sua volta un potente avversario: l’emergente Impero persiano sotto il comando del suo re Ciro. Quest’ultimo, dopo aver sconfitto prima i Medi e poi il regno dei Lidi nel 539 a.C., batte Nabonedo, l’ultimo sovrano neobabilonese, e mette fine all’indipendenza di Babilonia.
La fine dell’Assiria
La guerra civile fra il re assiro Assurbanipal (668-631 a.C.) (sovrano dal 668 al 631 a.C.) e suo fratello Shamash-shumu-ukin (669-648 a.C.), re di Babilonia per volontà dello stesso Assurbanipal, è l’evento chiave dell’ultima fase della storia dell’Impero assiro. Dopo quattro anni di assedi e di battaglie in campo aperto (652-648 a.C.), le forze di Assurbanipal riescono a sconfiggere la coalizione di Babilonesi, Elamiti e tribù aramaiche, caldee ed arabe capeggiata da Shamash-shumu-ukin, ma a un prezzo molto alto. Il conflitto consuma anche le risorse delle province non ribelli dell’Impero assiro, mentre sia le città principali che le aree rurali di Babilonia e delle zone adiacenti, soffrono saccheggi, razzie e distruzioni. L’impero ne rimane così indebolito che la sua reazione alla sfida postagli da nuovi avversari pochi decenni dopo potrà solo essere di difesa. Ciononostante, la resistenza assira rinvia il definitivo crollo dell’impero al 609 a.C.,
anno in cui l’ultimo re assiro sparisce dalle fonti in seguito a una battaglia vicino alla città di Harran (oggi Urfa in Turchia), nell’ovest dell’impero ormai defunto.
La sequenza di eventi che portano alla fine dell’Impero assiro ha come scenario la regione di Babilonia, il secolare avversario dell’Assiria. Dopo la sconfitta di Shamash-shumu-ukin il Paese gode di una fase apparentemente tranquilla sotto il governo assiro, impersonato dalla figura di un certo Kandalanu (VII sec. a.C.). Poiché quest’ultimo è chiamato re di Babilonia solo nelle formule di datazione di atti giuridici babilonesi, alcuni ricercatori sostengono che Kandalanu non sia altro che uno pseudonimo per lo stesso Assurbanipal. Il controllo assiro sulla Babilonia si rivela ancora una volta fragile (e sarà l’ultima) fragile con i successori di Assurbanipal impegnati a contendersi il trono: il figlio primogenito del re, Assur-etil-ilani, l’eunuco (e generale) Sin-shumu-lishir e, dopo la morte di Assur-etil-ilani, suo fratello Sin-sharru-ishkun. Nel 626 a.C. a Uruk, nel sud della regione di Babilonia, approfittando della situazione instabile, si solleva contro gli Assiri Nabopolassar (626605 a.C.) (sovrano dal 626 al 605 a.C.). Poco dopo i ribelli da lui guidati si impadroniscono della capitale con l’aiuto dei suoi stessi abitanti e Nabopolassar si dichiara re della Babilonia. Negli anni seguenti gli Assiri contestano a Nabopolassar il controllo di alcuni centri urbani della Babilonia, talvolta con successo, e riescono persino a riprendere per breve tempo la città di Uruk, dove la rivolta aveva avuto origine, ma intorno al 615 a.C. la guerra si è già definitivamente spostata in Assiria. Qui i Babilonesi e i loro alleati iraniani, i Medi, assediano, conquistano e saccheggiano le città chiave del Paese, massacrandone gli abitanti (nella città di Nimrud, gli scavi archeologici hanno messo in luce resti di uomini affogati nei pozzi).
Nabopolassar e la rinascita babilonese
Solo indagini recenti hanno permesso di rivelare le origini di Nabopolassar. Lui stesso si dichiara “figlio di nessuno” nelle sue iscrizioni: un’affermazione abbastanza singolare per un re mesopotamico. La corrispondenza reale assira ritrovata a Ninive dimostra invece che Nabopolassar è figlio di un certo Kudurru, un babilonese di alto rango che per lungo tempo detiene l’incarico di governatore assiro della città di Uruk. La famiglia è probabilmente di origine caldea e appartiene alla tribù di Dakkuru. Questo significa che la lotta fra Nabopolassar e gli Assiri è una continuazione dei conflitti fra i capi delle tribù caldee e gli invasori assiri che già nell’VIII secolo a.C. si contendono la corona babilonese. Un episodio significativo al riguardo viene riferito al re assiro poco dopo l’inizio della rivolta. A scrivere sono i Babilonesi che stanno dalla parte assira: “Quando [abbiamo preso la città], abbiamo trascinato la salma di Kudurru fra le strade; i suoi figli, li abbiamo cacciati tutti da Uruk” (ABL 469:15’-vs 1). La profanazione delle tombe di famiglia di traditori è un noto costume assiro. Questa vendetta sui morti depriva i vivi dei loro antenati poiché l’esistenza del morto nell’aldilà è legata alla
continua venerazione della sua tomba da parte della famiglia.
Per i suoi figli, dunque, Kudurru sparisce, non esiste più – uno dei motivi per cui il re ribelle Nabopolassar sostiene di essere figlio di nessuno. Probabilmente vi sono anche ragioni di opportunità alla base della scelta di dissimulare il fatto che il primo re della nuova dinastia babilonese sia in realtà figlio di un prominente collaboratore degli occupatori assiri.
Nei primi anni del suo regno Nabopolassar lotta, non sempre con successo, nella Babilonia contro la tenace resistenza assira. Solo più tardi, quando la guerra si sposta in Assiria, il re può iniziare l’ambizioso programma della sua dinastia per la ricostruzione del Paese devastato: fa riscavare importanti canali di irrigazione, riparare le mura di Babilonia, e, soprattutto, rinnovare alcuni templi nelle città principali della regione.
Quest’ultimo, secondo l’ideologia del tempo, è un lavoro essenziale per guadagnare la benevolenza degli dèi per le imprese del re e per il benessere dei suoi sudditi. Le iscrizioni di tutti i re della nuova dinastia enfatizzano soprattutto questo aspetto delle loro attività. Diversamente dal costume assiro, il concetto babilonese della monarchia richiede che la legittimità di un regno si basi, non tanto su imprese belliche, ma piuttosto sull’accurata interpretazione del ruolo del re come “buon pastore” del suo popolo e come pio sostenitore e fautore del culto degli dèi del Paese. Ciò non significa che la nuova dinastia sia meno aggressiva verso i paesi adiacenti di quanto lo siano stati i suoi predecessori assiri. Poiché l’imperialismo babilonese non è basato su concetti religiosi simili a quelli che danno legittimazione all’espansione assira, si può dire che l’impero babilonese sia una creazione piuttosto opportunistica: come sovrani della Siria e del Levante, i re babilonesi sono di fatto eredi degli Assiri. Ciò nonostante, una volta impossessatisi di questo vasto territorio, i Babilonesi lo sfruttano e lo difendono tenacemente. Verso la fine del VII secolo a.C., i principali avversari ad ovest sono gli Egiziani, che contestano ai Babilonesi il controllo del Levante. È il figlio maggiore di Nabopolassar, Nabucodonosor (605-562 a.C.), a dirigere l’armata babilonese che sconfigge definitivamente le forze egiziane in una battaglia tenutasi a Karkemish nel 605 a.C., vittoria che il principe non può sfruttare subito a causa della morte del padre che lo costringe a recarsi in fretta a Babilonia. La cerimonia di incoronazione si svolge senza difficoltà e poco dopo Nabucodonosor può tornare sul campo di battaglia.
Nabucodonosor: l’Impero neobabilonese al suo apice
Negli anni seguenti il giovane re continua la politica del padre: ogni primavera le truppe babilonesi partono per il Levante, raccolgono il tributo dovuto al loro re dagli stati alleati e dai territori recentemente conquistati, e sottomettono una dopo l’altra le città e gli stati che oppongono resistenza.
Nel 604 a.C. viene presa la città di Ashkelon sulla costa del Mediterraneo, e il re di Giuda, Ioiakim (sovrano dal 609 al 598 a.C.), rende omaggio al re babilonese. Nel 601 a.C. Nabucodonosor si dirige verso l’Egitto. Le armate babilonesi ed egiziane si incontrano vicino al confine, forse nello stesso Egitto. La battaglia non ha un esito chiaro; secondo una cronaca babilonese “si inflissero vicendevolmente gravi perdite” (ABC 101 no. 5: 6), ragion per cui nell’anno seguente, sempre secondo la stessa cronaca, il re “riorganizzò i suoi numerosi carri da guerra e i suoi cavalli” (ABC 101 no. 5: 8), senza però poter iniziare la campagna: Ioiakim di Giuda approfitta subito di questa opportunità per liberarsi dal giogo babilonese. Ma per gli Egiziani le conseguenze dello scontro sono ancora più negative: da questo momento in poi non sono più in grado di contestare ai Babilonesi il controllo della Siria, del Levante e della Palestina. Una volta riordinate le sue truppe, Nabucodonosor agisce con decisione: nel 599 a.C. sconfigge degli Arabi irredentisti, e nel 598-597 a.C. assedia Gerusalemme. Il successore di Ioiakim, Ioiachin, si sottomette e viene deportato a Babilonia. La narrazione biblica e la cronaca babilonese trovano a questo punto conferma in alcune tavolette cuneiformi ritrovate nel palazzo di Nabucodonosor che parlano di cibo per alcuni giudei deportati che risiedono nel palazzo, fra cui anche il re Ioiachin.
Il successore di Ioiachin, Sedecia (597-586 a.C.), posto sul trono da Nabucodonosor, rispetta per alcuni anni l’alleanza con Babilonia. Intorno al 590 a.C., però, si piega alla pressione del partito filoegiziano interno alla sua corte contro il giudizio del profeta Geremia, il cui libro è la fonte principale per queste vicende, e si ribella a Nabucodonosor. Già l’anno successivo l’armata babilonese arriva a Gerusalemme. La città cade nel 587 a.C. e viene saccheggiata. I Babilonesi distruggono il tempio della città e gli abitanti vengono deportati in Mesopotamia: ha così inizio l’esilio babilonese degli Ebrei. Anche altre città della Palestina soffrono. Non solo le fonti scritte, ma anche gli scavi archeologici condotti in Palestina mettono in evidenza gli effetti delle incursioni dei Babilonesi. Quasi ogni sito rivela tracce di distruzione che risalgono a questo periodo e si notano un calo demografico e una contrazione dell’insediamento nel periodo seguente, risultato delle vicende belliche e delle deportazioni verso l’est che i Babilonesi, sempre influenzati dal modello dell’imperialismo assiro, usano come mezzo per rendere più facilmente controllabili le zone suddite e per guadagnare manodopera nelle parti centrali del regno. Probabilmente proprio in questi anni Nabucodonosor fa incidere una sua raffigurazione e un’impressionante iscrizione in una parete rocciosa nella valle di Brisa in Libano.
Celebrazione delle gesta di Nabucodonosor in Libano
Dall’iscrizione di Nabucodonosor nella valle di Brisa
Dopo la conquista di Gerusalemme, avvenuta nel 587 a.C., Nabucodonosor e l’esercito babilonese invadono la Palestina e le regioni circostanti, imponendo il proprio potere e controllo. Il testo seguente è un estratto dalla doppia iscrizione fatta incidere da Nabucodonosor su una parete rocciosa nella valle di Brisa in Libano; il re parla delle sue gloriose imprese in Libano e della grande immagine che lo ritrae accanto all’iscrizione con funzione di difesa e protezione dei territori conquistati
[...]
Aiutato dai miei signori, gli dèi Nabu e Marduk, spedii in Libano ripetutamente la mia armata per fare guerra. Ovunque cacciai via il suo [cioè, del paese] nemico e feci felice il paese. Riunii la sua gente dispersa e la riportai alle sue abitazioni. Feci ciò che nessun re precedente aveva fatto: mi feci strada nelle alte montagne, schiacciai le rocce dei monti, aprii dei valichi, creai un passaggio per i cedri destinati al re Marduk. Raccolsi tronchi lunghi e spessi di cedri, di bellezza eccezionale, di piacevolissimo aspetto, eccelso prodotto del Libano, come se fossero fasci di canne, e ne profumai l’acqua dell’Eufrate. Li feci arrivare a Babilonia in gran numero come se fossero dei [comunissimi] pioppi eufratici. Alla gente del Libano trovai pascoli sicuri, non permisi che nessun oppressore la minacciasse. Per far sì che nessuno la sottomettesse creai una mia immagine reale che l’avrebbe protetta.
[...]
R. Da Riva, The Twin Inscriptions of Nebuchadnezzar at Wadi Brisa
Celebrando le imprese del re, il testo afferma enfaticamente il controllo di Nabucodonosor nel Levante. In effetti sono poche le città della regione che riescono a sottrarsi al controllo babilonese. Lìala più importante fra di esse è la grande città mercantile fenicia di Tiro, che, protetta dalla sua collocazione su un’isola davanti alla costa, resiste a un assedio di ben 13 anni, (secondo uno storico greco citato da Giuseppe Flavio). Se ne trova una conferma indiretta in un passo del Libro di Ezechiele (Ez. 29,18), nel quale il profeta parla dello sforzo dei soldati babilonesi durante l’assedio di Tiro, quando “ogni testa diventa calva” (dalla frizione dell’elmetto) e “ogni spalla escoriata” (dal peso del materiale portato per la costruzione di mura di assedio, rampe ecc.).
La sequenza di cronache babilonesi, le fonti più attendibili per la storia politica di questo periodo, si interrompe dopo il 594 a.C., impedendo una ricostruzione dettagliata degli ultimi decenni del lungo regno di Nabucodonosor. Sappiamo che continuano le incursioni militari in Siria e nel Levante, anche se alcuni studiosi sostengono che si tratta soprattutto di spedizioni armate per la raccolta dei tributi dovuti al centro imperiale. Ci sono anche indicazioni che Nabucodonosor aveva l’’intenzione di tentare un attacco diretto all’Egitto, ma l’esito di questa impresa non è noto. Altrettanto vaghe sono le informazioni sulla situazione ai confini nord ed est dell’impero; persino il tracciato dei confini che separano il regno di Nabucodonosor dal territorio dei vecchi alleati di suo padre, i Medi, è difficile da ricostruire. Pare che mentre i Babilonesi dominano le pianure della Siria e delle zone all’est del Tigri, i Medi hanno le loro sedi sulle colline e gli altipiani che confinano con le pianure a nord-est. Conflitti aperti fra i due poteri non sono attestati nelle fonti, ma è indicativo che alcuni Babilonesi proscritti come conseguenza di discordie interne alla Babilonia fuggano nel Paese dei Medi in cerca di aiuto. La vecchia alleanza chiaramente non esiste più. Nel sud-est, una campagna militare di Nabucodonosor raggiunge il cuore del Paese della tradizionale rivale di Babilonia, l’Elam, e probabilmente ne conquista la capitale, Susa, ma le informazioni di cui disponiamo su questo episodio sono scarse.
Gli ultimi re babilonesi
Alla sua morte dopo 43 anni di regno (562 a.C.), Nabucodonosor lascia un impero vasto e apparentemente stabile il cui centro, Babilonia, attraversa una sorta di età dell’oro. La stabilità interna però si rivela transitoria: il figlio e successore di Nabucodonosor perde il trono dopo soli due anni. Il putsch è opera di Neriglissar (559-556 a.C., re dal 560 al 556 a.C.), generale presente all’assedio di Gerusalemme, capo di un’altra tribù caldea e per di più cognato del re secondo l’opinione (spesso attendibile) dello storico ellenistico Berosso. Pare che Nabucodonosor abbia invano cercato di creare un legame fra la sua tribù e quella di Neriglissar tramite un matrimonio con sua figlia. Neriglissar regna per quattro anni, riprendendo il filo conduttore della politica di Nabucodonosor con campagne nel nord-ovest. Dopo la sua morte nel 556 a.C. suo figlio gli succede sul trono, ma dopo pochi mesi viene deposto e ucciso a seguito di un’altra ribellione.
Questa ribellione è opera dell’ultimo e più enigmatico re neobabilonese, Nabonedo (555-539 a.C., sovrano dal 555 al 539 a.C.), e di suo figlio Belshazar. Le origini del nuovo re sono note solo in parte. Non appartiene a una delle famiglie reali, suo padre viene nominato in una sua iscrizione, ma il suo rango e il suo ruolo nello Stato babilonese (se ne aveva uno) rimangono poco chiari.
Il titolo particolare (rubû, grande) che gli attribuisce suo figlio lascia intravvedere un’origine tribale, caldea. La madre di Nabonedo invece è ben conosciuta grazie alla sua cosiddetta “autobiografia”, in realtà un’inscrizione voluta dal re suo figlio: Adad-guppi è una sacerdotessa del dio della Luna, Sin, della città di Harran, nell’ovest dell’Impero. Sotto Nabucodonosor e Neriglissar, Nabonedo ha un incarico militare, e l’esercito babilonese è probabilmente l’appoggio di cui si serve per raggiungere il trono (sul quale dice in un’iscrizione di non aver avuto ambizioni: finta modestia di un usurpatore?).
I primi anni del nuovo re sono segnati da riforme amministrative che possono essere interpretate come una continuazione della politica interna di Neriglissar. Nel suo terzo anno di regno tuttavia Nabonedo si ritira dalla Babilonia (una cosa inaudita per un re babilonese) e porta il suo esercito in Arabia. Lì conquista la città-oasi di Teima che gli serve da base per il decennio seguente. Nel frattempo suo figlio Belshazar gestisce l’amministrazione della Babilonia in vece del padre. La festa religiosa più importante però, la festa del Nuovo Anno nella capitale, non può avere luogo a causa dell’assenza del re, la cui interazione con la somma divinità, Marduk, è la parte centrale del rituale. Secondo alcuni studiosi questa situazione crea un forte antagonismo fra il re e i sacerdoti di Marduk, un antagonismo che il re nutre con la sua predilezione per il dio della Luna, Sin, a svantaggio di Marduk. Sempre secondo gli stessi studiosi, il quasi esilio autoimpostosi da Nabonedo è dovuto a questo conflitto all’interno del regno (lo stesso re parla in un testo in parole generali dell’ingratitudine e del tradimento del popolo babilonese) così come il crollo rapido dell’Impero babilonese nel 539 a.C., quando il re persiano Ciro (559-530 a.C.) conquista il Paese apparentemente senza grandi difficoltà. In realtà, questa interpretazione è basata soprattutto su alcuni testi di propaganda scritti dopo i fatti. Questi mirano ad esaltare il conquistatore Ciro e a denigrare il suo avversario Nabonedo agli occhi del pubblico babilonese e quindi, come fonti storiche, sono sospetti. Le fonti contemporanee sono invece molto meno chiare. È vero che alcune iscrizioni di Nabonedo contengono passi che lasciano intravvedere un certo favore per il dio della Luna, ma la maggior parte di essi si trova nelle iscrizioni che parlano della ricostruzione del tempio del dio a Harran e per questa ragione lo esaltano con particolare enfasi: debole evidenza per una presunta “eresia” di Nabonedo e le sue presunte riforme religiose. La ragione per la permanenza del re a Teima rimane comunque poco chiara. Al suo ritorno egli riprende il controllo della gestione del Paese, apparentemente senza incontrare resistenza. Il re designa alcuni nuovi amministratori e prosegue sulla strada delle riforme cominciate dieci anni prima. Da un punto di vista militare si accinge a respingere la minaccia persiana che preme sui confini ad est della Babilonia. Le sue iniziative si rivelano poco efficaci: nel 539 a.C., Ciro sconfigge l’esercito babilonese, prende la capitale del Paese e mette fine all’indipendenza babilonese in una sola breve campagna. Da questo punto in poi di Nabonedo non si hanno più notizie sicure.
I Persiani
I nuovi dominatori, i Persiani, devono in parte la loro ascesa alla vittoria sui vecchi alleati dei Babilonesi, i Medi. Quest’ultimi, un popolo iranico le cui sedi si trovano sulle colline e gli altipiani al nord-est della Mesopotamia settentrionale, vengono spesso considerati, insieme ai Babilonesi, gli eredi dell’Impero assiro. La scarsità di fonti contemporanee tuttavia rende difficile la ricostruzione del loro ruolo nelle vicende politiche del nostro periodo. La supposizione che ai Medi vada attribuita la creazione di un grande impero centralizzato sulle orme dell’Impero assiro è dovuta innanzi tutto alla storiografia greca, cioè, a Erodoto e a Ctesia. Dalle loro opere traspare l’idea di una netta translatio imperii dagli Assiri ai Medi e dai Medi ai Persiani. Le fonti greche parlano di un re medo, di una capitale (Ecbatana), di una corte stabile; in breve, creano l’immagine di un regno simile a quello assiro o persiano. Le fonti vicino-orientali, però, (cronache babilonesi e iscrizioni reali babilonesi), molto più vicine ai fatti e molto più attendibili, descrivono i Medi come un gruppo etnico piuttosto amorfo, più simile a una confederazione tribale che a un regno centralizzato. I capi di questa confederazione vengono solo raramente designati come re nei testi mesopotamici, che fanno una chiara distinzione fra le strutture e le istituzioni mede e quelle assire e babilonesi. Un vero impero medo quindi non è mai esistito, il che però non toglie nulla all’importanza rivestita dai Medi riguardo la fine dell’Impero assiro. Alcune fonti babilonesi attribuiscono esplicitamente la distruzione delle città assire e dei loro templi alle orde barbare dei Medi: “Il re degli umman-manda [i Medi] appianò tutto in su e in giù, a destra e a sinistra, come un diluvio... egli distrusse i loro [scil. degli Assiri, MJ] luoghi sacri, non risparmiò nessuno, devastò le loro città, facendo strage più orribile di un diluvio”, dice Nabonedo in una sua iscrizione (Schaudig, Die Inschriften Nabonids [2001] 516 II 2’-31’), per poi aggiungere che il pio re babilonese, Nabopolassar, chiaramente “non interferì in nessun modo con i culti degli dèi” (ibid. II 36’-37’). Lo scopo propagandistico di questo testo è palese, ma l’immagine dei Medi qui trasmessa riappare coerentemente anche altrove e non può essere del tutto sbagliata. Non è un caso che la designazione per i Medi usata da Nabonedo letteralmente significa “uomini? forse.”. In qualche modo tuttavia i Medi controllano per un certo tempo parti dell’altopiano iraniano e delle zone montagnose dell’Iraq settentrionale, resti del defunto Impero assiro che non fanno parte del suo successore, l’Impero babilonese. Questa dominazione meda finisce dopo uno scontro fra i Medi e un altro popolo iranico, i Persiani appunto.
Nei primi decenni del VI secolo a.C., i Persiani si trovano già nel sud-ovest dell’Iran attuale, negli altipiani della zona conosciuta ai Greci come Persis, e nelle pianure e colline ad ovest di questa zona. Il primo re persiano degno di nota è Ciro (sovrano dal 558 al 520 a.C. ca.), fondatore dell’Impero. Secondo un’iscrizione di Nabonedo, è lui che mette fine al regno (se possiamo considerarlo tale) dei Medi. Per ragioni religiose, Nabonedo presenta il re persiano come uno strumento, un servo dei suoi propri dèi, che ne fanno uso per eliminare la minaccia dei barbari Medi. Nel testo, il re babilonese parla dei Medi agli dèi, e loro, per aiutarlo, “mobiliarono contro di lui [scil. il capo dei Medi] Ciro, il re di Anzan [= Persis], il suo servo umile, che con le sue poche truppe disperse le gigantesche orde dei Medi” (Schaudig, Die Inschriften Nabonids [2001] 417 I 27-28). Nella visione di Nabonedo quindi Ciro è un vassallo dei Medi che si ribella con successo ai suoi signori. Questo succede intorno al 550 a.C; negli anni seguenti, Ciro conquista il Paese di Urartu in Iraq e Siria settentrionali e distrugge il regno di Lidia ad ovest di questa zona. Con la sua rapida vittoria sulla Babilonia nel 539 a.C., prende forma l’Impero persiano, uno Stato che (in modo tutt’altro che statico) controlla quasi tutto il Vicino Oriente fino all’avvento di Alessandro il Macedone (356-323 a.C.).