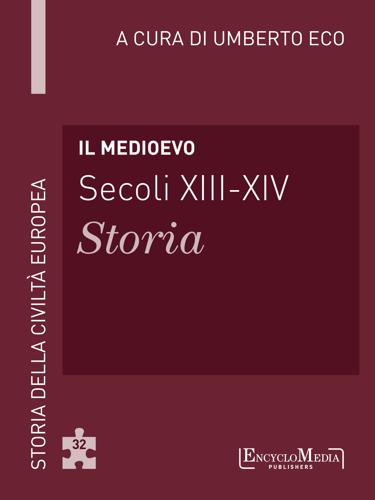Gli imperi coloniali
Il contributo è tratto da Storia della civiltà europea a cura di Umberto Eco, edizione in 75 ebook
Durante l’Ottocento gli imperi coloniali degli Stati europei si ingrandiscono notevolmente, nonostante l’indipendenza dell’America Latina. Alle tradizionali potenze coloniali – come Francia e Gran Bretagna – si aggiungono nuovi protagonisti, quali la Germania, il Belgio, l’Italia, e la rivalità nei territori d’oltremare porta nuovi motivi d’attrito fra le potenze europee.
Le due fasi del colonialismo europeo
Alla vigilia della prima guerra mondiale, quasi tutto il Vecchio Mondo è sotto il controllo delle potenze coloniali europee. In Africa solo l’Etiopia e la Liberia sfuggono a questo destino, mentre in Asia, Cina, Siam, Afghanistan, Persia e Impero ottomano conservano una precaria e spesso solo formale autonomia.
L’espansione degli imperi coloniali nel corso dell’Ottocento, il secolo durante il quale il Nuovo Mondo si sottrae definitivamente alla tutela europea, può essere suddivisa in due fasi caratterizzate da ritmi e modalità diverse: la prima va dal Congresso di Vienna al 1880 circa, la seconda da questa data fino alla prima guerra mondiale.
Nel primo periodo, l’espansione coloniale – pur notevole – ha un carattere poco sistematico ed è spesso il risultato di iniziative autonome delle autorità coloniali, per far fronte a rivolte locali o a vuoti di potere che minacciano gli interessi degli Stati europei. Nella seconda fase, la corsa ad accaparrarsi territori d’oltremare rientra invece in una congiuntura di forti rivalità politiche ed economiche fra le potenze europee: in questo contesto l’iniziativa torna nelle mani delle diplomazie che attuano una sistematica spartizione dei territori e delle sfere d’influenza.
L’Africa tra il 1815 e il 1880
All’alba del XIX secolo, la presenza europea in Africa è ancora limitata ad alcuni avamposti lungo le coste atlantiche, dell’oceano Indiano e del Mediterraneo, dominati da potenti Stati musulmani più o meno legati all’Impero ottomano. Lo sfruttamento della risorsa più importante dell’Africa subsahariana, gli schiavi, viene infatti organizzato con la complicità di Stati indigeni e inizialmente non richiede l’occupazione diretta da parte degli Europei. Nella prima metà del secolo, però, questa situazione cambia radicalmente.
L’intervento francese in Algeria inizia nel 1830, in parte per motivi di prestigio, in parte per eliminare la pirateria barbaresca. La Francia pensa inizialmente di limitarsi all’occupazione di Algeri e Bona, ma la rivolta scoppiata nel 1834 la porta a un coinvolgimento sempre più esteso, fino alla completa occupazione del Paese verso il 1880, a cui fa seguito un afflusso di coloni francesi.
Anche l’istituzione del protettorato francese sulla Tunisia è il risultato di una concatenazione in parte imprevedibile di avvenimenti e della rivalità fra le potenze europee. I debiti dei governanti tunisini con alcuni Stati europei portano infatti a un primo intervento europeo e a una conseguente rivolta dei territori occupati, che nel 1881 provoca il diretto intervento francese, al fine di prevenire le mire italiane.
L’intervento in Egitto è invece legato alla presenza strategica del canale di Suez e si conclude nel 1882, quando la Gran Bretagna – che considera il controllo del canale di fondamentale importanza per i collegamenti con l’India – impone il suo protettorato, dopo la repressione della sollevazione islamica; una soluzione che provoca però il risentimento francese.
Anche in Africa occidentale non siamo di fronte a sistematici disegni di conquista quanto a una concomitanza di fattori che vanno dall’attivismo missionario alla concorrenza commerciale tra le potenze europee. Un ruolo di rilievo hanno gli avamposti europei sulla costa che di loro iniziativa stringono accordi con i potentati locali, estendendo la propria influenza.
In realtà, gli Europei non mirano a dominare i territori dell’Africa, ma a garantire la sicurezza e il controllo dei traffici lungo le coste, e per far questo devono estendere la loro presenza. Progressivamente si vanno così definendo sfere di influenza abbastanza fluide: i Francesi in Senegal, Gambia e Sierra Leone, gli Inglesi sulla Costa d’Oro e in Nigeria, mentre più a sud si trovano le colonie portoghesi dell’Angola e del Mozambico, poco dinamiche in questa fase.
Particolarmente complessa è la situazione nell’Africa del Sud, dove gli Inglesi devono fare i conti con gli indigeni e con la presenza degli irrequieti coloni di origine olandese, i Boeri. A partire dagli anni Trenta i Boeri si spostano verso il Transvaal e il Natal, fondando due repubbliche autonome. Seguendo una politica oscillante, nel 1842 la Gran Bretagna occupa il Natal, ma nel 1852 riconosce il Transvaal e nel 1854 la colonia dell’Orange, per poi annettere nuovamente il Transvaal dal 1877 al 1881. È comunque la scoperta di giacimenti di diamanti che nei primi anni Ottanta imprime una svolta alle vicende della regione.
Gli Europei in Asia, nel continente australe e nel Pacifico
Nella prima parte del XIX secolo, anche l’espansione europea in Asia non è il frutto di un piano prestabilito. La principale preoccupazione della politica inglese in Asia è la sicurezza dell’India; l’intervento inglese lungo la frontiera nord-occidentale dell’India britannica, infatti, mira in primo luogo a stabilizzare la situazione nel Punjab e a controllare l’Afghanistan, per prevenire la crescita dell’influenza russa. Il Punjab e i territori dell’odierno Pakistan vengono annessi fra il 1842 e il 1848, mentre l’Afghanistan diventa uno Stato cuscinetto indipendente. Nel frattempo, con il dominio diretto di alcuni principati prima semi-indipendenti, cresce il potere inglese nell’interno dell’India.
Fra il 1857 e il 1858, con la ribellione dei sepoys, i soldati indigeni al servizio della Compagnia, il dominio inglese attraversa un momento di gravissima crisi. Dopo la repressione della rivolta, la responsabilità del governo indiano passa direttamente al governo inglese e la regina Vittoria riceve il titolo di imperatrice dell’India.
Anche verso oriente l’espansione è dettata da circostanze specifiche e in primo luogo dall’esigenza di far fronte, nella prima metà del secolo, alla minaccia dell’espansionismo birmano. L’intervento in Malesia è invece provocato dall’attività dei pirati. Gli Inglesi cercano comunque di limitare il loro impegno, preferendo stipulare dei trattati che trasformano gli staterelli locali in protettorati.
All’inizio dell’Ottocento la Francia, invece, non ha più possedimenti in Asia, salvo qualche base in India, come Pondichéry.
L’intervento francese in Indocina inizia nel 1847, come reazione alla persecuzione inflitta dai sovrani locali ai missionari francesi. Dal 1858 al 1860, truppe francesi occupano la zona di Saigon e, a partire da questo primo nucleo, annettono il resto dell’Indocina, spesso per iniziativa di funzionari locali. L’espansione procede in direzione del Tonchino, del Laos e della Cambogia che viene però annessa solo verso la fine del secolo.
L’espansione russa in Asia centrale avviene con modalità in parte diverse rispetto alle imprese degli altri Paesi europei, in quanto porta all’annessione di territori direttamente confinanti con quelli metropolitani.
Anche in questo caso l’intervento russo mira inizialmente a pacificare e a controllare una zona turbolenta alle sue frontiere, e a fronteggiare una possibile espansione inglese dall’Afghanistan. Il risultato finale è comunque l’annessione, fra il 1850 e il 1880, di tutta la zona fra il mar Caspio, il lago Aral e il Balkhas, abitata da popolazioni di lingua turca.
In Asia orientale l’iniziativa viene presa dal governatore generale di Irkutsk, che impone alla Cina di cedere la zona dell’Amur e quella parte di costa sul Pacifico in cui sarebbe sorta la città di Vladivostock.
L’espansione inglese nel Pacifico è in larga misura iniziativa dei coloni australiani. Nel 1820 una colonia di europei si insedia in Nuova Zelanda e nel 1840 i difficili rapporti con i Maori portano l’Inghilterra a dichiarare la propria sovranità sull’isola; nel 1874 gli Inglesi occupano, poi, anche le isole Figi.
La penetrazione francese è, in un primo tempo, il risultato degli interventi della marina militare in appoggio alle missioni cattoliche. Nel 1847 viene riconosciuto il protettorato francese su Tahiti e sulle isole Marchesi, e nel 1853 la Francia si assicura la Nuova Caledonia.
L’epoca della spartizione (1880-1900)
Nell’ultimo ventennio del secolo, l’espansionismo europeo oltremare assume un vero e proprio carattere imperialistico e sistematico. Le ragioni di questo cambiamento risiedono nella nuova situazione politica che si è creata in Europa con la nascita di nuovi Stati, quali l’Italia e in particolare la Germania. I territori d’oltremare diventano il teatro di una serrata competizione strategica e di prestigio, nonché merce di scambio nelle trattative diplomatiche.
Al fattore politico, che contribuisce all’espansionismo europeo, va poi aggiunto quello economico. Nel clima di rinnovato protezionismo che segue la Grande Depressione, molti in Europa pensano che sia essenziale garantirsi mercati protetti nelle colonie, come sbocco per i prodotti industriali e per i capitali in cerca di investimenti, ma anche per la popolazione giudicata in eccesso, come nel caso dell’Italia.
In questa fase entrano per la prima volta nel novero delle potenze coloniali anche Stati non europei, come gli Stati Uniti e il Giappone. A dare il via alla nuova fase sono le rivendicazioni avanzate dalla Germania di Bismarck nel 1884-1885.
Nel 1884, la Germania dichiara il protettorato sul Togo e sul Camerun e, l’anno seguente, su un tratto di costa dell’Oceano Indiano di fronte a Zanzibar, nell’odierna Tanzania.
L’iniziativa tedesca provoca una prima spartizione dell’Africa. Il re del Belgio Leopoldo si vede riconosciuto lo Stato libero del Congo e la Francia, che vede accettate le sue rivendicazioni su parte del Congo, cerca di estendere la sua sfera d’influenza nell’Africa occidentale e centrale.
Da parte loro, gli Inglesi pensano all’Africa soprattutto in funzione dell’India; il loro scopo principale è quello di mantenere il controllo sulla zona del canale di Suez e sulla colonia del Capo, da cui passano le rotte per l’Oceano Indiano. In questa prospettiva Cecil Rhodes sogna un impero britannico che si estenda senza soluzione di continuità dall’Egitto al Sud Africa, attraverso il Sudan, l’Uganda, lo Zambia e la Rhodesia, una continuità territoriale che la colonia tedesca del Tanganika rende però impossibile.
Nell’ultimo decennio del secolo e nei primi anni del Novecento, la definizione delle rispettive sfere d’influenza e la concreta presa di possesso dei territori in questione provoca attriti e incidenti fra le potenze europee: tra Francia e Gran Bretagna in Africa occidentale e nel Sudan, tra Francia e Germania in Marocco e tra Gran Bretagna e Germania in occasione delle guerre combattute dalla Gran Bretagna contro i Boeri (1899-1902).
L’Italia riesce a ritagliarsi dei possedimenti in Eritrea e in Somalia, ma ad Adua (1896) fallisce disastrosamente il tentativo di conquistare l’Impero etiopico che così, alla vigilia della prima guerra mondiale, è il solo Stato africano a sottrarsi al dominio europeo.
In Asia i processi già avviati nella prima parte del secolo giungono a compimento con l’occupazione francese del Tonchino (1884) e inglese della Birmania (1885). Il Siam conserva la sua indipendenza in quanto Stato cuscinetto fra i domini dei due Stati europei.
Nel Pacifico, dopo la guerra fra Spagna e Stati Uniti nel 1898, le potenze si spartiscono i possedimenti spagnoli. La Germania che già aveva imposto un protettorato su parte della Nuova Guinea e su Samoa, ottiene le isole Caroline, Marianne e Pelew; gli Americani le Filippine e Guam e annettono definitivamente le Hawaii.
La spartizione degli arcipelaghi del Pacifico viene perfezionata con alcuni accordi fra le potenze riguardanti le Samoa, Tonga e le Nuove Ebridi.
In Asia rimangono però alcuni Stati indipendenti di grande rilievo. Oltre agli Stati cuscinetto dell’Afghanistan e del Siam, anche la Persia, l’Impero ottomano e soprattutto la Cina sfuggono almeno formalmente alla presa europea, anche se devono fare importanti concessioni di carattere commerciale e territoriale, come, ad esempio, la cessione in affitto di Hong Kong da parte della Cina.
Le forme istituzionali del dominio coloniale inglese e francese
Nel XIX secolo, la dominazione europea in Asia, Africa e Australia assume forme istituzionali e organizzative quanto mai varie. La gamma delle possibili soluzioni va dai trattati conclusi con i potentati locali, che conservano un’indipendenza formale, all’imposizione di un protettorato e alla creazione di una vera e propria colonia, fino all’annessione pura e semplice delle nuove aree al territorio metropolitano.
L’impero inglese, di gran lunga il più vasto con più di 30 milioni di chilometri quadrati, si presenta anche come il più eterogeneo dal punto di vista dello status giuridico. Le colonie, popolate prevalentemente da Europei – tra le quali il Canada, l’Australia e la Nuova Zelanda – durante l’Ottocento acquisiscono una capacità di autogoverno sempre più ampia fino a diventare praticamente Stati indipendenti verso i primi anni del Novecento. Altre colonie hanno invece solo una certa autonomia amministrativa, ma sono governate direttamente da funzionari inviati da Londra. All’interno dell’impero britannico, l’India costituisce poi un caso a parte; alcune sue regioni, infatti, sono sottoposte al cosiddetto “governo diretto” di funzionari inglesi, altre al “governo indiretto” della Gran Bretagna attraverso principi indiani. Dopo il 1858, infine, il sovrano inglese si presenta come l’erede degli imperatori Moghul, legittimando la sua autorità e il suo dominio in India.
Nel corso dell’Ottocento, la Francia tenta di dare al suo impero coloniale una fisionomia istituzionale più uniforme. In linea di principio considera le sue colonie come parti del territorio nazionale, ma in realtà questo si traduce in un forte controllo politico e amministrativo del governo di Parigi sulle colonie, le cui rappresentanze parlamentari all’Assemblea nazionale rimangono quasi simboliche. Il fatto che le colonie francesi siano in teoria semplici dipartimenti d’oltremare ritarda la creazione di uno specifico ministero che viene finalmente istituito nel 1894.